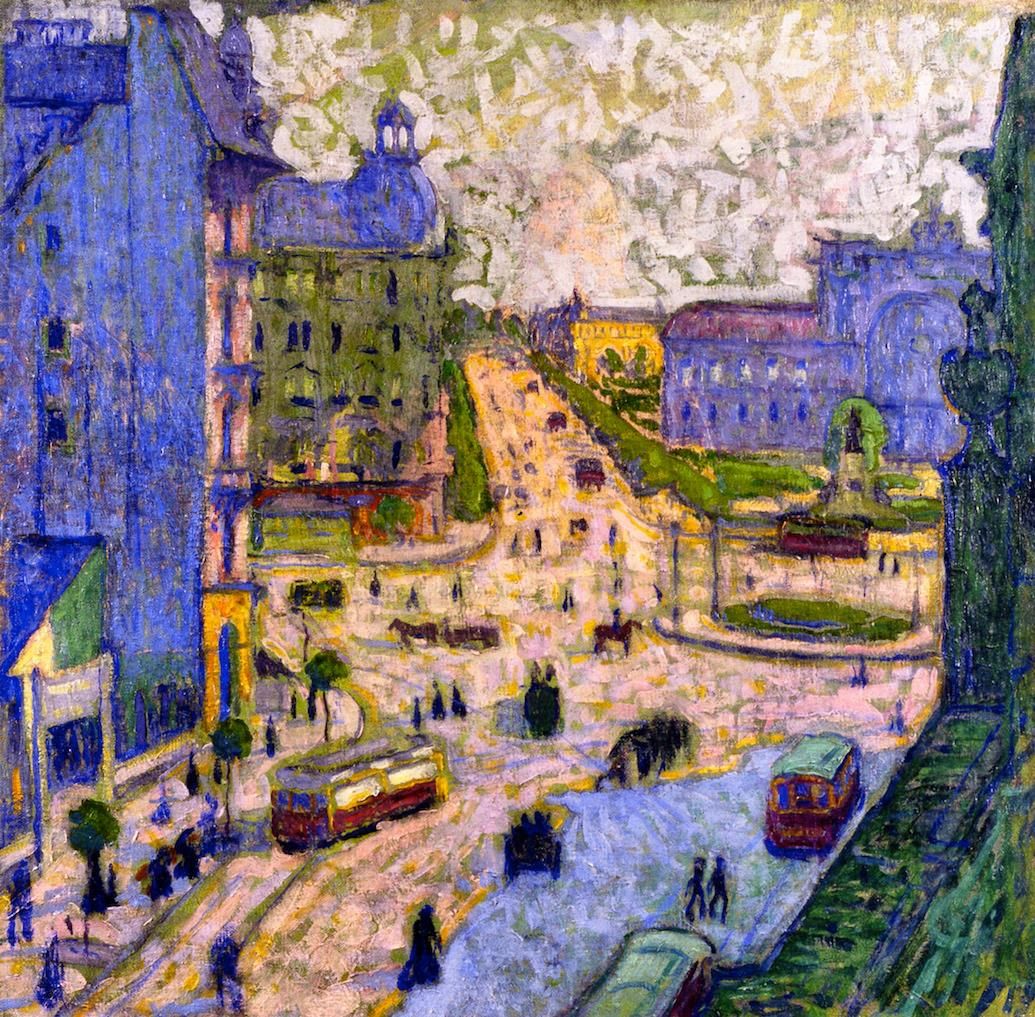In una delle non frequenti interviste da lei concesse, Ágota Kristóf – tentando di smentire le tinte eccessivamente cupe attribuite alla sua opera – sosteneva di aver scritto anche pièces teatrali «molto comiche», sebbene il suo fosse «uno humor un po’ nero». Se tracce evidenti di ilarità latitano patentemente sia da La chiave dell’ascensore, sia da L’ora grigia (angoscioso dittico sul tema del sacrificio femminile uscito per Einaudi nel 1999 a cura di Elisabetta Rasy), accenti più ameni sembrano invece trasparire dai dialoghi di John e Joe, delizioso duetto (tradotto l’anno scorso da Stefania Pico per Einaudi). Qui due clochard dall’umorismo laconico svelano con i loro maneggi farseschi la spietatezza venata di assurdo che il denaro introduce nelle relazioni umane. E se la tonalità di fondo appare più lieve del solito, resta tuttavia immutata quella nota che rende immediatamente riconoscibile il teatro di Kristóf, modellato su apologhi spiazzanti che potrebbero essere direttamente attinti ai sogni o agli incubi dell’autrice.
Obbedendo a procedimenti di condensazione e spostamento, i soggetti della rappresentazione si scambiano spesso di ruolo, gettano all’improvviso la maschera o assumono nuove sembianze, come a instillare un dubbio nello spettatore o a suggerire che i moventi reconditi che li determinano nel loro agire non possono manifestarsi sulla scena se non sotto il segno di una grottesca e alogica deformazione.
Composti in Svizzera
Atmosfere analoghe tornano anche nelle quattro pièces risalenti agli anni Settanta-Ottanta, riunite nel volumetto Il Mostro e altre storie (Edizioni Casagrande, pp. 136, € 18,00) curato da Marco Lodoli, che per Einaudi aveva già tradotto il romanzo breve Ieri. Composti dall’autrice magiara in francese, tra un turno in fabbrica e l’altro, nel tentativo di superare la dolorosa condizione di «analfabetismo» in cui l’avevano precipitata la fuga dall’Ungheria nel 1956 e la perdita della madrelingua, questi lapidari atti unici inscenano situazioni archetipe, scatenano conflitti elementari, quasi l’umanità stralunata di Kristóf abitasse un tempo mitico dove pulsioni, desideri e fobie si esprimono nella loro forma più incondizionata, senza orpelli culturali che valgano a contenerli. Qui l’asciuttezza della scena (pochi personaggi, scenografie assenti o ridotte all’osso) è il logico contraltare della saturazione claustrofobica che il testo riesce a produrre, tra tensioni irrisolvibili e paradossi multipli da cui lo spettatore non sa come evadere.
Nel Mostro, forse la più perfetta tra le quattro «storie», la scrittrice nata nel villaggio di Csikvánd nel 1935 e morta a Neuchâtel nel 2011 affronta il tema della dissidenza politica – un nodo per lei assai doloroso, approdato alla partenza dall’Ungheria voluta dal marito inviso al regime, la cui conseguenza fu, tra l’altro, la sottomissione a quell’esistenza alienante che avrebbe condotto per anni come operaia in una fabbrica di orologi. Uccidendo tutti i suoi concittadini, inclusi i suoi cari, l’intransigente Nob riesce a sconfiggere il Mostro puzzolente che ne aveva affatturato le menti, ma si ritroverà a regnare su un universo ormai vuoto. Se gli esseri umani per quieto vivere accondiscendono a prendere anche il fetore più disgustoso per un inebriante profumo, com’è possibile riportarli alla ragione senza trasformarsi nel loro più acerrimo nemico, sembra chiedersi l’autrice.
Altrove l’atemporalità sub specie aeternitatis al centro di trame come quella del Mostro lascia il posto a un’epoca indefinita, «persa nel futuro», in cui è fin troppo facile intravedere tracce del presente. In La strada la Terra è diventata un viluppo inestricabile di arterie asfaltate che non portano da nessuna parte se non ad altre strade, e l’esistenza di alberi, erba e fiori è ormai relegata all’ambito delle leggende non verificabili, tramandate da una generazione all’altra. Anche qui i personaggi di Kristóf tendono spasmodicamente verso un altrove di cui subodorano la presenza pur non essendone pienamente consapevoli, dal momento che quel mondo ideale si rivela solo a chi sa assumersi tutto il peso schiacciante della solitudine. Il miraggio di una azione collettiva che possa assicurare all’umanità la salvezza è infatti destinato a naufragare miseramente.
Verso il Grande quaderno
Il teatro di Kristóf raggiunge l’apice là dove rappresenta la contraddizione tragica tra destini condivisi e aspirazioni individuali. Meno riuscite appaiono le altre due pièces, L’epidemia e L’espiazione, dove la tensione drammatica si allenta e la forma si slabbra di fronte all’insorgenza di spunti che sembrano esigere una dimensione narrativa più ampia. Un passaggio che la scrittrice intraprenderà di lì a breve, cominciando a mettere su carta quei brevi testi ispirati ai suoi ricordi d’infanzia che diventeranno poi Il grande quaderno, serrato corpo a corpo con il francese in quanto lingua imposta dalle circostanze e definitivo congedo dalla condizione di «analfabeta».