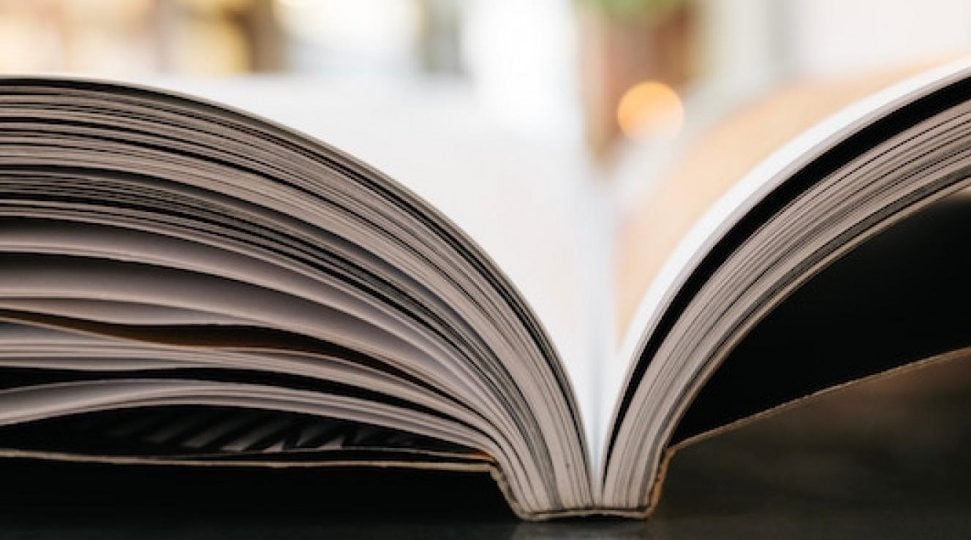«Il pendolo domina la stanza / leggi monotone / bisbigliano nella sera / nessuno può mutarle / nessuno penetrarle. / Oggi sono stato accusato / questa sera mi processeranno». Bastano le poche immagini che ne compongono l’incipit per riconoscere, con l’ingresso della prima persona sulla scena, il focus ritmico e semantico de «Il sogno del giudizio», poesia del 1931 di Gerrit Achterberg. Posto in apertura di Tebe (Joker Edizioni, a cura di Giorgio Faggin, pp.106, euro 16) antologia che attinge all’intera opera del poeta olandese, il componimento descrive frettolosamente un ambiente asettico in cui si consuma l’attesa di una sentenza, prestandosi a una doppia interpretazione.
Una lettura possibile sembra alludere a un prigioniero che, messo alle strette, esprime al lettore l’invocazione per una «sola parola di perdono / prima dell’alba, per una sola risposta che assolva». Ma è altrettanto plausibile che lo scritto abbia poco di contingente. Achterberg pare considerare la condanna come emessa da principio, da sempre, e va ripetendosela in mente in forma persecutoria, quasi intravedesse nell’esercizio poetico, nel gesto compositivo compiuto metodicamente, la sola possibilità di espiazione.
TRA GLI ANNI TRENTA e i Cinquanta del Novecento Gerrit Achterberg occupò un ruolo di spicco nel panorama nederlandofono per la difficile classificazione delle sue rime, irriducibili a nessuna tra le correnti dell’epoca. Pur partecipando di una generazione ancora legata a un’estetica romantico-religiosa, seppe influenzare il nascente mondo dell’espressionismo antiborghese che avrebbe segnato – a partire dal movimento Cobra – l’arte olandese del secondo dopoguerra; tra le peculiarità più vistose della sua poesia, una prolificità compositiva che spesso corrispose a una proliferazione di simboli, al bisogno di dare forma attraverso l’esteriorità della mitologia e della religione a una visionarietà penitente.
L’evento da cui molta critica ha preteso di far scaturire il complesso immaginario achterbergiano risale al 1937, quando l’uomo, allora poco più che trentenne, uccise a colpi di revolver la proprietaria dell’appartamento dove viveva a Utrecht, e ne ferì gravemente la figlia. Dopo essersi costituito gli fu diagnosticato un grave disturbo psicotico e fu internato presso diversi istituti psichiatrici. Non c’è dubbio che Achterberg andò costruendo e per certi versi arricchendo il proprio apparato simbolico di pari passo al progressivo affiorare – in forma immaginifica, talvolta quasi plastica – della sua colpevolezza, come si evince dalla scissione del soggetto lirico tra un io poetico, ancorato a determinati codici metrici e formali, e un io supplice, che si rivolge all’aldilà nel tentativo di rievocare la donna a cui ha tolto la vita.
NELLA RAPPRESENTAZIONE l’anima conserva un residuo di fattezze umane, viene incontro a metà del guado (il corpo «piegato come una fiamma verso l’acqua bianca»), si lascia riconoscere dal poeta/inseguitore così come dal lettore; eppure, nel dato effettivo del verso, essa si affaccia via via più faticosamente, perde, nel progredire della scrittura che quasi si frantuma, la sua corporeità e diventa suono, voce, gioco di corrispondenze grafiche.
La critica ha di volta in volta associato la scenografia di Tebe alla conoscenza o a un eventuale interesse di Achterberg verso le tradizioni più disparate – Grecia e antico Egitto; Orfeo e Euridice, Ecate, Osiride. Riferimenti riconoscibili ma che forse non basta individuare senza considerare attraverso quale esperienza, biografica o culturale, il mito viene attinto e attivato, ovvero, nel caso di Achterberg, alla luce del suo profondo retaggio protestante; al mito di Tebe va inoltre riconosciuta un’accezione peculiare, poiché, come si evince nei versi di «Diaspora», il territorio ultramondano è ripercorso a ritroso ben oltre l’immagine diafana del defunto, e fin dove la parola poetica riesce ad attingere: «Tu sei ineffabile; tuttavia / il mio volere ha sguinzagliato / guerrieri luccicanti con lo scopo di calcolarti: / un borbottio incomprensibile / finirà per coincidere / con il nostro conoscersi / nell’abisso del linguaggio. / Da quella somma nascerà il tuo corpo / perché intendo convocare /tutte le molecole / che erano disperse. Tutte».
NEGLI ANNI delle avanguardie Achterberg fu esponente di un simbolismo interpretato entro codici metrici ancora piuttosto assodati. Oltre che referenti semantici, il computo di «tutte le molecole», la «somma», sono indice di contorni compositivi delimitati. Siamo lontani dagli accenti più euforici dell’espressionismo; manca ogni postura iniziatica, si resta tutto sommato nel terreno dell’apollineo.
C’è da chiedersi allora in che senso questo poeta radicato nella tradizione del verso ottocentesco seppe incontrare il nuovo gusto sperimentale. Nella visione poetica Achterberg non ripone l’aspettativa di sovvertire il reale ma di dissolverlo, risucchiandolo fin dentro la dimensione del limbo, con una metrica balbettante che quasi sfocia nel silenzio; al sonetto classico, sua forma prediletta, Achterberg applica piccole variazioni metriche o di accento solo in parte apprezzabili nella traduzione in verso libero, la quale esplicita il racconto, gli slanci meditativi, ma forse non rende giustizia della dialettica tra forma e contenuto che in Achterberg è così cruciale. Il poeta olandese assegna alla scrittura il compito ambivalente di aggiudicargli una pubblica approvazione, di riabilitarlo, e insieme di agire al di là di ogni convalida, di materializzare essa stessa un flatus vocis, un filo inconsistente ma diretto tra la realtà e un orizzonte trascendente.