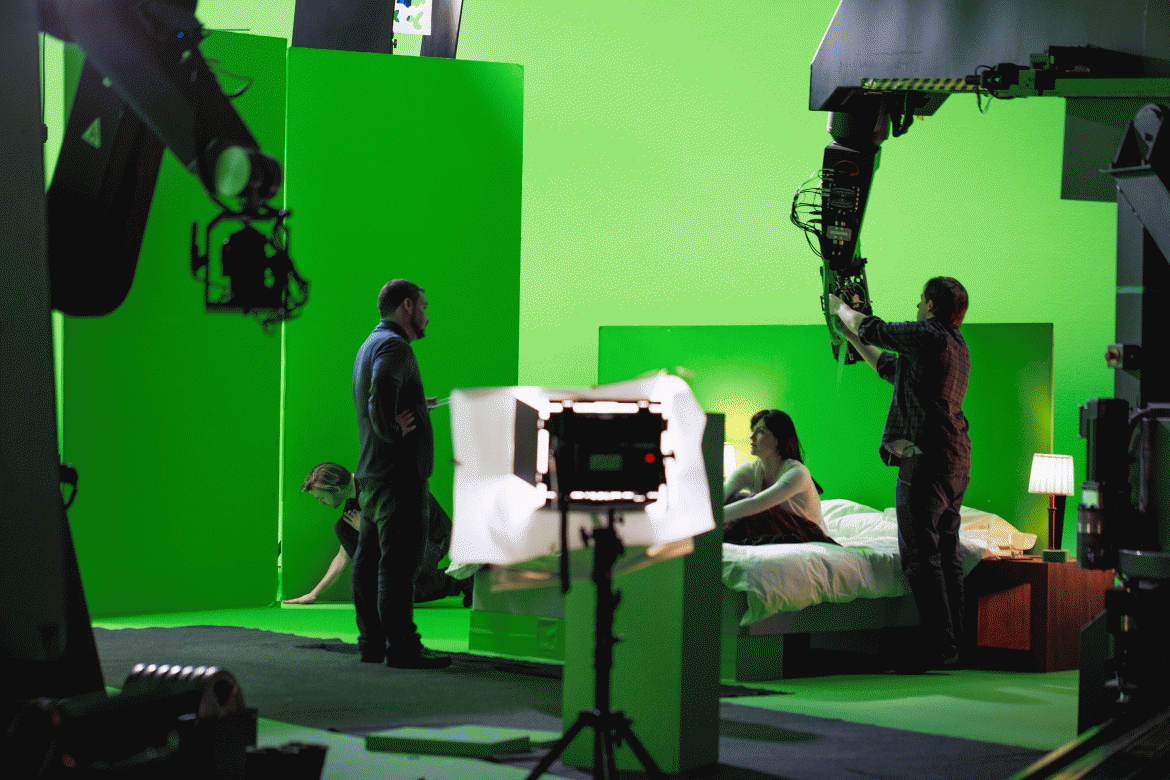Victor Perez, spagnolo andaluso, a 38 anni è considerato uno dei più quotati creatori di effetti visivi cinematografici a livello mondiale, chiamato da aziende prestigiose e per film di altissimo tasso spettacolare. Ha cominciato a lavorare a 127 di Danny Boyle, poi ha collaborato (sempre come libero professionista) per l’Industrial Light and Magic di George Lucas, per l’Imax, per Harry Potter e i doni della morte, I pirati dei Caraibi – Oltre i confini del mare, The Bourne Legacy, Il cavaliere oscuro. Il ritorno di Christopher Nolan, Rogue One – A Star Wars Story. Ha anche diretto due corti: Another Love e Echo, due lavori che utilizzano magnificamente gli effetti visivi (non speciali, perché lui si risente). In Italia, dove risiede, tra le altre cose, ha lavorato per Il ragazzo invisibile. Seconda generazione di Gabriele Salvatores. Ma prima di arrivare alla consacrazione professionale Victor ha una storia che merita di essere raccontata. Da lui stesso.
LA STORIA
“Sono nato e cresciuto in campagna, mio padre lavorava in un’azienda che produceva olio, selezionava le olive come chimico. Gli amici che avevo abitavano lontano. Quando non ero a scuola dovevo inventarmi qualcosa per giocare. Mi è sempre piaciuto inventare storie, ma la molla è stato mio fratello, di quindici anni più grande. Avevo sei anni quando mi ha detto “facciamo che si muovono i tuoi pupazzi”, e mi ha mostrato quel che al cinema si chiama stop motion animation. Lui faceva delle foto, le sviluppava e le stampava, poi le faceva scorrere sotto il dito e io “si stanno muovendo…”. Quando ha preso una telecamera supervhs me la lasciava usare. Io non avevo altro da fare, scattavo a singoli fotogrammi, poi rivedevo, scattavo e rivedevo e un giorno ho detto a mio fratello “guarda che ho fatto” e ha visto un Transformer che saltava. Era stupito. E mi ha detto “ti insegno anche altre cose”.
Lui mi portava al cinema a vedere Guerre stellari, i miei genitori erano un po’ anzianotti, ho sempre detto di avere avuto due coppie di genitori, mio fratello e mia sorella che ha 17 anni più di me e i miei veri genitori che quasi quasi facevano i nonni. Quando mio fratello ha comprato un computer, un Amiga, me lo lasciava usare, come diceva sempre mia madre a me piaceva giocare con le luci e i bottoni, e il computer è diventato il mio modo di giocare. Fino a quando mio fratello mi ha detto “dammi una mano a ritoccare queste foto. Devi fare così, così e così”. Avevo tempo, non mi piaceva studiare, anche se a scuola andavo bene, così aiutavo mio fratello, che mi pagava, molto poco… ma ero contento. Quando avevo sedici anni facevo le mie foto, usavo Photoshop, che conoscevo dalla versione 2.5, la prima uscita per Windows. Un giorno sono andato a stamparle in paese, in una tipografia digitale, una delle prime. E il proprietario mi ha detto “bellissime, chi le ha fatte?”, “le ho fatte io”, “no, guarda che so che non è facile, chi le ha fatte?”, “io”. “Ah sì, e come lo hai fatto?”, “così, così e così…”, lui è rimasto e mi ha detto “ma tu sai usare Photoshop?”, “dalla prima versione”, facevo il fighetto.
E mi ha chiesto se dopo la scuola ero interessato a lavorare come apprendista. Erano in tre, erano gli albori della stampa digitale, loro non avevano esperienza, io invece sì e da apprendista ho finito per insegnare come usare Photoshop. In realtà avrei voluto fare l’attore. Quando siamo andati a vivere a Lucena, vicino a Cordoba, mi sono iscritto alla scuola comunale di teatro. Mio padre mi diceva “se vuoi fare i soldi devi diventare dentista, se vuoi fare quel che ti fa felice, vai”. Finita la scuola ho cominciato a studiare arte drammatica e a fare un po’ di conti con la realtà. Se voglio fare i miei spettacoletti devo anche lavorare per fare dei soldini. E questo mi ha fatto entrare in un meccanismo sanissimo: vuoi soldi? Lavora. Che è la vita. Quindi ho fatto l’attore anche con compagnie professionali, ma non ho mai lasciato la grafica e i montaggi di effetti, anzi potevo lavorare con il mio computer da casa. La vita dell’attore non è facile e ho cominciato a cercare più lavoro di grafica che, all’inizio del duemila era una professione piuttosto nuova, e mi pagavano anche bene. Il mio hobby era molto più “profittabile”.
Un giorno sono venuto in Italia, a Reggio Emilia, per studiare il teatro di maschere e ho cominciato a maturare una cura per l’estetica, per la possibilità di mescolare fotografie, animazione e tutto quello che poteva permettere di raccontare una storia. Stavo imparando a farle a studiarne i dettagli per l’espressione. Ecco, lì è scattato qualcosa perché potevo applicare questa cosa strana che sapevo fare con il computer al racconto delle storie. Potevo disegnare le mie maschere, potevo distorcerle e creare altre cose.
Durante il corso ho conosciuto Chiara, mia moglie. Per un anno e mezzo solo telefono, io in Spagna, lei in Italia, sono arrivato a spendere 1500 euro in un mese. Era l’unico modo per parlarci, poi un giorno ci siamo detti “o tu vieni qua o io vengo là, così non ha senso”. Lei voleva la Spagna, io l’Italia. Ho vinto, non so per quale motivo. E ho dovuto di nuovo fare i conti con la realtà. Non potevo fare l’attore con l’accento, ma non era neanche quello, è che non volevo più fare l’attore per un motivo che ho scoperto anni dopo. Voglio essere giudicato per quel che faccio e non per l’aspetto fisico. Ho fatto un po’ di commedia dell’arte, con la compagna di Antonio Fava. Ma non avevo prospettive. Chiuso. Ora mi metto a raccontare storie e ho cominciato a cercare scuole di cinema. Questo è buffo, le cercavo ovunque, finché ne ho trovata una fondata da Vittorio Storaro. Mamma mia, io adoro, Apocalypse Now. Dove sta questa scuola? A trecento metri da casa mia, perché nel frattempo io e Chiara ci eravamo trasferiti a L’Aquila. Ci sono andato a piedi, il corso era già iniziato, erano tutti giovani, per loro a ventisei anni ero vecchio.
Un professore, Steve Natanson, mi diceva “guarda che sei bravo con il compositing”, e io “cosa è il compositing?”. E lui “è quello che stai facendo mettendo insieme immagini di diversa provenienza”. Facevo compositing senza sapere cosa fosse. Lui allora mi ha raccomandato presso una scuola negli Stati Uniti, ci sono andato. Laggiù solo alla fine ho capito che il mio insegnante era l’eminenza mondiale del compositing. Ho vinto un premio come miglior studente dell’anno, ma ero avvantaggiato perché avevo esperienza, e mi sono perfezionato. Potevo fare cinema. Avevo cominciato e impostare l’episodio pilota per una serie tv, avevo anche trovato un finanziatore, un pazzo che aveva visto i miei lavori e ci credeva. Dovevamo firmare il contratto il 6 aprile 2009.
La sera precedente erano venuti a trovarmi degli amici di Trento che avevo conosciuto negli Usa, e con questi amici si diceva a cena ma sì, magari andiamo tutti a Londra a studiare gli effetti. La cena era fatta da me, spagnola, tortilla, patate … Chiara era a letto con l’influenza. Alla fine la cucina era un disastro, prima di andare a dormire mi sono detto “se Chiara si sveglia e la vede mi ammazza”. Mentre pulivo mi dicevo “se accetto questo contratto farò il regista”. Quando studiavo cinema mi dicevano che il meglio era già stato fatto. Ma io sentivo che non era vero, come in tutte le arti si può fare di più. Finito di pulire e di mettere a posto mi sono messo il pigiama, Chiara stava dormendo, non me lo scordo, mi sono seduto a letto e mi sembrava come se qualcuno mi stesse premendo forte, è andata via la luce, e il poco che sono riuscito a vedere era l’edificio di fronte che è entrato dalla finestra facendola esplodere, sapevo che era quell’edificio perché era entrato dalla finestra anche il lampione.
Non vedevo bene, ero in stato di shock, ricordo bene il sapore della polvere. Eravamo abituati alle scosse, ma non sei mai pronto a pensare che casa tua possa cadere, ho preso Chiara che diceva “aspetta, aspetta”, perché ci dicevano di metterci sotto lo stipite in caso di terremoto. Io ho detto “se devo morire muoio fuori”, abbiamo percorso il corridoio, nel salone i mobili si muovevano come fossero su una nave, la porta era incastrata, l’ho aperta facendo forza, siamo usciti. I miei due amici di Trento erano nel bed and breakfast al piano terra del condominio di fronte. Non ho mai voluto fare l’eroe, ma istintivamente e incoscientemente sono entrato e ho visto la porta chiusa e incastrata che avrebbe dovuto aprirsi da dentro. Ho dato un colpo da fuori, e loro sono usciti. Chiara avrebbe voluto rientrare e in quel momento di polvere e vento hanno ricominciato a cadere sassi e altro. Di fronte c’era un giardinetto e siamo andati lì, così non poteva caderci addosso più nulla.
C’era una polvere pazzesca, non si poteva né vedere, né respirare bene, non sapevamo cosa fosse successo, ma si sentivano le urla delle persone. Proprio di fianco a casa nostra un edificio di quattro piani era collassato, poi abbiamo saputo che vi erano morte 27 persone. Sentivamo le urla e l’impotenza di non potere fare niente. Eravamo in pigiama a tre gradi, sotto shock e non sapevamo cosa fare, anche perché il terremoto continuava. Infreddoliti. Al mattino, dopo quattro ore, è arrivato l’esercito che ci ha portato in un campo di raccolta. Io non avevo il cellulare, che avevo sentito suonare al mattino sotto le macerie, era mia sorella che chiamava. Quella notte di terrore è un evento che ti cambia la vita. Ci hanno portati a Montesilvano, alloggiandoci in un albergo, ma nessuno era pronto.
C’era da mangiare perché gli alberghi l’avevano, ma non c’erano vestiti, era difficile trovare acqua eravamo 70mila persone da ricollocare. Erano scene da Walking Dead perché l’unica cosa che vedevi a Montesilvano, nonostante il freddo, erano persone che giravano per le strade in pigiama, o ferme, sotto shock. Perdi tutti i rifermenti. Io per esempio ero in pigiama e mi ero registrato solo con il nome e quando mia sorella era riuscita a mettersi in contatto con mia suocera le disse che risultavo disperso. Ho dovuto chiamare per avvisare che ero vivo e mi volevano ammazzare loro, mi dicevano che ero stato irresponsabile. Era tutto davvero surreale. Coi miei primi vestiti, che poi erano una tuta, ho scoperto davvero il valore delle cose. Stavo andando a una postazione a prendere dell’acqua e una signora da un balcone del primo piano mi ha detto “ragazzo, vieni, vieni”. Io sono salito “guarda io ho dei vestiti di mio marito che ormai è morto. Te li posso dare?”.
“Signora se lei mi avesse offerto un milione di euro non sarei stato più felice”. Ho provato anche delle scarpe, per tre giorni ho avuto ai piedi delle ciabatte bianche da donna. Mi sono messo a piangere. Seduto, davanti a quella signora, ero nervoso, emozionato al punto che non le ho neanche chiesto come si chiamasse. Mi sono messo la tuta, mi ha dato anche vestiti per mia moglie, quel gesto per me è stato qualcosa di troppo grande. Mi aveva regalato dignità. E allora mi sono detto, non so come fare, ma lo farò: io, a qualsiasi costo, devo realizzare i miei sogni, partendo da zero, anzi da un pigiama che, tra l’altro, ho ancora e mi piace pensare che un giorno questo era tutto quel che possedevo.
Poi ho sentito per telefono un amico spagnolo attore che mi diceva “eri disperso, ma ora stai bene? Come ti posso aiutare?”. Era tutto surreale… non avevo più niente. E mi ha detto “ce l’hai un computer?”. “No, non ho niente”. Una settimana dopo in albergo mi è arrivato l’ultimo modello di MacBook della Apple, che costa l’iradiddio. Si erano messi d’accordo gli attori del film di Antonio Banderas El camino de los ingleses, dove avevo lavorato come attore. Così, saputo quel che mi era successo mi avevano comprato il computer. Per me quel computer è come quando i supereroi acquisiscono un potere. Mi dava la possibilità di fare.
In una stanzetta d’albergo a Montesilvano, con Chiara, ho deciso che dovevo fare qualcosa. Con quel computer, una notte, mi sono registrato un video in cui avevo in mano una scopa, poi su una panchina ho cominciato a fare prove per farla diventare una spada laser come in Guerre stellari. Era anche la cosa migliore che potessi fare, darmi qualcosa da fare in quella situazione di crisi. Senza dirmi niente si erano messi d’accordo tutti i miei amici che si erano chiamati tra loro, anche persone che non conoscevo, avevano fatto una colletta, guidati da Valerio, l’amico di Trento. Alla fine avevano messo insieme più di diciassettemila euro.
Persone che neppure mi conoscevano… L’ho scoperto quando mi hanno fatto una festa a sorpresa e mi hanno detto “non è tantissimo, ma con questo ti puoi pagare un corso a Londra, magari già sai quello che ti possono insegnare, ma è una scuola con tanti contatti che è quello che ti serve”. Ero commosso e ho detto “non posso permettermi di dirvi di no”. In meno di un mese ero a Londra. Il corso costava tanto e vivere lì era carissimo. Valerio aveva un’amica a Londra, che aveva anche contribuito alla colletta, disposta a ospitarmi. Lei aveva una stanza l’altra era soggiorno e cucina insieme, mi ha messo lì un lettino. Per nove mesi ho vissuto nella cucina di una psicologa brasiliana a Londra. L’unica cosa che facevo era andare a scuola e tornare a casa a lavorare, a studiare fino a tardi la notte.
Dormivo poco, due tre ore per notte, lei era spaventata mi diceva “tu hai un problema serio” e io “no, ho solo perso la casa e tutto il resto, devo fare andare bene quello che sto facendo, non ho altra scelta”. L’unica regola che mi ero dato era di non raccontare a nessuno del terremoto. Non volevo che venisse dato lavoro al “poverino”. Tre giorni dopo la fine del corso, non parlavo neanche bene l’inglese, mi ha chiamato uno studio, che oggi è molto importante, per farmi lavorare. Ho cominciato con una cosettina, però in meno di tre mesi ero diventato il direttore tecnico dello studio. Io consideravo quelli di Londra come dei giganti, i migliori al mondo, in realtà li avevo mitizzati. Aveva ragione la brasiliana a dire che avevo un problema (ride). Ma quando finalmente ho potuto fare paragoni con il mondo reale mi sono accorto che effettivamente io ormai appartenevo a quel mondo, ero ossessionato che non sapessero della mia esistenza, se non sono bravo è un discorso ma devono sapere che esisto.
Così ho cominciato a pubblicare articoli su riviste specializzate, costruivo strumenti e poi quando è cambiato il software io ero lì, un po’ è botta di culo, un po’ è essere pronti, ho potuto avvantaggiarmi perché usavo il nuovo software da un po’ di tempo, perché Steve Wright negli Stati Uniti ci aveva detto “date un occhiata a questo perché tra qualche anno…” E io l’avevo studiato. Avevo anche avuto la faccia tosta quando ero a Londra di andare dalla compagnia che faceva il software e dire “vorrei usarlo, mi date una licenza gratis”, costava seimila euro. Me l’hanno data per un anno. Per inciso quel software ha vinto l’oscar tecnologico e io sono l’ambasciatore, perché sono stato davvero tra i primi a usarlo.