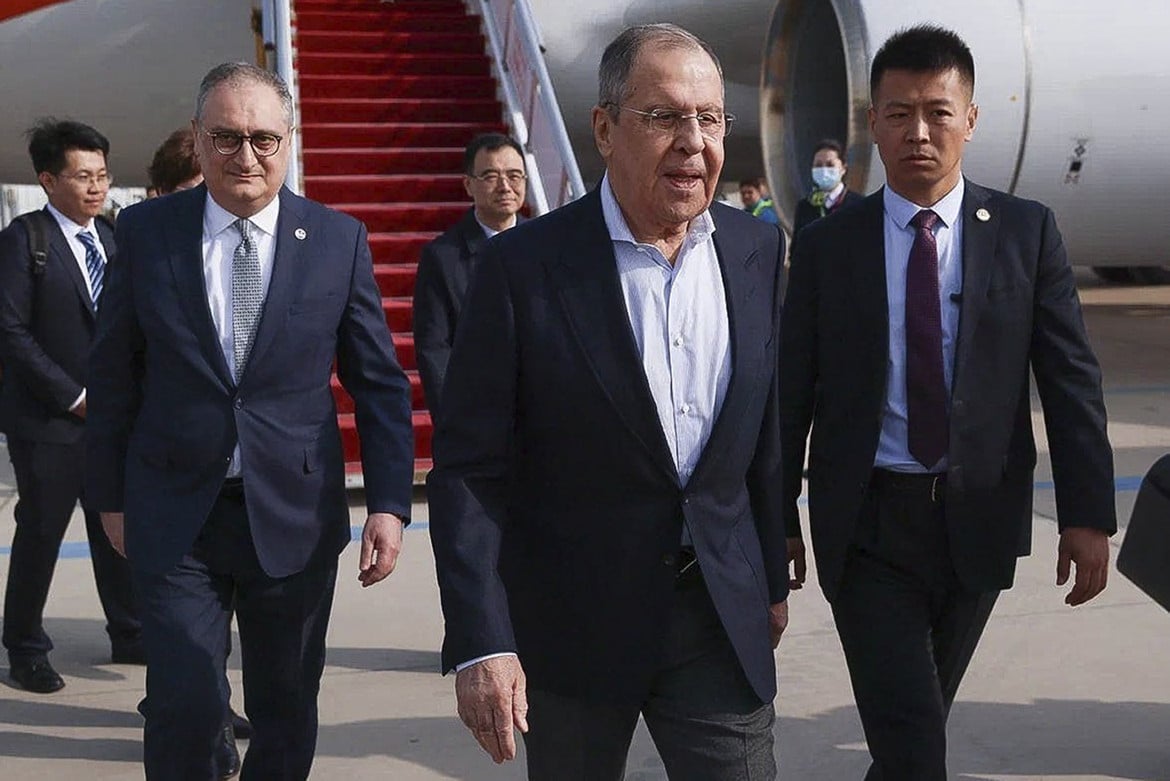A tre giorni dalla fine ufficiosa della tregua siriana, la comunità internazionale prova a tenere in piedi il cessate il fuoco. Lo fa a parole («Non è finita», ha ribadito martedì il segretario di Stato Usa Kerry) per essere smentita dai fatti. I siriani rimangono ai margini, i grandi esclusi da trattative gestite fuori e da uno scambio di accuse che è la routine.
Ieri sul tavolo è tornato il bombardamento statunitense delle truppe governative a Deir Ezzor, catalogato come «errore» da Washington. La coalizione internazionale anti-Isis, sabato, non rispondeva al telefono: la linea rossa – remiscenza da Guerra Fredda – aperta per evitare simili incidenti non ha funzionato. Mezz’ora dopo i primi raid Mosca ha telefonato al centro operativo della coalizione, ma l’ufficiale all’altro capo del telefono non sapeva bene cosa rispondere.
Alla seconda telefonata, i russi hanno trovato il responsabile e denunciato il bombardamento, fa sapere il colonnello Thomas, portavoce del Comando Centrale Usa. Subito l’operazione è stata cancellata, ma i 62 soldati siriani erano già morti.
Sul fronte opposto nel mirino c’è la distruzione di 18 camion di aiuti umanitari della Mezzaluna Rossa. I russi insistono: sono stati colpiti da un incendio, non da un raid. Mosca ha presentato il video girato da un drone: un camioncino con sopra un mortaio corre lungo il convoglio, usando gli aiuti umanitari come scudo per muoversi verso il centro di Aleppo.
Gli statunitensi ribattono: le conclusioni delle indagini preliminari indicano che si è trattato di un bombardamento, di Mosca o di Damasco, gli unici a trovarsi nella posizione giusta per colpire. Le informazioni su cui l’inchiesta si fonda non provengono, però, da fonti americane sul campo, ma dalle opposizioni al governo di Damasco.
E qui si riapre l’eterna questione dell’affidabilità dei gruppi di “ribelli” operativi sul terreno: Washington non vuole mandare il suo esercito ed è quindi costretta a trovare soluzioni diverse, ovvero scovare qualcuno che faccia il lavoro ma che ovviamente porta poi avanti la propria agenda.
Gli Usa si avvalgono anche dei propri droni di sorveglianza che lunedì al momento dell’attacco al convoglio hanno registrato la presenza di due Su-24 russi, ma non il lancio di bombe. Ma – dicono gli Usa – erano là, per cui non possono che essere stati loro. Mosca usa la stessa logica: sul luogo dell’attacco c’era anche un drone statunitense, dice l’esercito di Putin, e si è allontanato solo mezz’ora dopo.
In tale contesto le violazioni si sprecano, una dietro l’altra: ieri è stata la volta di un altro ospedale, nel villaggio di Khan Tuman vicino ad Aleppo, quattro medici uccisi in quello che gli Usa indentificano come un raid russo. Anche in questo caso Mosca reagisce: «Non ci sono crateri e i danni non sono del tipo causato da bombe sganciate dal cielo», scrive in un comunicato il Ministero della Difesa russo.
Ma nella bolgia siriana non è più possibile distinguere tra responsabili: ogni soggetto si macchia dei propri crimini, ognuno mantiene la popolazione ostaggio della guerra. Non ci sono buoni e cattivi, al contrario di quanto detto dal segretario generale dell’Onu Ban Ki-moon che all’Assemblea Generale di martedì ha imputato al presidente Assad il più alto numero di vittime civili, dimenticando di citare quelle provocate dalle opposizioni e quelle attribuibili ai poteri regionali, dal Golfo alla Turchia, incendiari della crisi dal 2011 con armi, denaro, miliziani e frontiere aperte.
Le contraddizioni delle strategie straniere esplodono in tutta la loro gravità facendo della Siria il campo di battaglia per altri conflitti: quella occulta tra super potenze, Stati Uniti in difesa e Russia in attacco; quella regionale tra asse sciita e asse sunnita; quella palese tra Turchia e Kurdistan. La prima impedisce di trovare un accordo reale nascondendosi proprio dietro la ricerca del dialogo; la seconda mantiene alto il livello della tensione bellica con il costante rifornimento di armi ad entrambe le parti; la terza tiene in ostaggio il solo vero prodotto politico uscito dalla crisi, il confederalismo democratico di Rojava.
E, elemento non certo meno importante, svela l’incoerenza di Washington che da una parte manda i marines a sostegno dell’operazione di terra turca e dall’altra continua a sostenere le Ypg kurde. Lo stesso Obama ha parlato nei giorni scorsi dell’intenzione di armare direttamente i combattenti kurdi impegnati contro lo Stato Islamico, mentre vengono colpiti dall’alleato di ferro turco.