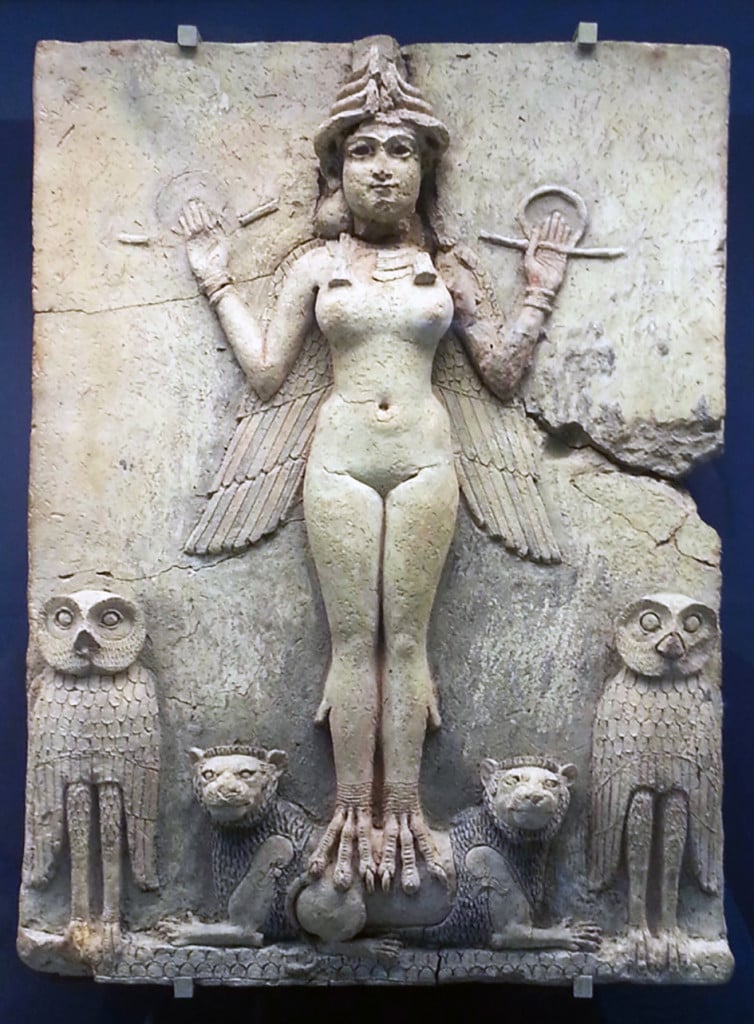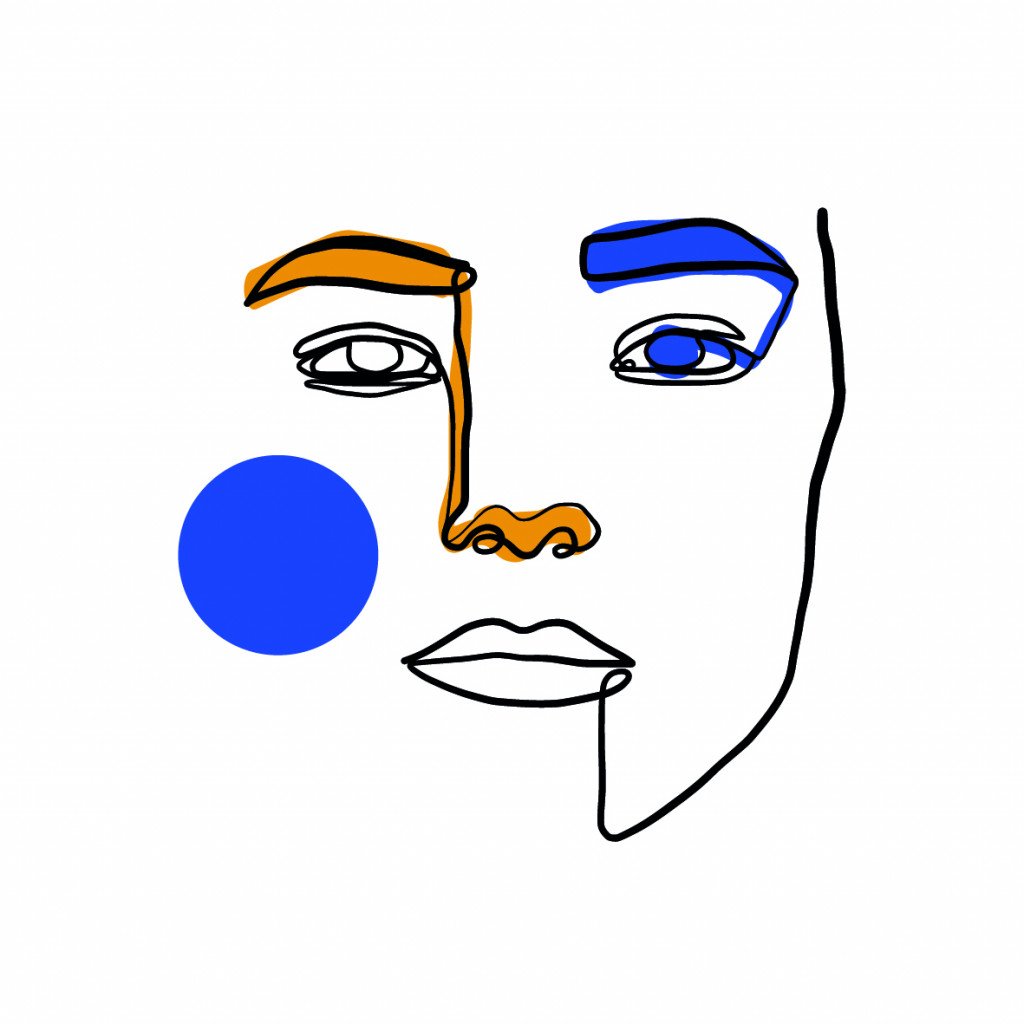Sono un’impiegata baciata dalla quarantena. I miei attrezzi di lavoro sono il computer e il software. La macchina a cui sono incatenata è lo schermo luminoso che prosciuga ogni giorno i miei occhi fino all’ultima lacrima. I gesti che mi logorano coinvolgono polsi, spalle, cervicale. Ma soprattutto gli occhi. Sono una di quelle che scrivono le pagine web, trattano le fatture, organizzano i dati, vi servono come clienti o come utenti di servizi, spostano conoscenza da qui a là. Lavoro di cura intellettuale che richiede attenzione, precisione, presenza; creatività il giusto, meglio non esagerare perché facilmente inceppa le organizzazioni ed è faticosa da gestire nel meccanismo della gerarchia. Perlopiù si chiede, alla schiera delle impiegate e della manovalanza intellettuale, di non uscire dal seminato e di non essere troppo reattive. Risolvere i problemi, sì; porne, no. La nostra forma si esplichi nell’area concessa, in cambio di un contratto di lavoro. Poiché si ritene doveroso lasciare la politica fuori dalla stanza, il politico che inevitabilmente si manifesta in ogni rapporto viene rimosso, silenziato.
Ogni giorno, nella vita normale, alla solita ora esco di casa. Percorro le stesse strade, scendo le stesse scale, varco gli stessi tornielli, saluto gli stessi alberi. Giorno dopo giorno ho sperimentato le varianti di percorso ed ognuno, alla fine, è diventato la solita strada. Dal programma di marcia giornaliero cerco sempre di ritagliare un pezzetto da dedicare a sperimentazioni intellettuali o interazioni collettive. Questi pezzetti che allungano la «to do list» quotidiana sono eccitanti quanto faticose escursioni su strade alternative. Più sentieri, che strade vere e proprie. Ogni sentiero apre una diversa possibilità di me, ogni sentiero è l’evidenza di ciò che non potrò diventare, l’affaccio su uno scenario possibile che si estende in un orizzonte indefinito. Il sentiero mi invita ad inoltrarmi ma il giorno finisce, la notte mi casca sugli occhi, e il mattino dopo dovrò tornare a rifare lo stesso tragitto, scendere le stesse strade, attraversare gli stessi tornielli e salutare gli stessi alberi. Ogni metro conquistato su uno dei sentieri esplorativi è fatica e devozione, amore ricambiato nel tempo strappato all’ordinaria amministrazione. La quarantena ha dilatato questo tempo, lo ha espanso e improvvisamente mi sono sentita ricca e sensata.
Sono una di quelle tante migliaia, decine, centinaia di migliaia che ogni giorno raggiunge la sua casella nell’ingranaggio. Per tanti anni ho vissuto il mio lavoro come nel più tradizionale e romantico dei sogni d’amore, proiettando su di esso aspettative irrealizzabili. Come quando ti prendi una cotta per uno/una che era tale solo nella tua fantasia, piangendo e strappandoti i capelli ogni volta che lui/lei non ti corrisponde come vorresti. L’avessi presa subito per quello che era, questa relazione, e cioè un matrimonio di interesse, sarebbe stato più semplice darla via: la propria intelligenza, a condizioni non scelte. Oggi ogni forma di passione è spenta e la meta da conquistare non è il più, ma il meno. Meno energie e meno aspettative, uguale meno delusioni. Raggiungo ogni giorno il mio posto di lavoro come una moglie il letto coniugale in un matrimonio, appunto, d’interesse. Nell’indifferenza dei gesti provo una leggera nausea di me stessa e del vivere. Ho bisogno di lui, del lavoro, perché ho bisogno dei suoi soldi. Ma lui mi annoia e non riesco più a definire il senso di quello che sto facendo, che utilità abbia. Una parola sembra poter descrivere al meglio questo scenario. Una parola ottocentesca, riscoperta nel Novecento e oggi, pare, quasi dimenticata: alienazione. Colpisce come l’alienazione possa riprodursi anche negli ambienti di lavoro meno direttamente coinvolti dal modo di produzione capitalistico, persino in quelli che apparentemente lo mettono in discussione.
La quarantena mi ha baciato come un’amante clandestina. La quarantena, con lo scompiglio delle vite e di ogni ordine prestabilito e con l’obbligo di stare in casa, ha aperto una parentesi di libertà nella mia alienazione. Il virus ha incarnato il mio desiderio di scompigliare tutto. Anzi peggio, e lo dico con vergogna per chi ha sofferto e perso la vita, il virus ha incarnato la mia rabbia e la mia furia distruttiva. Mi ha consentito di guardare con il binocolo i luoghi dove esercito la mia prostituzione e le relazioni malate che li invischiano. Osservandoli così, da una certa lontananza, i grovigli emotivi che ammorbano le mie notti diventano oggetti entomologici. Gli uffici sono luoghi di invidia, frustrazione, potere. Quando mi lamento, le amiche scuotono la testa: «è solo un lavoro», dicono, «non devi investirci emotivamente», «sei fortunata». Lo dicono giustamente, perché ci sono forme di alienazione molto più degradanti, faticose, e sgradevoli della mia. Il mio lavoro è il meglio che si possa immaginare per tutta una serie di motivi. Alla fine chi ha potere su di me non mi chiede molto: solo di essere sorridente e complice mentre eseguo i miei compiti; non pretendere di far parte di una squadra di lavoro, cioè di un gruppo di pari. Ho la busta paga, i permessi, le ferie, le malattie. L’importante è fare il minor rumore possibile ed è proprio questo il dettaglio che mi fa saltare i nervi. Un dettaglio irrilevante, davvero, rispetto alla mole di sfruttamento, degradazione e annichilimento della vita che caratterizza il sistema economico neoliberista.
La quarantena è venuta a tirarmi fuori dalla gabbia, mi ha regalato il tempo e la primavera. In questi mesi ho vissuto come una regina, grata di tutto, inspirando ogni attimo con una consapevolezza vivissima, come se mi fosse scivolato via uno strato di pelle. Grata dell’odore della mia casa e della luce calda che rimbalza dalla finestra, grata di avere tempo per contemplare l’arrivo della primavera, del tempo da dedicare alle persone care pure se in videochiamata, grata per i pasti regolari in compagnia del mio compagno, per il mio modesto attivismo da operaia della militanza. Il mio bilocale è stato una reggia, i pochi metri quadri del mio balcone un lussureggiante giardino. La quarantena ha aperto un varco temporale imprevisto, come in un romanzo di fantascienza o in un’esperienza psichedelica. Grata di non avere bambini o anziani da accudire. Grata di ricevere lo stipendio! Ho lavorato da casa, certo, ma con le attività ferme anche i ritmi del lavoro si sono dilatati. Ho continuato a svolgere le solite attività, ma è cambiato il modo. Ho avuto più tempo per scrivere, per leggere, per fare esercizio fisico, per meditare. Per ascoltare il canto del merlo. Poiché il ritmo della giornata si è modificato, la mia mente si è modificata. La staticità indotta è stata un’occasione per rallentare la cavalcata dei pensieri, forse anche un’illusione che, se la normalità era il problema, non saremmo tornate alla normalità.
***
* L’autrice di questa testimonianza ci chiede di pubblicare sotto pseudonimo