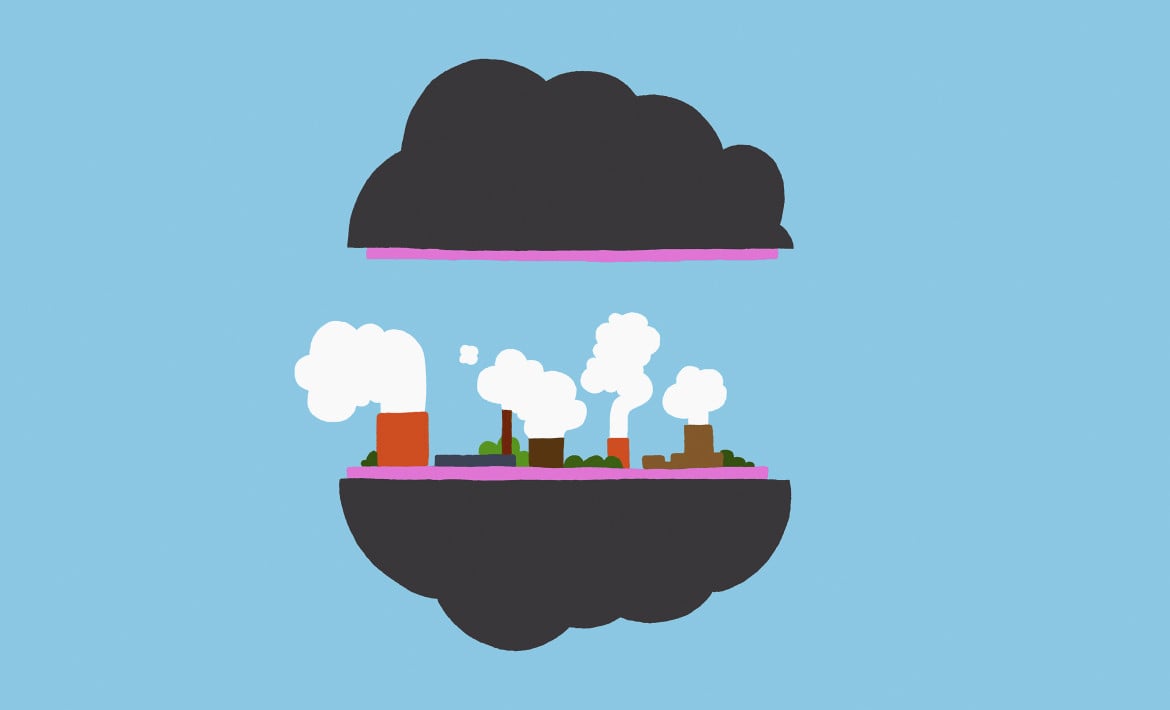L’hanno presentato come un «passo storico». In realtà è una piccola pezza su una grande piaga.
Con l’approvazione del disegno di legge delega sul contrasto alla povertà e l’introduzione del Reddito d’inclusione (REI) – è stato detto – anche l’Italia alla fine si dota di uno «strumento universalistico» con cui affrontare l’enorme esercito di poveri cresciuto in modo esponenziale in questi anni.
Eravamo rimasti gli ultimi in Europa a esserne privi, dopo che anche la Grecia se ne è dotata stanziando a febbraio un fondo da un miliardo di euro per circa 400.000 famiglie. Ora avremmo rimediato. Ma è davvero così?
In realtà la misura «universalistica» non è.
Copre a malapena un quarto della «povertà assoluta» (1.582.000 famiglie, per un totale di 4.598.000 individui). Cioè i più poveri dei più poveri tra i poveri: le famiglie più sofferenti (quelle con minori a carico o particolari disabilità) tra i «poveri assoluti» (quelli che non hanno il minimo indispensabile per una vita decorosa: mangiare tutti i giorni, coprirsi, curarsi…) i quali a loro volta sono circa la metà dei cittadini in condizione di «povertà relativa» (più di 8 milioni e mezzo), e un quarto dei «deprivati» (circa 19 milioni). La cifra messa a disposizione del provvedimento per il 2017 è modesta: all’incirca un miliardo a cui aggiungere altri 600 milioni con accorpamenti di altre voci (risorse sottratte alle non autosufficienze, agli asili nido, alle politiche sociali, il cui fondo è stato ridotto a un ventesimo rispetto al 2005…) e qualcosa dall’Europa. Essa dovrebbe permettere agli «aventi diritto» un’integrazione del reddito fino a un massimo di 480 Euro mensili, a fronte di una serie di contropartite (la dimostrazione dei «mezzi» tramite Isee, l’accettazione di un percorso di inserimento lavorativo, un patto sottoscritto di buona condotta…).
Condizioni tutte da definire con i decreti attuativi da parte del governo. Ed è qui che appunto il «passo storico» si rivela in realtà il solito espediente della «politica-annuncio».
Perché è noto che nel campo delle politiche di contrasto alla povertà quasi tutto si gioca sui meccanismi di assegnazione e sulle forme di governance della gestione.
Come si definiranno i «bisognosi»? La condizione di «povertà assoluta» non ha un’unica soglia, al di sotto della quale si è definiti tali. L’Istat ne ha predisposte 342 in base all’area territoriale (Nord, Centro, Sud), alla dimensione dei comune di residenza (aree metropolitane, comuni medi, comuni piccoli), alle dimensioni della famiglia. Vanno da un massimo di 1982 euro mensili per famiglie grandi in metropoli del nord a 490 euro per coppie di pensionati in piccoli centri del sud. Chi valuterà e come gli «aventi diritto», con quali metodi di comparazione? E poi: si richiede l’accettazione di un percorso di inserimento lavorativo come se tutti i poveri assoluti fossero disoccupati. Ma l’11,7% delle famiglie con persona di riferimento occupata come operaio è in condizione di povertà assoluta! Infine: quali uffici elaboreranno le graduatorie, gestiranno i fondi, verificheranno sul territorio? Tutti i precedenti tentativi ed esperimenti in questo campo si sono arenati su queste secche.
Per non parlare della spinosa questione degli «stranieri»: tra le famiglie «miste» la povertà assoluta raggiunge il livello record del 14,1%. Tra quelle composte da «soli stranieri» censite dall’Istat addirittura il 28,3%.
È prevedibile fin da ora la canea che solleverà la questione tra gli xenofobi nostrani e la possibilità di discriminazioni odiose, se questa materia incandescente verrà regolata con la negligenza e l’opacità che si annuncia.