Riassumere la storia di Delhi e della sua gente in un’opera di «non-fiction» di oltre 450 pagine è un’impresa che nessuno, sano di mente e frenato dall’umiltà, dovrebbe intraprendere sperando nel successo. Meno che meno, come invece fa Rana Dasgupta nel suo Delhi – appena uscito per Feltrinelli, tradotto da Silvia Rota Sperti – pensando che le somme tirate in una galoppata superficiale attraverso la Storia della capitale indiana possano valere come modello, o meglio monito, per il resto delle «megalopoli in via di sviluppo» mondiali.
Dasgupta sconta terribilmente un handicap di partenza che, perlomeno, ha la bontà di dichiarare: lo scrittore non è di Delhi, è figlio di indiani della diaspora e fino al 2000 ha vissuto tra il Regno Unito e gli Stati Uniti. Raggiunge e racconta Delhi, quindi, con la perizia di un acuto osservatore senza fare sufficientemente i conti – né prima, evidentemente, né durante la stesura del libro – con l’impedimento di essere «esterno», un elemento estraneo, sia come formazione sia linguisticamente (Dasgupta ammette di non parlare hindi), al contesto mostruoso che si prefigge di raccontare e che, giustamente, descrive in tutta la sua mostruosità.
Il tema, la metamorfosi orripilante che Delhi ha subìto negli ultimi 150 anni causata dall’invasione del Capitale, viene sviscerato dando voce a personaggi che l’autore vorrebbe esemplari della popolazione di Delhi, che al momento si aggira ufficiosamente intorno alle 20 milioni di persone. In realtà, si tratta quasi sempre di punjabi di vario sesso ed età, tutti accomunati dalla piattezza con cui si muovono tra pagine che affrontano, spesso speditamente, una gamma di argomenti monstre della Delhi contemporanea: la rivoluzione dell’high tech, la violenza contro le donne, la corruzione, le catastrofi ambientali, le connivenze tra imprenditoria e potere politico (entrambi criminali), le tensioni intercomunitarie, le condizioni dei senzatetto e degli «slum», il trauma irrisolto della Partizione del 1947, i pogrom contro la comunità sikh del 1984, la perdita delle tradizioni islamiche, il sorgere dei ghetti di lusso nella periferia della città.

Lo spettacolo di varia imbecillità arricchita che Dasgupta offre in «Delhi» è vivido e genuino e mostra al lettore la radiografia di una classe dirigente ributtante, meschina ed egoista, che incidentalmente tiene le redini del secondo paese più popoloso al mondo; di un miracolo economico annunciato come nazionale, ma relegato a minoranze infime – e ricchissime – del tessuto sociale di Delhi.
Con Delhi, Rana Dasgupta ci mostra una megalopoli che sembra aver raggiunto il punto di non ritorno dalla dannazione. Nella città di Dasgupta, tutto va ed è destinato ad andare irrimediabilmente a rotoli, in una spirale di corruzione e sistematico abbandono delle classi disagiate, incoraggiata dalla fame di «roba» che corrode le classi dirigenti.
Il sospetto è che Dasgupta sia caduto nella tentazione comune a molti «expat» residenti a Delhi, scambiando la percezione superficiale e personale dell’orrore delhese al quale si viene esposti non appena si costruisce una parvenza di vita sociale metropolitana – serate intere a discettare di «soluzioni finali» nella comodità delle residenze della Delhi bene, magari incoraggiati dall’alcol – con la comprensione totale e ponderata del contesto che ci circonda. Che la maggioranza degli «expat», e si teme anche Dasgupta, evidentemente non conosce e forse non conoscerà mai, in mancanza di strumenti linguistici e culturali che ci lasciano fuori dall’India che non fa notizia, la vera «classe media»: troppo poco povera per compatirla, troppo poco ricca per invidiarla o disprezzarla.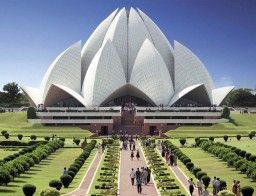
Una parte di Delhi che magari, come racconta Dasgupta, mostra sul lunotto posteriore dell’auto l’effige del dio Ram con arco e frecce. Ma non lo fa perché il protagonista del Ramayana è un amante immaturo e bellicoso, come sostiene Dasgupta tracciando un parallelo caratteriale col prototipo del cittadino di Delhi: forse, meno poeticamente, perché Ram è tra le icone della destra indiana anti-musulmana, eventualità che l’autore ritiene di non considerare nella sua trattazione epico-antropologica.
Infine, una nota sulla buona traduzione di Rota Sperti, che ridà la fluidità della prosa di Dasgupta ma che, a tratti, incappa in sviste semantico-culturali svelando una conoscenza superficiale del paese. Come nel caso dei disperati dello slum che chiudono un baracchino del té per aprire un «albergo»; quando «hotel», in India e in hindi, indica anche una bettolaccia dove si serve cibo a buon mercato.

