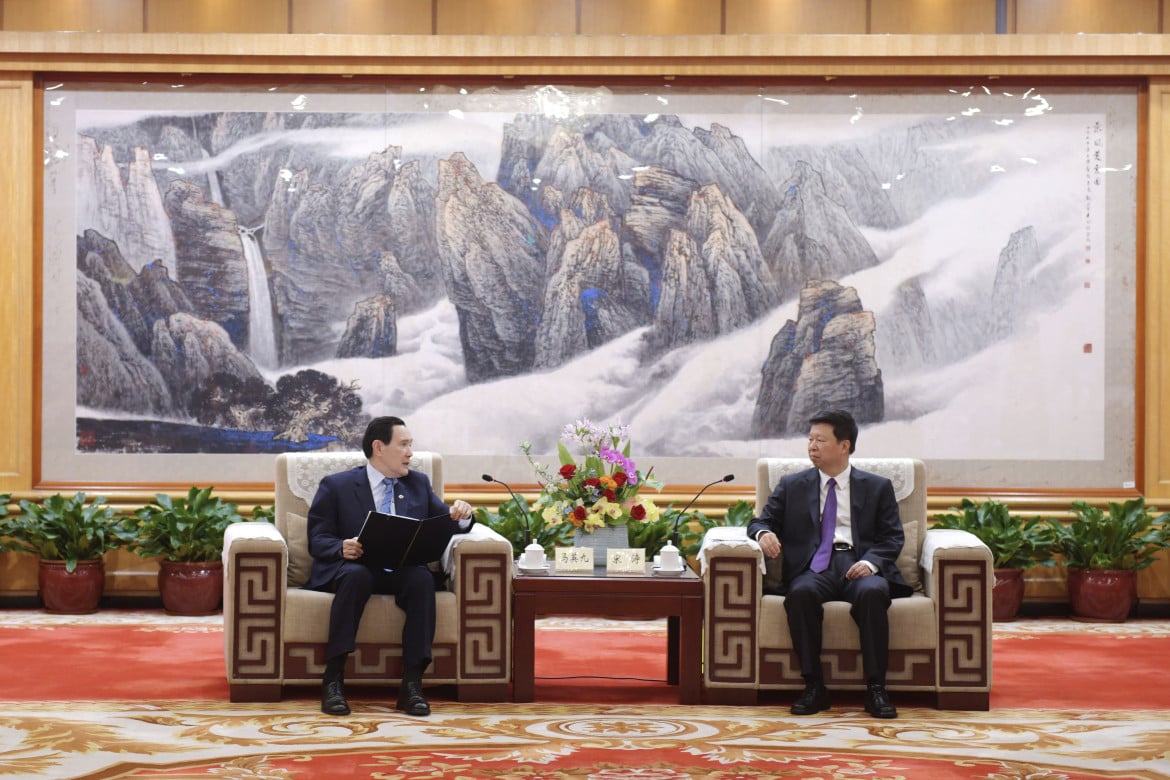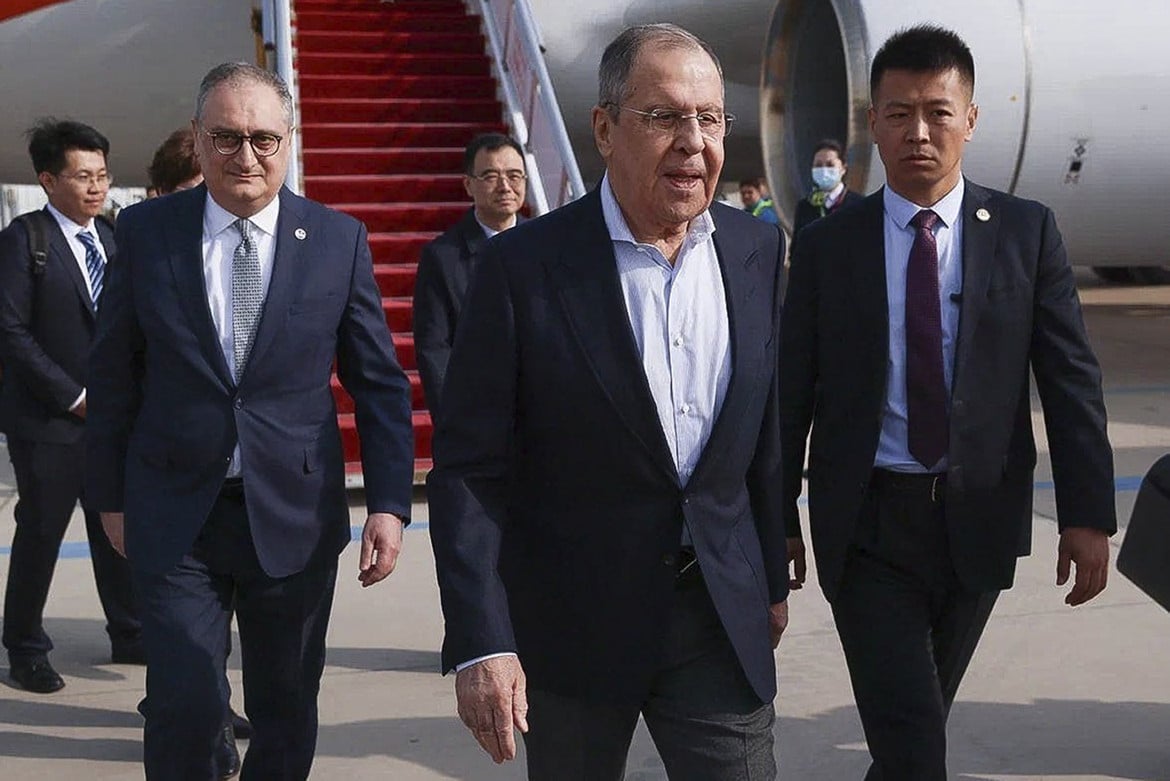Una folata di vento lanciata sulla carta
Le religioni del Libro e del deserto raccontano che la nostra prima dimora è stata un giardino. Nel luogo protetto che Dio ha affidato ad Adamo, la natura ordinata è separata dal suo volto selvaggio; tracciare il limite consente di sfuggire al terrore dell’indefinito, e la «definizione» (horos) è la risposta alla domanda greca per eccellenza, «che cos’è?».
Il pensiero dell’Occidente ha concepito anche il paesaggio a partire dall’orizzonte (horismos) che lo delimita, mancandone così il tratto peculiare, l’apertura e la lontananza. I dizionari definiscono «paesaggio» la parte di un paese che la natura presenta allo sguardo. La nozione resta così impigliata nella «piega» che la filosofia ha assunto fin dall’origine: la natura rimane separata dall’osservatore proprio in virtù del primato della vista che, fra i cinque sensi, mette a distanza, fissa l’oggetto e lo prepara alla determinazione che ne esprime l’essenza.
Restiamo eredi inconsapevoli di categorie che ci rendono difficile vivere di paesaggio, come propone François Jullien nel nuovo capitolo del confronto fra la cultura dell’Occidente e la tradizione della Cina: Vivere di paesaggio o l’impensato della ragione (a cura di Francesco Marsciani, Mimesis, pp. 168, euro 16.00).
A lungo relegato a sfondo scenografico, il paesaggio in pittura da noi ha conquistato autonomia nella stagione da Friedrich e di Turner fino al Cézanne in lotta contro la variabilità indomabile della montagna Sainte Victoire.
Alla ricerca della coerenza
La cultura cinese ha tralasciato la rappresentazione delle figure umane (e del nudo in cui la nostra classicità ha visto rifulgere il Bello ideale) per volgersi fin dall’inizio al paesaggio. Non è nella riproduzione della forma umana che il pittore manifesta la sua abilità; è facile la resa di oggetti che hanno una forma costante – uomini, animali, case –, quel che ha valore è esprimere la «coerenza interna» che regola il processo del mondo, scandito dall’alternanza delle fasi yin e yang. Lo slancio del pennello, come una folata di vento sulla carta, insuffla nell’inchiostro il soffio-energia (qi) con cui l’universo intero respira e si rinnova. Il paesaggio prediletto è quello in cui le cose sfumano progressivamente; il pittore dipinge l’indistinto della transizione, il momento in cui la presenza viene attraversata dall’assenza e lo sguardo va e viene tra il c’è e il non c’è, tra opposti che si richiamano. Picasso potrà dire, rivolgendosi al «cinese» Malraux, che proprio i Cinesi hanno compreso quel che conta davvero in pittura: non imitare la vita, ma lavorare come lei.
Perché si produca l’effetto di paesaggio occorre che si instauri una messa in tensione fra polarità, suggerisce l’ideogramma cinese per paesaggio che equivale a montagne-acque. Non basta armonizzare una varietà di oggetti distinti; quello che conta non è la differenza, ma lo scarto che mette in tensione gli opposti, il verticale della montagna e l’orizzontale delle acque, la solidità e il flusso, lo stabile e il variabile.
La riva è paesaggio, non il mare aperto, la montagna è paesaggio, non la cima innevata. Se non agiscono differenziali tutto resta in stanca, atono; se non si delineano linee di forza che animano il paesaggio, chi contempla non ha di che «nutrire la vita». A differenza del pittore occidentale che privilegia un punto di vista unico e statico, esterno all’immagine che raffigura, lo sguardo del pittore cinese è mobile, si lascia assorbire fino a passeggiare nel paesaggio. Quanto viene percepito non è più estraneo e indifferente, si carica di una componente affettiva; un paesaggio è come un archetto, diceva Stendhal, fa risuonare qualcosa nella nostra interiorità, non tanto un suono distinto quanto una vibrazione, una risonanza che rinnova la connivenza, la tacita comunicazione fra l’io e il mondo.
Nella poesia e nella pittura cinese la materialità tende già da sé allo spirituale; l’aura, di cui Benjamin lamentava la perdita e il cui etimo greco indica la brezza, l’atmosfera, è nei vapori che si levano dal fondo delle valli e sfumano le forme del rilievo. Lo spirito del paesaggio che il pittore cinese mira a cogliere non si carica del significato mistico-religioso che l’Occidente ha cercato nella lontananza come apertura verso l’aldilà. Invece della scelta a favore del meta – l’oltre della meta-fisica – la Cina presta attenzione al tra, alla condizione sospesa fra essere e non-essere, alla vaghezza che induce alla rêverie. Il lontano è lo svolgersi di un processo continuo che dalla prossimità si perde nell’indistinto, nel vago e nel nebuloso, ovvero ciò che il nostro pensiero delle distinzioni ha relegato alla poesia. La grafia primitiva dell’ideogramma qi, il soffio-energia, il flusso che attraversa e anima la realtà, evoca la forma di una nuvola, poi il vapore che si innalza dal riso che cuoce. La spiritualità cinese emana dai corpi, ne è la quintessenza: non appartiene a un piano trascendente, si sprigiona a partire dal sensibile.
Oltre ciò che impedisce l’esistenza
Lo sprigionamento, nozione che la nostra logica della determinazione ha lasciato ai margini, diventa chiave per comprendere l’emergere di quella che Jullien definisce Una seconda vita, titolo del suo ultimo libro appena edito da Feltrinelli, (traduzione di Paolo Poli, pp. 96, euro 12,00). Lo sprigionamento non è l’uscita dalla Caverna, il momento in cui finalmente abbiamo dissipato le tenebre, non è neppure la conversione; è l’esito di un processo in cui, per trasformazioni silenziose e inavvertite, si acquisisce lucidità grazie al succedersi delle esperienze. La seconda vita si emancipa da quanto in precedenza l’aveva bloccata, espande il suo comportamento; anche il vivere si fa più sottile, si decanta e si alleggerisce, accede all’esistenza, cioè comincia a «tenersi fuori» (ex-sistere) da ciò che ne ostruiva il fluire.