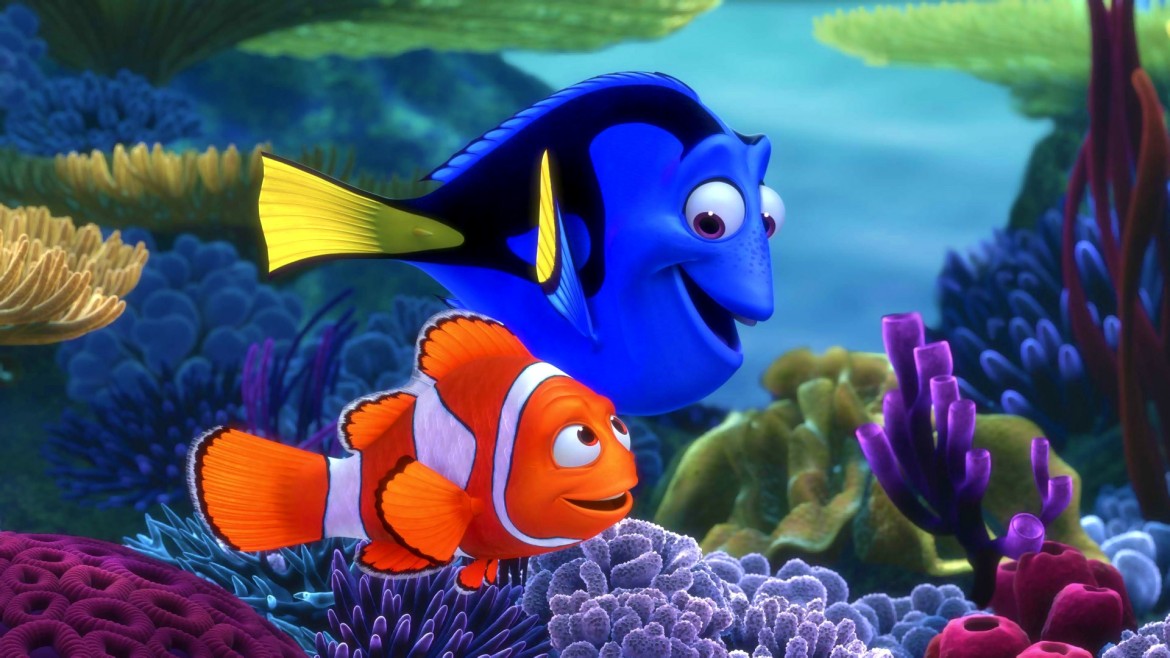Ci sono voluti tredici anni, il magnifico WALL-E e una (immeritatamente) disastrosa avventura fantasy fuori dalla Pixar (John Carter), perché Andrew Stanton si rituffasse nel blu infinito da cui era stato temporaneamente sottratto Nemo, il piccolo pesce pagliaccio con una pinna deformata e un papà iperprotettivo protagonista del capolavoro acquatico della factory di John Lasseter. Da allora, la Pixar ha intensificato il suo output produttivo e allargato la pratica dei sequel aldilà del tempio sacro dei Toy Story. I risultati di questo adeguamento alla logica delle franchise – Cars 2 e Monster University – non sono stati all’altezza dei film originali e dell’inventiva Pixar in generale.
Rispetto a quei due film, Alla ricerca di Dory sembra senz’altro una scommessa più personale da parte di Stanton che, nella cerchia ristretta di Lasseter, è considerato il più bravo in fatto di «storie». Anche qui, il centro dell’azione è una rescue operation. Solo che questa volta ad essere smarrita è Dory, il pesce chirurgo del primo film, loquacissima (in inglese è la voce di Ellen DeGeneres) e spensierata per forza, perché completamente priva di memoria a breve termine.
«Ho sempre visto Dory come un personaggio tragico», ha detto Stanton al Los Angeles Times; «che passa la maggior parte del tempo a vagare per l’oceano, scaricata da, e scaricando a sua volta, altri pesci, perseguitata da un inalienabile senso di abbandono». In effetti, questo senso di scardinamento continuo, di solitudine profonda e dello sforzo frenetico per ovviarla ancorano emotivamente il film, più delle complicate sequenze d’azione teen age-friendly, a cui, purtroppo, ormai già da qualche film, ricorre anche la Pixar, a scapito della magia del dettaglio e dell’intelligenza contemplativa dei suoi film più belli.
Stanton usa il flash back per inquadrare la storia: Dory è minuscola, poco più di una palla blu vivo, striata di giallo, con enormi occhi viola, e un’espressione di eterna costernazione, perché si dimentica tutto, nonostante i giochi pazienti con cui i sui preoccupati genitori cercano di attivarle la memoria. Perdersi è questione di un attimo, risucchiata in un labirinto di alghe impassibili, la vediamo crescere, chiedendo disperatamente a pesci sconosciuti la strada per tornare in un posto che già non si ricorda più. Cut, e un anno dopo, Dory si è stabilita presso la Grande barriera corallina con Nemo e papà Marvin, quando il passaggio migratorio di un branco di mante canterine riattiva il desiderio di ritrovare la sua famiglia.
Quando lei dilegua insieme al branco, Nemo e Marvin si mettono sulle sue tracce. Il resto del film si svolge in un parco marino, ispirato al National Marine Sanctuary di Monterey, e da cui Stanton trae un’inesauribile serie di gag e set – tubi, vasche, secchielli, piscine, grate, brocche trasparenti. E una serie di nuovi personaggi: un polpo mimetico con sette tentacoli che sogna di finire rinchiuso in un acquario di Cleveland, una balena che vede male e che va a sbattere da tutte le parti, un beluga, due leoni marini e un uccello dagli occhi rosso sangue. Come Dory, e Nemo, hanno anche loro qualcosa che non funzione benissimo e, come loro, hanno imparato a trasformare quella differenza in una marcia in più. Se, alla sua uscita in sala, WALL-E sembrava un’ eco delle corsa alla presidenza di Obama, Alla ricerca di Dory si può facilmente intendere come un manifesto contro l’America dei pregiudizi predicata da Donald Trump.
Di avventura in avventura; di blu, in verde, in grigio, in marrone trasparente (da tredici anni a questa parte la texture dell’animazione sottomarina è molto più varia e il disegno dei personaggi più foto realistico) – Stanton arriva al finale. E se ne concede addirittura due. Uno «quieto», tutto emozione, in una profondità oscura in cui appena si distinguono le forme dei pesci. L’altro esplosivo, tutto azione, con una fuga in camion e un esercito di otarie. L’ «Ohhhhh» rapito con cui un’intera sala, piena zeppa di bambini, ha salutato il primo dei due, rende omaggio alla vera magia della Pixar.