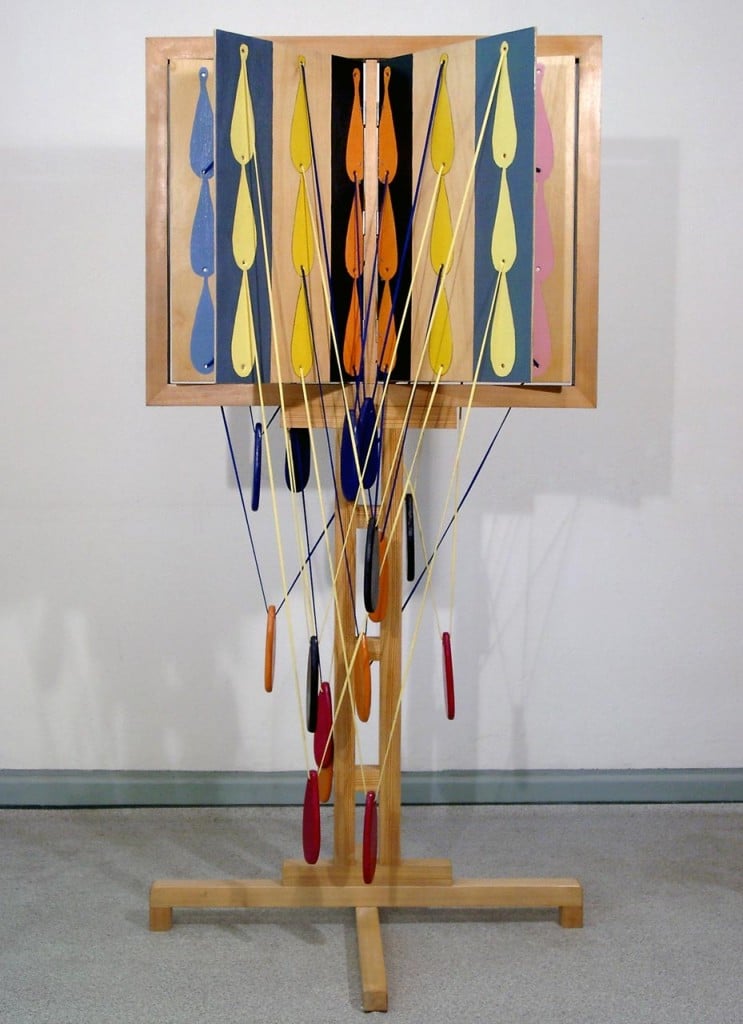Nel romanzo di Michael Crichton Sol levante, il protagonista, vissuto a lungo in Giappone, spiega così la differenza tra statunitensi e giapponesi: «Di fronte a un problema noi cerchiamo un colpevole, loro una soluzione». Ed è proprio la ricerca del colpevole che ha dominato il dibattito sui risultati delle prove Invalsi 2019.
Di soluzioni poche, e quelle poche sembrano poggiare su osservazioni ed esperienze personali, certamente utili e interessanti, ma non sufficienti per affrontare un settore centrale come l’istruzione. Eppure si sa: chi non è andato a scuola, chi non ha avuto un figlio o un nipote a scuola, chi non ha almeno presentato un libro in una scuola! Insomma, sembra prevalere la posizione di Michael Gove, sostenitore della Brexit, che nella campagna referendaria ha dichiarato: «La Gran Bretagna ne ha abbastanza degli esperti».
Tuttavia, a qualche settimana dai titoli allarmati dei primi giorni, è forse possibile proporre qualche riflessione più meditata sui risultati relativi all’italiano. Innanzi tutto, le prove Invalsi sono dei test che valutano solo alcune competenze e non l’efficienza globale della scuola italiana. Anche il migliore dei test è solo uno strumento diagnostico limitato: è sbagliato scientificamente e didatticamente derivare da questi risultati informazioni diverse. Ciò va detto non per rassicurarci e minimizzare la portata dei risultati, ma per condurre un processo corretto di diagnosi.
I test Invalsi sono, diciamo così, l’equivalente delle analisi del sangue per la glicemia, quindi un test diagnostico utile, ma non sufficiente per valutare la salute di un essere umano. Questo uso scorretto dei risultati Invalsi va contrastato non solo sui giornali, ma soprattutto all’interno del mondo della scuola: i test Invalsi non devono essere usati per valutare l’efficienza delle scuole, come i risultati dei test sulla glicemia non servono a valutare l’efficienza degli ospedali.
DETTO QUESTO partiamo da alcuni dati. Quelli dell’Istat 2015 mostrano che mai prima d’ora l’italiano è stato così diffuso come lingua parlata e scritta e mai prima d’ora è stato lingua nativa della maggioranza dei bambini nati in questo paese (con e senza cittadinanza). L’italiano non è più una lingua straniera, ma al contrario è finalmente diventata la lingua più usata dagli italiani.
Bisogna tuttavia tenere a mente due fattori. In primo luogo, i dialetti rimangono presenti accanto all’italiano come lingua materna o lingua seconda per un 30% degli italiani. In secondo luogo, la piena apertura della scuola repubblicana a tutti e tutte senza distinzione ha introdotto nella scuola un forte plurilinguismo, oggi aumentato anche dalle lingue di nuova immigrazione. Insomma, da un lato, l’italiano usato da tutti e tutte si è inevitabilmente allontanato da quello colto dell’élite, dall’altro, è aumentato il numero delle lingue presenti nelle classi.
Dobbiamo dunque essere contenti che l’italiano sia la lingua finalmente condivisa dalla maggior parte degli italiani perché il possesso della lingua nazionale è un passo necessario per una piena cittadinanza. Nello stesso tempo quando una lingua diventa espressione di tutta la nazione, essa si apre a nuovi apporti, viene a contatto con altri idiomi che si usano nella vita familiare e sociale, dialetti o altre lingue, e con tutte le forme nuove più o meno mescidate e multimodali di comunicazione.
DI FRONTE a questi grandi cambiamenti, la scuola ha reagito in modo non uniforme e soprattutto non ci sono state riforme unitarie, che cioè prevedessero un percorso consequenziale e ragionato dalla Scuola dell’infanzia alla fine della Scuola secondaria superiore. L’unica riforma in questa direzione l’aveva concepita il ministro Tullio De Mauro, ma, com’è noto, non andò in porto.
Gli insegnanti hanno quindi continuato a lavorare in un contenitore dalla struttura e dimensioni invariate, e gli aggiustamenti sono stati sempre locali e non sempre per il meglio. È mancata da parte dei dirigenti politici una progettualità complessiva che coinvolgesse i docenti stessi in un processo di riflessione e riconsiderazione dei bisogni linguistici delle nuove generazioni.
Eppure molti insegnanti hanno aderito con entusiasmo e dedizione a iniziative importanti, che hanno creato vasti movimenti di rinnovamento. Sotto la spinta di Tullio De Mauro nel 1975, sono state scritte Le dieci Tesi per l’educazione linguistica democratica (http://giscel.it), che rappresentano ancora oggi un documento programmatico necessario per un cambio di prospettiva. In primo luogo, si parla di educare all’uso delle lingue e non solo di insegnare l’italiano: ciò comporta accettare e includere nel processo di crescita delle competenze linguistiche dei ragazzi tutto il loro mondo linguistico. Non escludere la loro lingua nativa, se è diversa dall’italiano, come se fosse un male da estirpare, ma partire dagli usi noti per arrivare ai meno noti.
Per raggiungere questo obiettivo non bastano le regole di una grammatica, anche ben fatta, bisogna avere la pazienza di partire proprio dall’uso corrente di chi abbiamo in classe per spiegare le differenze che derivano dai vari elementi della situazione comunicativa. E da esse si arriva pian piano a come le lingue grammaticalizzano, cioè rendono sistemiche, l’espressione di queste differenze, per esempio attraverso l’uso di pronomi diversi, di modi e tempi diversi, di lessico diverso ecc. Il percorso è complesso, ma necessario, se al pieno possesso dell’italiano formale e colto vogliamo portare, e certamente vogliamo, anche chi non ha mai avuto alcuna esperienza di questi usi: chi non ha un libro in casa, chi non ha genitori istruiti, chi non è madrelingua italiano. Questo percorso ha il merito di mettere al centro del processo di crescita i ragazzi. Partire dalle loro competenze linguistiche, che possono sembrare sgangherate, ma sono pur sempre funzionali al loro universo comunicativo, per farli approdare a usi produttivi e ricettivi complessi è la strada da seguire. Considerare le nuove generazioni come un insieme di analfabeti telefonino-dipendenti, rimpiangere bacchettate e lezioni ex cathedra sono nostalgie di chi giovane non è più.
COME SI FA? Si formano gli insegnanti in modo adeguato. Come De Mauro ricordava sempre, il fattore che incide maggiormente nel successo scolastico è la bravura dei docenti. Non conta tanto avere una scuola colorata e con belle piastrelle, certo aiuta e così dovrebbe essere, ciò che conta è l’insegnante: deve essere formato in entrata e in servizio in modo non casuale.
La scelta di dare agli insegnanti cinquecento euro da utilizzare per la loro formazione la dice lunga sulla serietà programmatica dei nostri governanti. I cinquecento euro servono perché lo stipendio dei docenti è vergognosamente basso, ma l’idea che questi coprano la formazione in servizio vuol dire affidare alla volontà del singolo e al mercato ciò che invece dovrebbe essere un processo strutturale e gratuito. Anche ammesso che tutti gli insegnanti siano ugualmente desiderosi di formarsi in ciò che è veramente necessario per i bisogni dei loro studenti, siamo sicuri che chi insegna a Vallo della Lucania abbia le stesse possibilità di formazione di chi fa lo stesso mestiere a Milano, Roma o Napoli?
* L’autrice dell’articolo è ordinaria di Linguistica generale all’Università di Salerno e membra della Segreteria generale e del Gruppo di intervento e studio nel campo dell’educazione linguistica (Giscel)