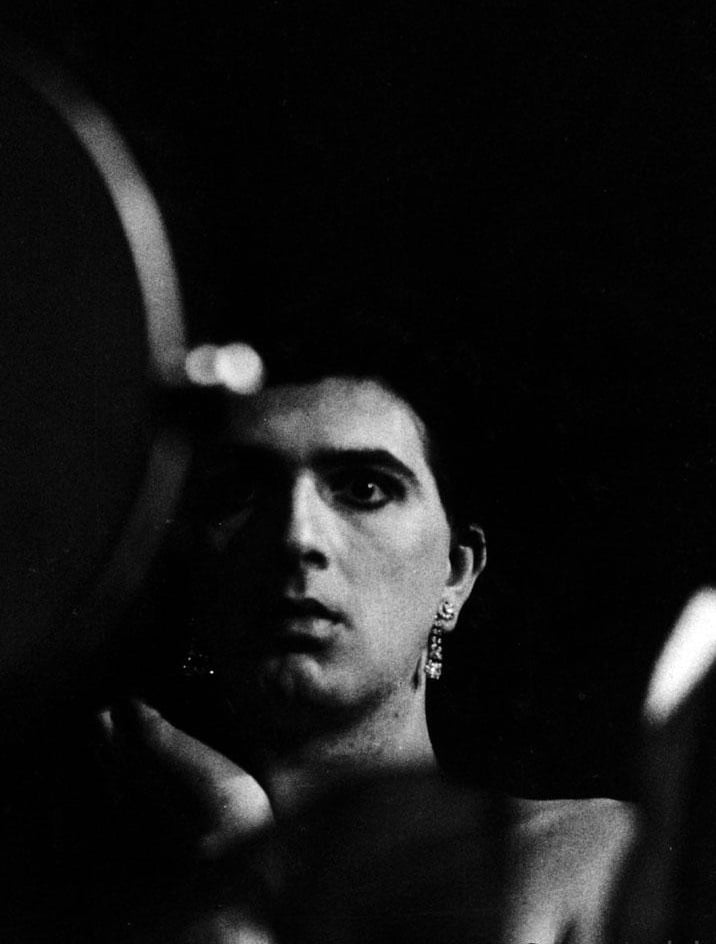Annibale Ruccello, scomparso nel 1986 ad appena trent’anni, nella sua prolifica opera teatrale ha raccontato di una Napoli realissima ma inesistente, chiassosamente presente e viva ma irrintracciabile topograficamente, posta in una qualsiasi periferia urbana o in quella mentale dei suoi personaggi, ancora più «fuori» di una periferia. Spazi liminari brulicanti di angoscia e di crisi della presenza come in un racconto di Ortese o di Mastriani, le scene dei personaggi di Ruccello non si svolgono nei tracciati urbani di Viviani né negli interni domestici di Eduardo De Filippo, ma in ristrette stanze virtuali, tutte mentali, abitate da ansie, paure, rimpianti, attese. Così il monolocale del protagonista ne Le cinque rose di Jennifer (1980), la cucina di Notturno di donna con ospiti (1983), la stanza della professoressa di Weekend (1983), non sono altro che pedane dove questi «deportati» da una cultura a un’altra mettono a nudo la loro caduta, agiscono i loro deliri.
A RICORDARE il drammaturgo napoletano con un agile libretto, Immaginari antropologici. Annibale Ruccello (Ferrari editore, pp. 81, euro 12), è ora Domenico Sabino, regista, studioso di religiosità popolare e docente di Teatro contemporaneo all’Accademia di belle arti di Napoli.
Sabino, dopo aver delineato la biografia di Ruccello, si concentra sulla sua concezione del teatro e della vita, che sappiamo improntata all’antropologia fin dagli anni universitari, conclusi con una tesi (il relatore fu Luigi Maria Lombardi Satriani, cui si deve anche la prefazione del volume ora pubblicato) su La Cantata dei pastori di Andrea Perrucci, da cui nascerà l’omonimo e pregevole lavoro pubblicato l’anno dopo, nel 1978. Uno sguardo «da lontano» che porterà Ruccello a indagare «con rigore e senza convenzioni, come emerge nelle opere teatrali, la società napoletana e l’hinterland in uno dei decenni più difficili: 1976/86». Soprattutto la sua relazione col femminile o, come lo definisce l’Autore, il femmineo, che si ricollega «alla Grande Madre e quindi alla Madonna o, meglio, alle sette Madonne/sorelle della tradizione cultuale in Campania».
COME NELLE CULTURE popolari, cui Ruccello fa spesso riferimento, anche nel suo teatro la voce e il corpo sembrano essere elementi esclusivi, a discapito di scenografie tendenzialmente vuote: c’è «il bisogno di una decostruzione, Destruktion – nell’accezione heideggeriana – dello spazio scenico, che dà spazio al corpo e alla voce». Uno sguardo antropologico è anche nell’analisi che fa Sabino di alcuni elementi drammaturgici (presi nel loro aspetto principalmente fenomenologico) del teatro ruccelliano come la gatta, il topo o la spada. Indagini che necessariamente, nella brevità del lavoro, non hanno la possibilità di penetrare più a fondo nella storia concreta del drammaturgo napoletano e della sua opera, densa di tematiche antropologiche.
Di grande interesse è l’approccio alla lingua utilizzata da Ruccello, una lingua, meglio un dialetto, definita «di resistenza» da Franco Quadri, in cui secondo Sabino «confluiscono tutti gli aspetti letterari e cinematografici di Ruccello: Marcel Proust, Federico De Roberto, Giuseppe Tomasi di Lampedusa, Pier Paolo Pasolini, Thomas Mann, Luchino Visconti, Jean Genet».