A quindici anni dalla sua pubblicazione, arricchito da una prefazione che ne illustra la genesi e l’ulteriore significato che ha assunto nel frattempo per l’autrice, torna per 66thand2nd Madre piccola (pp. 282, euro 17), il romanzo d’esordio di Ubah Cristina Ali Farah, la scrittrice nata a Verona nel 1973 da padre somalo e madre italiana e cresciuta a Mogadiscio, città che fu costretta a lasciare definitivamente nel 1991 allo scoppio della guerra civile. Quel romanzo, poi seguito da Le stazioni della luna e Il comandante del fiume (entrambi per 66thand2nd), nasceva dall’urgenza di tornare a definire la propria vita dopo il trauma della guerra e della fuga e rivelava l’intuito emotivo e la capacità, anche poetica, di dar voce allo spaesamento come a nuovi possibili approdi di una delle protagoniste della nuova letteratura afro-italiana. L’autrice presenterà il libro domenica al Salone di Torino: ore 15 Arena Piemonte con Lara Ricci e Fabio Geda.
«Madre piccola» indaga come si possa ritrovare un proprio centro di gravità dopo aver perso tutti i punti di riferimento. In quel momento ha compreso che per lei quel centro poteva essere rappresentato dalla scrittura?
Il centro era certamente la scrittura o per così dire la mia recuperata capacità di raccontare dopo anni di afasia. L’urgenza di trasmettere non solo quello che avevo vissuto ma soprattutto le storie che generosamente mi venivano narrate. Per molti anni, dopo la guerra e l’esilio, mi mancava il vocabolario per trasmettere l’enormità di quello che era accaduto. Quando si perdono tutti i propri punti di riferimento si ritrova un centro di gravità attraverso la relazione, ogni qualvolta troviamo qualcuno disposto ad ascoltarci.
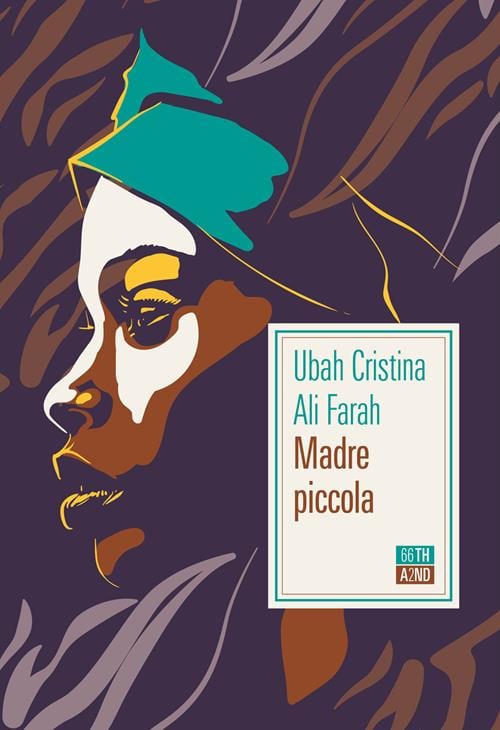
I tre protagonisti del libro, Barni, Domenica e Taageere raccontano in prima persona le loro vicende e i loro stati d’animo. Ai suoi occhi queste tre figure rappresentano i diversi volti di una condizione comune?
I protagonisti ricorrono tre volte nella storia e non solo parlano in prima persona ma si rivolgono a un interlocutore specifico. Dialogano anche con testi canonici della poesia somala che si riferiscono a momenti specifici della loro storia: l’infanzia, nei primi anni ’70, ovvero l’età d’oro della nazione, la rottura e quindi la guerra civile e infine la diaspora susseguente. A mano a mano che i personaggi prendevano corpo, mi sono resa conto della forza di questa rottura, tra il prima e il dopo, la guerra come una sorta di spartiacque in cui era racchiuso un segreto, un frammento che cambiava completamente la direzione di quella che era stata la loro esistenza fino a quel momento.
La redazione consiglia:
Yabar, ragazzo alla ricerca di séProcedendo a ritroso, vale a dire dopo aver letto i suoi romanzi successivi, viene da pensare che con «Madre piccola» lei abbia cominciato a stringere quei nodi solidi lungo un groviglio di fili, come scrive nel libro, che danno forma ad una cultura diasporica, a una letteratura che è allo stesso tempo italiana e somala e che non rinuncia però a guardare dentro ciascuna identità.
La scrittura è in effetti una continua ricerca, un’immersione nella memoria per trovare delle risposte non sempre possibili. Nei romanzi mi sono sempre interrogata sul peso della Storia nelle nostre vite presenti e future, ma anche sul potere dell’immaginario per creare nuove possibilità o luoghi d’approdo. L’identità come sappiano è una pericolosa e inesistente costruzione, ciascuno di noi è una costellazione vibrante, ma non fissa, che ogni volta trova nuove conformazioni.
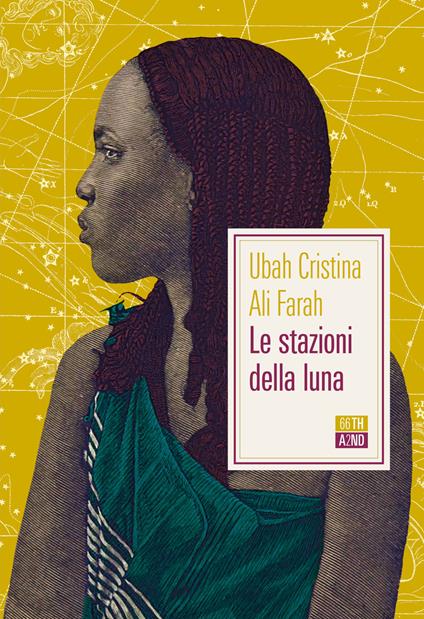
Il libro si apre con una prefazione nella quale lei racconta del suo breve ritorno a Mogadiscio lo scorso anno, per la prima volta dal 1991. Come è cambiata la realtà che ha osservato, ma anche il suo sguardo?
Dopo trentun’anni, immagino che ogni città cambi, soprattutto dopo essere stata completamente distrutta, eppure è stato incredibilmente emozionante per me riconoscerla senza allo stesso modo riconoscerla. Mogadiscio è sempre stata una protagonista centrale nella mia scrittura e la nostalgia può essere un sentimento estremamente pericoloso, dal quale credo di essere ora immune, dopo essermi congedata dalla città.
Di fronte all’invasione russa dell’Ucraina c’è chi ha osservato come gli europei si stiano misurando con ciò che in altre realtà si è costretti a subire da sempre. Invertendo il senso del ragionamento, cosa prova di fronte a tutto ciò chi come lei ha lasciato la Somalia alla volta dell’Europa per fuggire dalla guerra?
È un argomento molto dibattuto in questo periodo e devo dire che ogni guerra ovunque essa avvenga mi riempie di sgomento. Nel 1991 quando lasciai Mogadiscio sembrava che il mondo fosse interamente in fiamme, la guerra in Iraq, nell’ex Jugoslavia, ogni volta che guardavo il notiziario mi veniva da piangere, come se nessuno più potesse essere al riparo. Il destino dell’umanità appartiene a tutti, indipendentemente da dove siamo.





