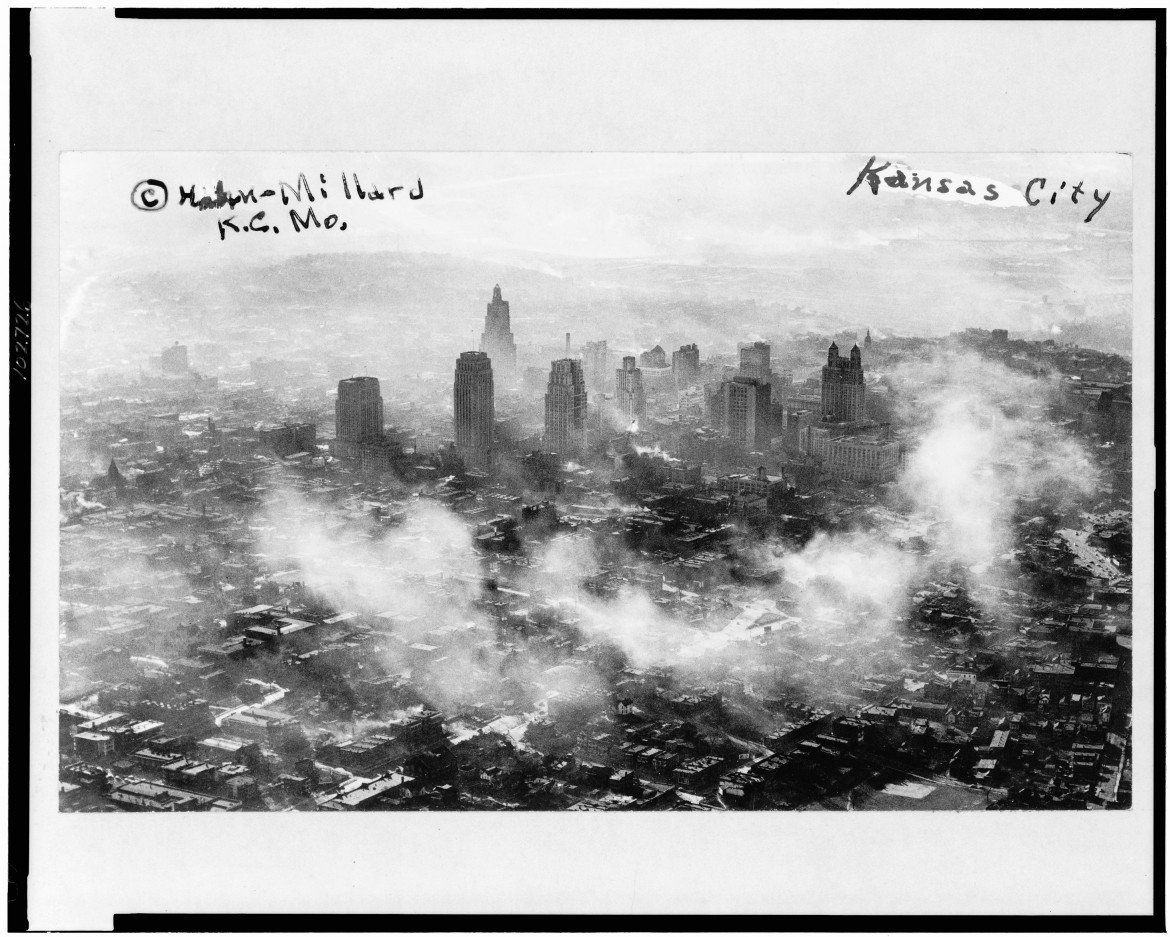Nel già complicato risiko siriano, il presidente statunitense Donald Trump sta muovendo carri armati senza alcuna logica. Mi ritiro subito, anzi tra quattro mesi, chi l’ha detto che me ne voglio andare: questo a grandi linee il riassunto delle ultime puntate della strategia dell’attuale Casa bianca nel paese.
Un paese che per il tycoon altro non è che «sabbia e morte», parole vomitate mercoledì in un incontro con la stampa, in sfregio alla millenaria storia di una regione che è stata culla della civiltà e alle vite distrutte di milioni di siriani, in macerie come le città tra le più antiche del globo.
Dopo aver «dimissionato» il capo del Pentagono James Mattis, contrario al ritiro annunciato dal presidente prima di Natale, dopo aver già tramutato il «subito» in «quattro mesi», ora Trump non dà nemmeno più una data d’uscita: «Un certo periodo di tempo», è la sola concessione in merito alle tempistiche del fantomatico ritiro.
E poi, in perfetto stile americano, dà un colpo al cerchio e uno alla botte: promette di difendere i curdi siriani mentre il suo Dipartimento di Stato discute con il loro principale nemico, la Turchia, l’accordo sulla vendita del sistema di difesa aerea Patriot, necessario a impedire che Erdogan porti a compimento un identico accordo, già siglato, con la Russia per il sistema S-400, previsto in arrivo ai turchi a ottobre.
«Ce ne andremo e lo faremo in modo intelligente – ha detto Trump ai giornalisti – Ma non ho mai detto che ce ne andremo domani». Nel frattempo, aggiunge, i marines continueranno a combattere l’Isis e a garantire protezione alle unità di difesa curde Ypg/Ypj. Da chi? Dall’alleato della Nato, la Turchia. Come? Lasciandogli le armi statunitensi, fanno sapere fonti interne all’esercito Usa.
Una schizofrenia politica che non aiuta a uscire dal pantano siriano, coltivato dalle potenze globali e regionali negli ultimi otto anni. E alla fine il vincitore della guerra è Bashar al-Assad, presidente dalle sette vite. Le deve sì a russi e iraniani, ma anche all’incapacità americana di mettere insieme una strategia univoca.
E così, dopo essersi ripreso quasi tutto il paese, ora punta con le spalle coperte a Rojava. Con l’arrivo delle truppe governative nella regione su richiesta curda, nello specifico nella città di Manbij, i combattenti delle Sdf (Forze democratiche siriane) hanno iniziato in centinaia a ritirarsi per spostarsi sulla riva orientale del fiume Eufrate. Lì, dove l’esercito turco intende proseguire l’operazione terrestre iniziata tre anni fa.
Con Manbij affollata come non mai (2mila marines Usa, i governativi, le Ypg/Ypj curde e pure i miliziani di opposizione al soldo turco), la Federazione del Nord della Siria – la creatura politica nata dal confederalismo democratico in atto a Rojava – agisce: una delegazione è volata a Mosca nei giorni scorsi per discutere degli ultimi sviluppi. E, probabilmente, per rilanciare il dialogo sull’autonomia della regione iniziato la scorsa estate con il governo di Damasco. «Non abbiamo mai tagliato i ponti con il governo – dice a Kurdistan24 Abdulkarim Omar, co-presidente della Commissione esteri della Federazione – Abbiamo sempre detto che il regime non era serio nel negoziato per un accordo».
Ora potrebbe esserlo di più. A Manbij si incontrano due esigenze: quella del governo di proseguire nella riunificazione del paese e quella di Rojava di salvare il più bello degli esperimenti politici messi in atto in Medio Oriente. Da mercoledì gli abitanti di Manbij hanno iniziato una veglia, sotto una grande tenda nel centro della città, con un messaggio: resisteremo all’occupazione turca.