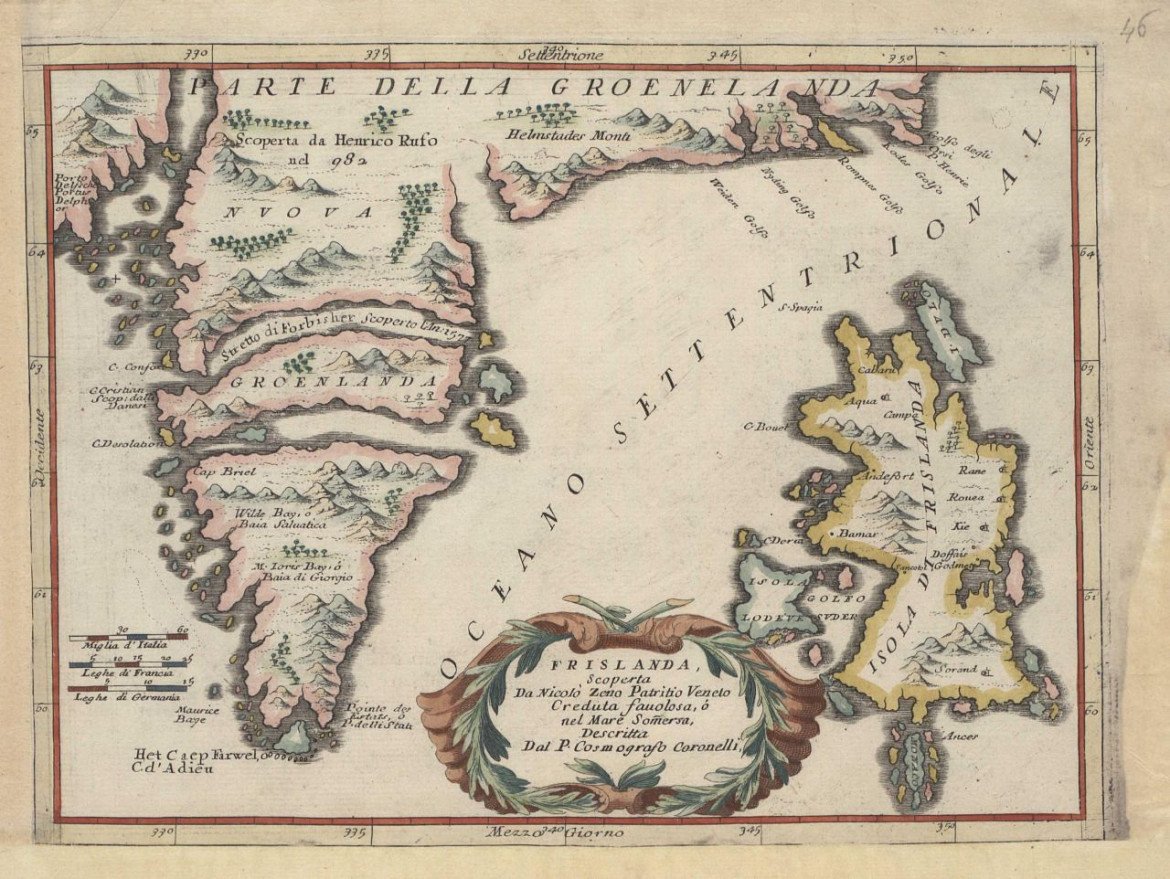Dodici anni separano la prima edizione di Nel bianco (Rizzoli 2008), di Simona Vinci, da quella uscita nelle scorse settimane (Neri Pozza, pp. 208, euro 18). Nel frattempo, la Groenlandia, uno degli ultimi lembi di terra a conservare spazi inesplorati, ha assistito all’incremento radicale dei viaggi low cost e delle temperature globali, che ne minacciano seriamente il delicato ecosistema.
IL PASSAGGIO del tempo, che naturalmente trasforma la ricezione del testo, è colto anche dalla veste grafica del libro, che se in precedenza raffigurava in copertina una balena stilizzata su sfondo nero, oggi ritrae un malinconico orso polare che si specchia nell’acqua di un paesaggio artico in via di scioglimento (l’immagine è del fotografo norvegese Roy Mangersnes).
Nel bianco è un libro di viaggio che rielabora l’esperienza della scrittrice, che nel 2008 spese alcune settimane a osservare la vita di Tasiilaq, un piccolo villaggio dell’isola artica. Poiché i viaggi «cominciano dentro la testa», la prima parte del testo è dedicata alla genealogia del progetto: la raccolta delle informazioni, il tracciato del viaggio, l’immaginario conglomerato attorno alla destinazione, costituito anzitutto da testi di esploratori a cavallo dei secoli XIX e XX, nonché dalla produzione letteraria di London e di un autore siberiano, Jurij Rytcheu.
Nessuno dei racconti è ambientato nella terra meta del viaggio, ma l’immaginario è il luogo principe della confusività: «Siberia, Alaska e Groenlandia mi sembravano tre nomi diversi dello stesso posto ghiacciato e bianco», perfetti dunque per diventare, secondo l’espressione volgare, un «luogo dell’anima». In questi testi, sfogliati nei pomeriggi di alcuni decenni prima, è collocata l’origine del viaggio.
La seconda parte è intitolata Islanda, isola in cui l’autrice passa una settimana prima di arrivare a destinazione. Si tratta di un luogo di mediazione, in cui la scrittura prende le misure stilistiche e retoriche del problema: come descrivere un paesaggio-non paesaggio, un paesaggio che progressivamente diventa sempre più a-geografico, senza segni?
QUI SCELTE LESSICALI e costruzioni metaforiche si avvicinano ad un campo semantico sempre più rarefatto, spesso composto da pochi elementi naturali di base. Ma è solo nella terza parte, dedicata finalmente al viaggio e all’arrivo a Tasiilaq, che il linguaggio affronta il vuoto di segni: «Vita che si perpetua un istante dopo l’altro, che sciama, ronza, fischia, scorre, zampilla, erutta, tracima, soffia, cinguetta, bela, nitrisce, ma che non racconta storie. Le storie esistono perché esiste il tempo misurato. E per la natura, il tempo misurato, scandito, sezionato, non ha alcun senso». Le tracce umane, però, non sono decifrabili: in alcune pagine gli Inuit, immersi in un silenzio «minerale», sono parte del paesaggio: «non riesco a scindere le condizioni in cui vive questa gente dal paesaggio maestoso nel quale vive».
Simona Vinci si trova dunque in un’impasse che porta al tentativo di descrivere il tempo, sottoposto, così come il silenzio, a un’isotopia di concretezza e sovrapposto al Sila, la parola groenlandese per denotare il tempo meteorologico, elemento determinante per la vita a quelle latitudini. La funzione della fotografia, interpolata al testo, sembra quella di dare concretezza, attraverso il fantasma delle immagini, alla presenza del tempo. Mai in modo diretto, però: «cerco di fotografarlo, questo bianco ma quella che vedo nel monitor della digitale non è neanche un’immagine, non è niente». Non è possibile fotografare il tempo.
IL LIBRO si sottopone consapevolmente ai luoghi comuni della letteratura di viaggio: l’incomprensibilità dei luoghi e delle persone, spesso retoricamente organizzata in enumerazione caotiche; la mediazione di strutture descrittive note per affrontare il problema dell’ignoto; l’uso dell’alterità per conoscere le proprie radici, tema sul quale si conclude il libro. Qualche volta ne scapita, pena una certa prevedibilità, ma nel complesso l’esperimento è riuscito.