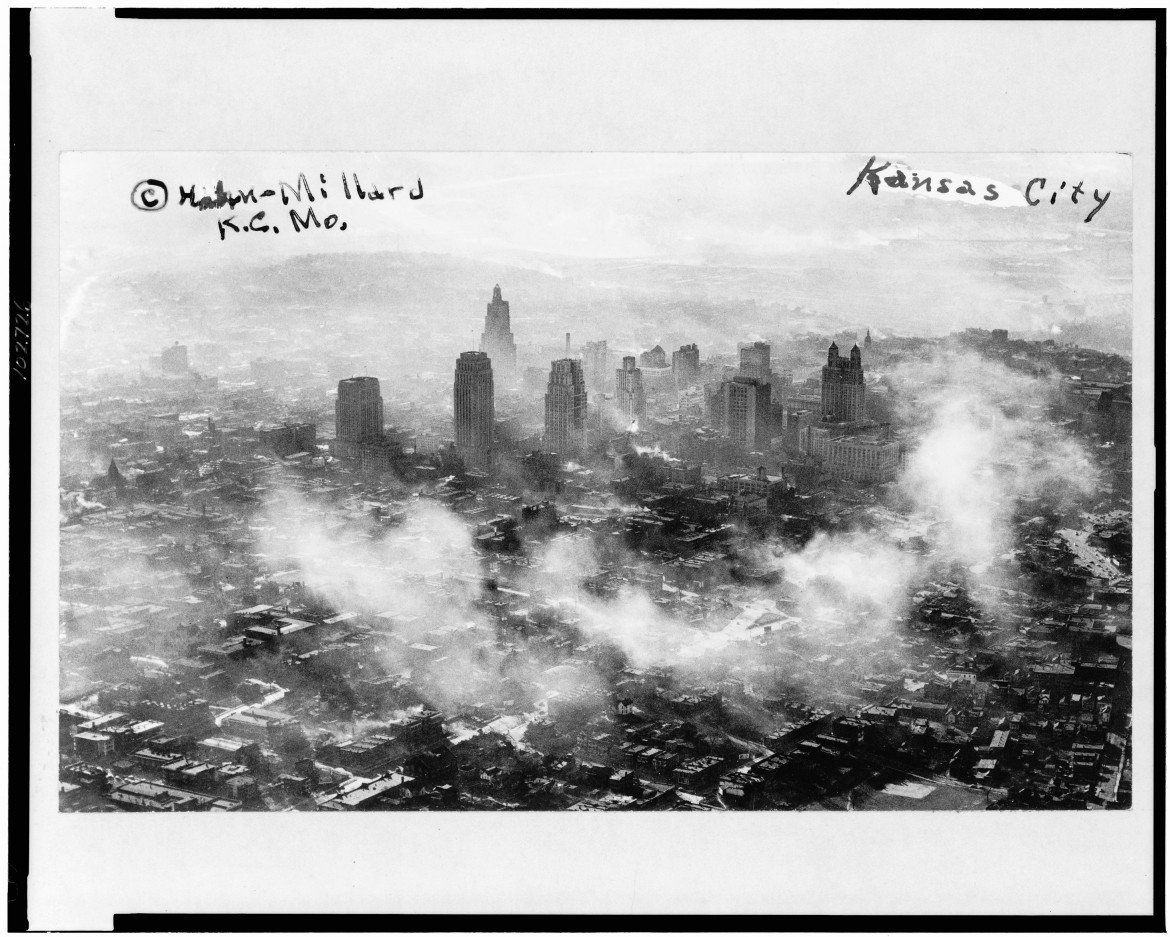È curioso come i nuovi talenti della comunicazione politica spesso non vengano riconosciuti per tempo: forse per il fatto che i vecchi talenti della comunicazione sono un po’ reticenti a cedere il passo agli avversari. Solo la mattina dopo la vittoria-choc di Donald Trump nelle elezioni dell’8 novembre si è cominciato a capire che, dal punto di vista della comunicazione, lui aveva fatto tutte le cose giuste e Hillary, insieme al 98% della stampa americana, tutte quelle sbagliate.
TRUMP HA FATTO APPELLO a un senso di crisi e di pericolo, Hillary ha puntato sulla tranquillità e la rassicurazione. Trump ha usato un linguaggio diretto e violento, Hillary sembrava un avvocato a colloquio con i suoi clienti. Trump ha promesso di costruire un muro al confine con il Messico, Hillary ha noiosamente citato la «riforma dell’immigrazione». Il bancarottiere di New York vuole «prosciugare la palude» della capitale Washington, la ex First Lady sembrava non essere mai vissuta altrove. Chi è risultato più convincente?
IN CONDIZIONI «NORMALI», i democratici avrebbero dovuto stravincere contro un candidato non qualificato, estremista, poco sostenuto dal partito.
Doveva finire come nel 1964 nel match fra Lyndon Johnson e Barry Goldwater: 61% a 38%, sedici milioni di voti di scarto. Hillary non solo non ha vinto ma ha perso perché ha trascurato, sia dal punto di vista della comunicazione che della proposta politica, quegli stati del Midwest che sembravano i più fedeli al partito democratico: in Michigan, Obama aveva ottenuto 10 punti percentuali più di Romney nel 2012, che erano stati addirittura 17 nel 2008 contro McCain.
Trump ha vinto e forse è venuto il momento di sottolineare che il suo percorso politico ha delle interessanti analogie con quello di Ronald Reagan, un altro grande protagonista della politica spettacolo. Trump si è fatto le ossa nel suo show The Apprentice, Reagan aveva fatto gli spot pubblicitari per General Motors per anni, prima di scegliere la politica attraverso un percorso più tradizionale come governatore della California.
LO STILE DEI DUE non avrebbe potuto essere più diverso: tanto Reagan cercava di essere rassicurante (un venditore nato, come Berlusconi), tanto Trump è invece violento, demagogico, sprezzante verso gli avversari. Entrambi, però, capivano istintivamente cosa il loro pubblico voleva sentire, che è qualcosa di molto diverso da ciò che si vuole sentire nei salotti di Hollywood o nelle redazioni di New York. Noi osservatori della politica americana spesso dimentichiamo che i film di Woody Allen che ci piacciono tanto si possono vedere a Manhattan oppure a Los Angeles, ma in mezzo ci stanno 3.944 chilometri dove non vengono neppure distribuiti perché non avrebbero pubblico. Uno dei motivi del sostegno a Trump più citati nelle interviste post-voto è il suo straight talk, parlare chiaro, dove naturalmente la «franchezza» è in realtà un abile miscuglio di xenofobia, misoginia e razzismo, un codice comunicativo che però è usato da almeno metà degli americani.
A DIFFERENZA di Reagan, Trump ha dovuto conquistare il partito repubblicano dall’esterno, schiacciando i suoi concorrenti, quindi arriva a Washington non come governatore del più popoloso stato dell’Unione ma come outsider che non è riuscito a raccattare nemmeno l’endorsement di un giornale che aveva sostenuto tutti i candidati repubblicani nell’ultimo secolo, il Manchester Union-Leader del New Hampshire. Tra l’Alaska e la Florida, si sono trovati solo sei quotidiani, tra cui il decisamente ignoto ai più Waxahachie Daily Light, per sostenere Trump (Waxahachie sta in periferia di Dallas, in Texas).
L’OUTSIDER, però, non può governare un paese di 323 milioni di abitanti contando sulla figlia Ivanka, il genero Jared Kushner, l’ex sindaco di New York Rudy Giuliani e il governatore del New Jersey Chris Christie. Ah sì, c’è anche il vicepresidente Mike Pence, che è del mestiere ma il suo stato di provenienza, l’Indiana, ha un reddito procapite al 36° posto fra quelli dei 50 stati americani, non la migliore delle raccomandazioni per riportare la prosperità in tutto il paese. Quindi Trump può solo fare quello che sta facendo: ricorrere ai lobbisti della capitale, al partito repubblicano, ai centri studi finanziati dai miliardari vicini al partito, in testa la Heritage Foundation. Avendo promesso di «prosciugare la palude» Washington, nei primi 17 giorni dopo la sua elezione si direbbe che Trump stia sguazzando piuttosto felice nel fango. Le nomine annunciate fin qui, chi sono? Reince Priebus, il presidente del partito repubblicano, come capo di gabinetto. Jeff Sessions, senatore a Washington dal 1997, come Attorney General. Il nome completo è Jefferson Beauregard Sessions, dove «Beauregard» è un omaggio al generale G. T. Beauregard, uno dei più importanti generali sudisti nella guerra di Secessione. Michael Flynn, capo della Defense Intelligence Agency nel 2012, come consigliere per la sicurezza nazionale. Mike Pompeo, deputato repubblicano, come direttore della Cia. Nikky Haley, governatore repubblicano del South Carolina, come ambasciatrice all’Onu e infine Betsy DeVos, ex presidente del partito repubblicano in Michigan, miliardaria, come segretario all’Istruzione.
Si parla inoltre del miliardario Wilbur Ross come segretario al Commercio. Quindi: senatori, deputati, militari di carriera, governatori, finanziatori del partito, non esattamente la lista che ci si aspetterebbe da chi per mesi ha lanciato solo insulti e anatemi contro «l’establishment».
IN REALTÀ TRUMP sembra avviarsi lungo la strada già percorsa da Reagan, che arrivò a Washington con una reputazione di estremista ma compose una squadra di governo piuttosto convenzionale: politici repubblicani di esperienza, banchieri di Wall Street, militari di carriera. Il vicepresidente fu George Bush padre, che alle primarie aveva definito il programma economico di Reagan Voodoo Economics. Il capo di gabinetto fu James Baker, collaboratore dei presidenti repubblicani Nixon e Ford. Il segretario al Tesoro fu Donald Regan, che veniva da Merril Lynch (Trump vorrebbe in quel posto Jamie Dimon, di JPMorgan Chase). Il segretario all’Istruzione fu Terrel Bell, il cui incarico era smantellare il ministero, esattamente lo stesso che, 36 anni dopo, avrà Betsy DeVos, grande sostenitrice della scuola privata. Il segretario di Stato fu, brevemente, Alexander Haig, in precedenza comandante in capo della Nato. Trump, ora, ha bisogno del partito almeno quanto, in campagna elettorale, il partito ha avuto bisogno di lui.
IL PARTITO REPUBBLICANO del 1980 era però molto diverso da quello del 2016. Oggi i repubblicani moderati sono estinti, il partito è la casa comune di estremisti di destra, più o meno ostentati secondo le contingenze elettorali. Reagan non avrebbe potuto, nemmeno volendo, portare alla Casa Bianca come consigliere un personaggio vicino ai suprematisti bianchi come Steve Bannon. E il generale Haig, una testa calda esattamente com’è oggi il generale Michael Flyn, durò in carica poco più di un anno. Quindi, la vera domanda oggi è quanto Trump sarà indipendente dal partito e cosa vorranno o potranno fare i suoi collaboratori, in politica estera nettamente più guerrafondai di lui.