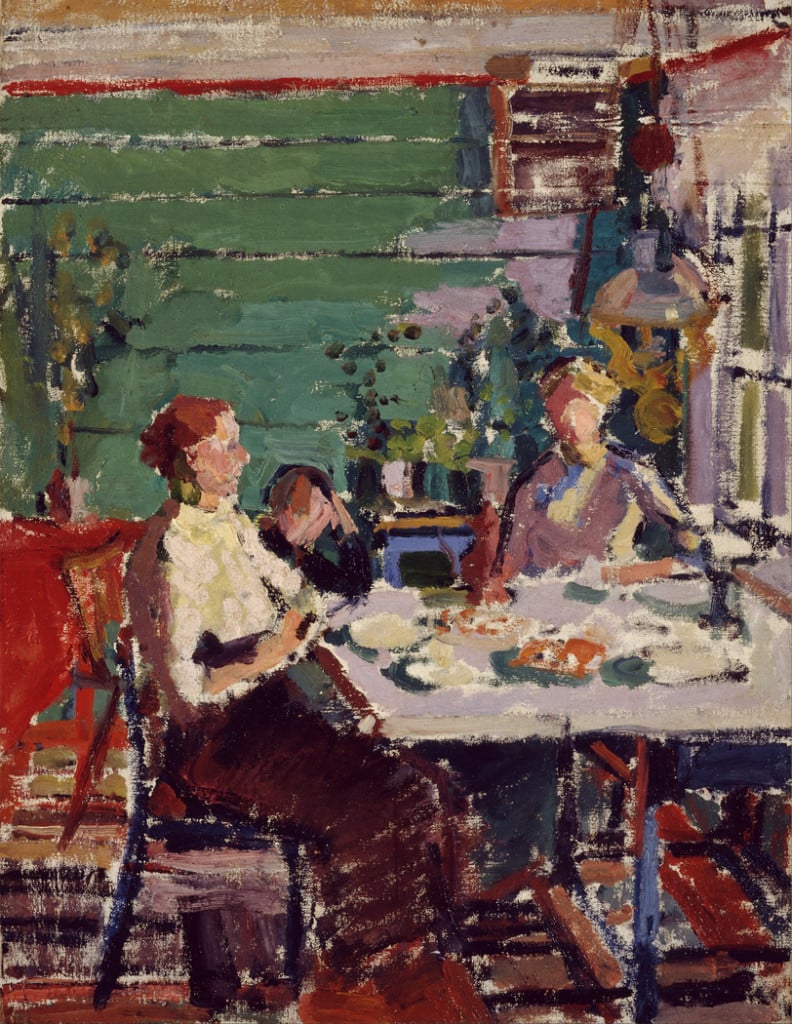Quando, nel 1882, diede alle stampe Two on a Tower Thomas Hardy aveva già passato la quarantina e pubblicato alcuni significativi romanzi, tra i quali quel Via dalla pazza folla (Far from the Madding Crowd) che Virginia Woolf considerò un primo «magnifico risultato» di questo prolifico e un po’ misterioso scrittore. Attivo fino all’ultimo (morì nel 1928, a 88 anni), Hardy contenne il proprio lavoro di romanziere entro il confine del XIX secolo, pur avendolo immaginativamente per tanti versi già varcato. Come poeta, invece, si spinse oltre. Il titolo, non immemore di Walter Pater, di una delle sue raccolte – Moments of Vision, del 1917 – esibisce quella innervazione profonda che iscrive a pieno titolo il suo nome nell’incipiente Novecento. Da Proust, a Woolf, a Joyce.
Nato in un remoto villaggio dell’Inghilterra sud-occidentale da padre scalpellino e piccolo costruttore locale, e madre assai superiore al marito per grado d’istruzione, Thomas Hardy – al pari del giovane Swithin St Cleeve di Due sulla torre – sentì «scorrere nel suo sangue due classi sociali», distanti ma non competitive. Onorò il lavoro del padre laureandosi in architettura al King’s College di Londra. Poi cominciò ad affermarsi come architetto nella grande capitale, ma presto si stancò di quella professione, e tornò sui luoghi dell’infanzia per dedicarsi integralmente alla scrittura. Per costruire i suoi romanzi sentì il bisogno di calarsi nelle profondità storiche e antropologiche del territorio d’elezione. Ambientò la maggior parte delle sue trame in una immaginaria regione che chiamò Wessex – «terra dell’ovest» – dal nome dell’antico regno anglo-sassone che nell’alto Medioevo aveva governato quella terra. Trapela, da queste scelte vocazionali, un ideale ritorno alle potenze materne.
Due anime, e il cosmo
Esiste una letteratura critica su Hardy scrittore paesaggista, che lo descrive come quasi un attardato Wordsworth sensibile ai più minuti effetti naturalistici: al suono del vento, «differente a seconda dei differenti alberi che attraversa; o della pioggia, a seconda che cada su un terreno arato o su una sterpaglia di radici secche», scrive per esempio Woolf. Tuttavia, Hardy si distacca dal secolo che stava morendo nel lavorare questa Natura onnipervasiva come una potenza inaccessibile, beffarda spettatrice del fare umano. Ne deriva alla sua prosa un effetto speciale, come di ripresa con due camere che si incrocino senza toccarsi: e forse la fortuna filmica cha ha arriso a questo scrittore, e in particolare a Far from the Madding Crowd, dal quale sono stati prodotti ben quattro film, di cui l’ultimo nel 2015, è scritta proprio nell’intuizione «cinematografica» della capacità di suggestione delle sue tramature stressate su due telai.
Due sulla torre (ora tradotto da Chiara Vatteroni per Fazi, prefazione di Giorgio Montefoschi, pp. 360, € 17,00) accentua al massimo questa tecnica e in questo senso può dirsi sperimentale. Non meraviglia che il fatto che incontrò scarso successo di pubblico. Lo stesso Hardy, nel difendere la sua creazione, mise il dito nella piaga: «questo esile racconto – scrisse nella nota introduttiva alla seconda edizione – è nato dal desiderio di incastonare due esistenze infinitesimali nell’universo stellare». Ma nello scrivere tale desiderio sfocia in tragedia: lungi dall’incastonarsi, le due esistenze si sparigliano. Nello spazio desolato dei cieli, l’aspirante astronomo, che vorrebbe cartografarli, si trova a tu per tu con una immensità «senza limiti e senza forma», disseminata di rovine: la materia stellare è in continuo, irreversibile disfacimento. Il «vero cielo» è un orrore: «the actual sky is a horror», ripete Swithin, quasi presago dell’imminente «the horror, the horror!» di Kurtz, nel conradiano Cuore di tenebra (1899).
La torre del titolo è artefatto architettonico che si erge sulla cima di un colle, i cui fianchi sono ricoperti da un fitto bosco di abeti. In basso, una striscia di terreno arato rende difficile l’avvicinamento anche solo alla base del colle. In modi diversi l’operosità umana e la forza primigenia del bosco sembrano essersi unite per sbarrare l’accesso alla torre che svetta in alto, luminosa. Ma, così come il lavoro dei campi non è che un graffio sulla crosta terrestre, destinato a differenziare momentaneamente il colto dall’incolto, anche la Storia è solo un’increspatura del tempo astronomico. «La cima della collina ricoperta di abeti era (secondo alcuni archeologi) un antico accampamento romano – se non (come sostenevano altri) un antico castello britanno, oppure (come giuravano altri ancora) un antico campo sassone».
Una sera, dopo vari tentativi falliti, lady Constantine, malinconica signora del luogo, riesce a raggiungere la sommità della torre. E lì si offre ai suoi occhi la visione di un giovane biondo, quasi ancora un adolescente, intento a scrutare il cielo. Lei ha ventinove anni, e un matrimonio sfiorito alle spalle. Così ha inizio la favola.
Coincidenze mirabolanti
Da quel momento non si contano gli andirivieni tra la torre e la casa signorile. All’approssimarsi di una notte perfetta per l’osservazione delle stelle, mentre i due si inerpicano su per il colle – esso stesso opera d’architettura: «earthwork» stratificato lungo il tempo infinito di una preistorica land art planetaria – la signora ha la sensazione di stare camminando sui morti, e dunque sulla Storia: «Com’è terribilmente buio! … Sono certa che qui giacciano sepolti molti antichi Britanni». Si ha a tratti l’impressione che la difficoltà di una scelta concettuale ed espressiva che all’essere umano contrappone una Natura tanto matrigna produca nella trama un sovrappiù di coincidenze mirabolanti, sfocianti in tragedia. Ma la tragedia è qui elemento originario, anteriore alla coincidenza. Improvvisamente, un’ombra di Morte cala sul personaggio; ne fiacca la forza desiderante, e riporta in primo piano, assieme all’impulso autodistruttivo, un più irresistibile, perché primario, principio di piacere. Il fascino modernistico della narrativa di Hardy cresce su questa educazione sentimentale alla morte.
Ne è plasmata la protagonista femminile di Due sulla torre: un personaggio fortemente desiderante diviso tra l’impersonare la ricca e non disinteressatamente munifica lady Constantine, e la voluttuosa Viviette che spinge l’amato al matrimonio segreto. Sul vezzeggiativo da cagnolino è impresso il sigillo d’imbastardimento della sua anima. Facendo le viste di difendere Viviette, Hardy ancora una volta svia il lettore: «nel libro non c’è nemmeno una carezza fuori del vincolo matrimoniale». Tuttavia è indubitato che qualche carezza clandestina vi fu: chi, se non Swithin, è il padre del bambino biondo che l’astronomo in erba stringe fra le braccia alla fine?
Fine di un filo esausto
Ma la decadenza morale di Viviette non è nell’eventuale infrazione ai codici del comportamento sessuale, bensì nell’essersi arresa al «desiderio di annichilimento che nasce dalla disperazione, quando si pensa che, alla fine, anche noi, che dovremmo essere i nostri amici migliori e più fedeli, non crediamo più alla nostra causa». Siamo alle ultime pagine, ed è da questo momento che Viviette comincia a morire: la scoperta – complice la classica lettera postuma – di aver già dovuto sopportare, agli occhi del marito, quel disprezzo, risveglia in lei un senso di colpa retrospettivo.
La sua forza vitale ne è fiaccata alla radice. Si spegnerà poco dopo, fulminata dalla troppa felicità per il ritorno dello sposo, ora deciso a rivelare al mondo il matrimonio fin lì per volontà di lei tenuto segreto. L’improvviso finale a sorpresa è l’ennesima coincidenza mirabolante che tronca un filo narrativo ormai esausto.