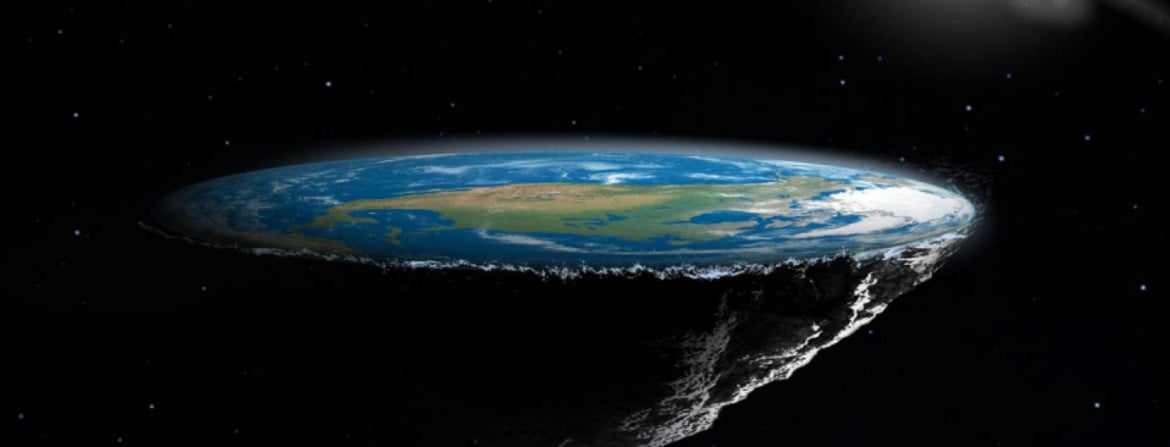Nel 2018, il Metropolitan Museum di New York proponeva una mostra intitolata Everything is Connected: Art and Conspiracy. Per chi visitava la rassegna, l’impressione era soprattutto quella di un certo estraniamento: sembrava contemplare un passato distante, in cui le teorie del complotto erano un fenomeno marginale radicato soprattutto nella controcultura degli anni ’60 e ’70 e collegato a forme di indagine critica e artistica. Ma è proprio il contrasto con il contesto in cui veniva proposta questa mostra che suscitava riflessioni.
Oggi, il complottismo non è più un fenomeno marginale ma fa parte del mainstream politico e tende a collocarsi in una ben determinata area ideologica. Dal movimento anti-vaccino al diffondersi delle teorie di QAnon tra i sostenitori di Trump o alle elucubrazioni sul piano di sostituzione etnica in Europa, le teorie del complotto sono diventate un aspetto fondamentale del discorso politico dell’estrema destra e si collegano spesso a fenomeni di stampo fascista. Il fenomeno, ovviamente, non è nuovo, e il fascismo del ‘900 fece ampio uso delle teorie del complotto, a cominciare dalla più famosa, il falso documento dei Protocolli dei savi di Sion.
Per la maggior parte degli studiosi, le teorie del complotto vengono considerate soprattutto come un fenomeno di ordine epistemologico e cognitivo. Questa posizione è stata riassunta in modo esemplare una decina d’anni fa da due studiosi di Harvard, Cass Sunstein e Adrian Vermeule: le teorie del complotto, secondo loro, rappresenterebbero «a crippled epistemology», cioè una epistemologia «zoppa», incapace di distinguere tra causalità e intenzionalità. Gli studi di psicologia cognitiva hanno provveduto ad approfondire questa ipotesi, collegando questi modi di pensare a determinate distorsioni delle funzioni cognitive, considerando l’attribuzione di intenzionalità o di non-casualità a determinati eventi una modalità spontanea, innata, dell’attività cerebrale che viene superata dallo sviluppo delle funzioni superiori del ragionamento logico nel corso dell’educazione.
In questa prospettiva, contrastare le teorie del complotto diventa fondamentalmente una questione di rieducazione cognitiva, che può prendere varie forme: evitare gli effetti di «bolla informazionale» ed esporre gli individui a punti di vista alternativi, correggere le distorsioni del ragionamento rinforzando i contrappunti critici, mantenere una vigilanza epistemologica sui social network, ecc. Questa concezione sta oggi dietro le politiche pubbliche di lotta contro il complottismo, che prendono quasi tutte la forma del «debunking», cioè dell’esposizione della falsità o dell’illogicità dei discorsi complottisti – politiche che, come ormai si sa, non funzionano.
Per certi versi, la riduzione delle teorie del complotto a una questione epistemologica è stata coestensiva alla nascita dell’idea stessa di «teoria del complotto». La nozione di conspiracy theory nel suo senso odierno è stata coniata dal filosofo Karl Popper in due conferenze del 1948 dedicate alla questione del razionalismo nelle scienze sociali, che incluse più tardi nella seconda edizione di La società aperta e i suoi nemici, pubblicata nel 1952.
Quello che Popper chiamò la «teoria complottistica della società» (conspiracy theory of society) rappresentava secondo lui una forma di superstizione, simile all’idea secondo la quale ciò che accade nel mondo degli uomini accade perché è stato deciso dagli dei. Nel mondo moderno, non ci sono più gli dei, ma per chi continua a vedere nelle guerre, nelle sciagure e nelle catastrofi il risultato di un’intenzione e di un disegno nascosto, il posto degli dei «era ormai occupato dai Savi di Sion, dai monopolisti, dai capitalisti, e dagli imperialisti».
Per Popper, lo storicismo moderno, pur essendo secolarizzato, rimaneva una forma di pensiero mitologico rivolto verso delle entità invisibili. Popper non negava che i complotti esistessero, anzi: passiamo il nostro tempo a cercare di controllare, individualmente o in coordinazione con altri, la nostra realtà sociale e il comportamento degli altri. Eppure i risultati che raggiungiamo non sono mai esattamente quelli scontati. Se «niente risulta esattamente come inizialmente previsto», secondo Popper è perché la società rappresenta una realtà molto complessa, il risultato imprevedibile dall’intrecciarsi costante di miriadi di azioni individuali che non sono calcolabili e quindi sfuggono ai tentativi di controllarle.
Il complotto è per certi versi il modello dell’agire umano, ma lo è proprio perché – come Machiavelli aveva già detto – è quasi sempre destinato a fallire. La teoria del complotto non poteva quindi essere una teoria che spiegava i fenomeni sociali. L’unica scienza sociale possibile, per Popper, si doveva limitare allo studio delle «conseguenze non intenzionali dell’azione».
A ben guardare, però, le osservazioni di Popper sull’epistemologia delle scienze sociali racchiudevano un argomento politico. Le sue riflessioni sul complotto si basavano su un’immagine della società direttamente ispirata ad alcuni scritti di Friedrich Hayek, pubblicati sulla rivista Economica durante la guerra, e da The Road to Serfdom, che uscì nel 1945 e che Popper aveva letto. Per Hayek, l’ordine sociale era il risultato spontaneo, quasi organico, di un’infinità di azioni individuali, un ordine che per definizione era imprevedibile e quindi sfuggiva a qualsiasi tentativo di manipolazione razionale. Le ragioni per le quali i complotti di solito non hanno l’esito scontato erano le stesse ragioni per le quali la pianificazione economica era, secondo Hayek, destinata a fallire: l’imprevedibilità fondamentale di un ordine sociale basato sulla libertà individuale.
Ma ciò implicava un’eccezione importante: laddove l’agire non era libero le cose andavano diversamente. L’ingegneria sociale poteva funzionare a partire dal momento in cui poteva contare su un certo livello di coercizione. Ovvero: se la teoria del complotto era inaccettabile come teoria sociologica nel mondo democratico, offriva invece una descrizione corretta delle società totalitarie, nelle quali gli avvenimenti sociali potevano essere ricondotti a un potere centrale tentacolare che sovrastava alla società e ne controllava il funzionamento. La critica della teoria del complotto ricopriva in realtà una sua parziale validazione.
Le considerazioni di Popper riflettevano senz’altro l’emergere di una corrente «neo»-liberale che trovò nella lotta contro il totalitarismo un cavallo di battaglia ideologico durante la Guerra Fredda. L’assimilazione del totalitarismo a una forma di complotto era già stata proposta da Alexandre Koyré in uno scritto pubblicato nel 1943 durante l’esilio a New York, che trattava di ciò che oggi chiamiamo le fake news (di complotti, Koyré s’intendeva assai: mandato a Odessa dopo la fine della prima guerra mondiale, era verosimilmente stato allo stesso tempo agente dei servizi francesi e responsabile bolscevico della commissione stampa e propaganda della città).
Secondo Koyré, se la menzogna era uno stratagemma da sempre usato in tempo di guerra, era diventato il perno dell’organizzazione sociale dei regimi totalitari. Per un gruppo che si crede circondato da forze ostili, era naturale ricorrere alla dissimulazione. Le parole dei suoi membri e dei suoi capi servivano allora soprattutto a nascondere i loro scopi e le loro opinioni: diventavano «l’unico modo di nascondere il proprio pensiero». La verità era riservata agli insiders e diventava «esoterica». I movimenti totalitari erano quindi simili a delle «società segrete», ma la loro particolarità era che anche una volta conquistato il governo mantenevano le strutture delle società segrete: il potere di un gruppo di iniziati, il sospetto costante, l’alterazione del linguaggio fino al punto di oscurare la realtà… Koyré li definì «complotti a cielo aperto».
La formula fu ripresa da Hannah Arendt, in Le origini del totalitarismo, libro sul quale l’articolo di Koyré ebbe un’influenza profonda. Per la Arendt, credere nei complotti determinava degli effetti organizzativi reali: «i Nazisti cominciarono con la finzione di un complotto e presero esempio, più o meno coscientemente, dalla società segreta dei Savi di Sion». Ogni complotto fittizio finisce col produrre un contro-complotto reale. Ma ciò significa paradossalmente che, in determinati casi, il rapporto tra ideologia e realtà si rovescia, e l’ideologia diventa fonte e spiegazione dei fenomeni sociali: le teorie del complotto diventano causa del fascismo o del populismo e quindi li spiegano.
È difficile separare gli aspetti epistemologici da quelli politici in una nozione intrisa dai conflitti ideologici della seconda metà del ’900. Quanto sono rilevanti oggi queste idee e quanto ci permettono di decifrare il passaggio storico che stiamo attraversando? Sicuramente va accolta l’intuizione che vede nelle teorie del complotto un formidabile strumento di coordinazione ideologica e di organizzazione politica dal basso e a basso costo, che, capitalizzando sul risentimento, apre nuovi spazi politici fuori dai vecchi partiti, spostandoli completamente o, come nel caso del partito repubblicano negli Stati Uniti, prendendone il controllo. E senz’altro elementi di stampo fascista si ripropongono oggi attorno a questi discorsi.
Ma è sufficiente denunciare il fascismo latente o esplicito delle teorie del complotto? Il rischio di ridurre una questione politica a una questione psicologica o ideologica – e quindi di offuscarla – è reale. Nel suo tentativo di definire uno «stile paranoico» che si esprimerebbe regolarmente nella storia americana, lo storico Richard Hofstadter finì col dipingere una forma mentis sradicata da qualsiasi contesto storico, una specie di essenza pericolosa, da tenere a bada. Non a caso il suo famoso saggio del 1964 viene oggi riscoperto (e ripubblicato questo anno nella prestigiosissima collana «Library of America») come chiave di lettura del «populismo» contemporaneo.
Le debolezze dell’approccio di Hofstadter sono palesi: a ridurre certi fenomeni politici alla loro retorica paranoica, di certo non si capisce in quali condizioni storiche e sociali questa retorica si ripropone come strumento ideologico efficace. Sono proprio questi limiti che spiegano oggi il ritorno a Hofstadter: se, come suggerivano Koyré o Arendt, le teorie del complotto producono estremismo politico, la critica epistemologica del complottismo fa presto a sostituirsi all’analisi e alla lotta politica. Se è compito degli storici e degli scienziati difendere la verità e la razionalità, richiamarsi a questi valori a sostegno di un orientamento ideologico o equipararli alla difesa dello status quo politico è rischioso. Si tratta di una vera e propria mistificazione ideologica che, lungi dall’essere efficace, non fa che confermare i peggiori sospetti dei complottisti, oltre a costituirsi anch’essa come forma di anti-politica.
Prendendo le distanze da questa critica, non si tratta di sottovalutare il pericolo che rappresentano le teorie del complotto. Si tratta invece di ritrovare un quadro politico entro il quale questi fenomeni si collocano. Non è solo nell’impoverimento culturale o nelle bolle informazionali dei social che ne vanno cercate le cause, bensì nell’incapacità di dare una risposta politica alla crisi che sta attraversando il neoliberalismo. Le sue politiche economiche e sociali creano delle disuguaglianze senza precedenti e rappresentano gli interessi di una parte sempre minore della popolazione. Ciò vuol dire che le forze politiche che rappresentano questi interessi possono sempre più difficilmente vincere elezioni senza assicurarsi il sostegno di chi subisce queste politiche. È in questo contesto che le teorie del complotto diventano sempre più centrali, offrendo una razionalizzazione del disagio sociale e trasformandolo in energia politica. Da Trump a Salvini, questa è ormai diventata la formula ideologica del tardo-neoliberismo, che ha rotto definitivamente con le sue vecchie radici anti-autoritarie.
Paradossalmente, è nella psicologia che si possono trovare gli strumenti per andare oltre la patologizzazione del complottismo e costruire una prospettiva storica e politica, e in particolare nella corrente della psicologia esistenziale che ha cercato di porre il problema della paranoia in termini di rapporto dell’individuo con il mondo. Il giovane Lacan o Binswanger, per esempio, hanno concepito questa condizione non come il sintomo di una personalità morbosa o di una patologia individuale, ma come un fenomeno relazionale legato al collasso del rapporto dell’individuo con la società e con il mondo, che può verificarsi in certe situazioni di crisi. Il sentirsi in balìa di potenze invisibili e oggetto di manipolazioni, la perdita del senso dell’agire e il vanificarsi del mondo come realtà agibile e ospitale, riflette un’ansia esistenziale – ciò che Ernesto De Martino definì «la paura di non esserci più». Come aveva intuito, le teorie del complotto danno una forma a questi sentimenti. In una situazione di precarietà economica sempre più diffusa, di rischio ambientale generalizzato e di pandemia globale, questa paura di non esserci sta diventando la condizione antropologica del nostro tempo. In questo contesto, la lotta contro il complottismo e contro i suoi risvolti politici non può limitarsi a una lotta culturale sulla scienza e sulla verità, ma per diventare una vera lotta contro il fascismo deve essere anche una lotta politica sulle garanzie della vita.
___________________________________________
Note bibliografiche
Arendt, H. Le origini del totalitarismo, Einaudi, Torino, 2009.
De Martino, E. La fine del mondo. Contributo all’analisi delle apocalissi culturali, Einaudi, Torino, 2019.
Hayek, F. «Scientism and the Study of Society», articolo pubblicato in tre parti, Economica vol. 9, n. 35, 1942, pp. 267-291; vol. 10, n. 37, 1943, pp. 34-63; vol. 11, n. 41, 1944, pp. 27-39.
Hayek, F. La via della schiavitù, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2011.
Hofstadter, R. «Lo stile paranoico nella politica americana», Rivista di politica, n. 1, 2012.
Koyré, A. Riflessioni sulla menzogna politica, De Martinis & C., 1994
Popper, K. La società aperta e i suoi nemici, 2 vol., Armando Editore, Roma, 2004.
Sunstein, C. & A. Vermeule, «Conspiracy Theories: Causes and Cures,» The Journal of Political Philosphy vol. 17, n. 2, 2009, pp. 202-227.
Zambelli, P. Alexandre Koyré in Incognito. Leo S. Olschki, Firenze, 2016.