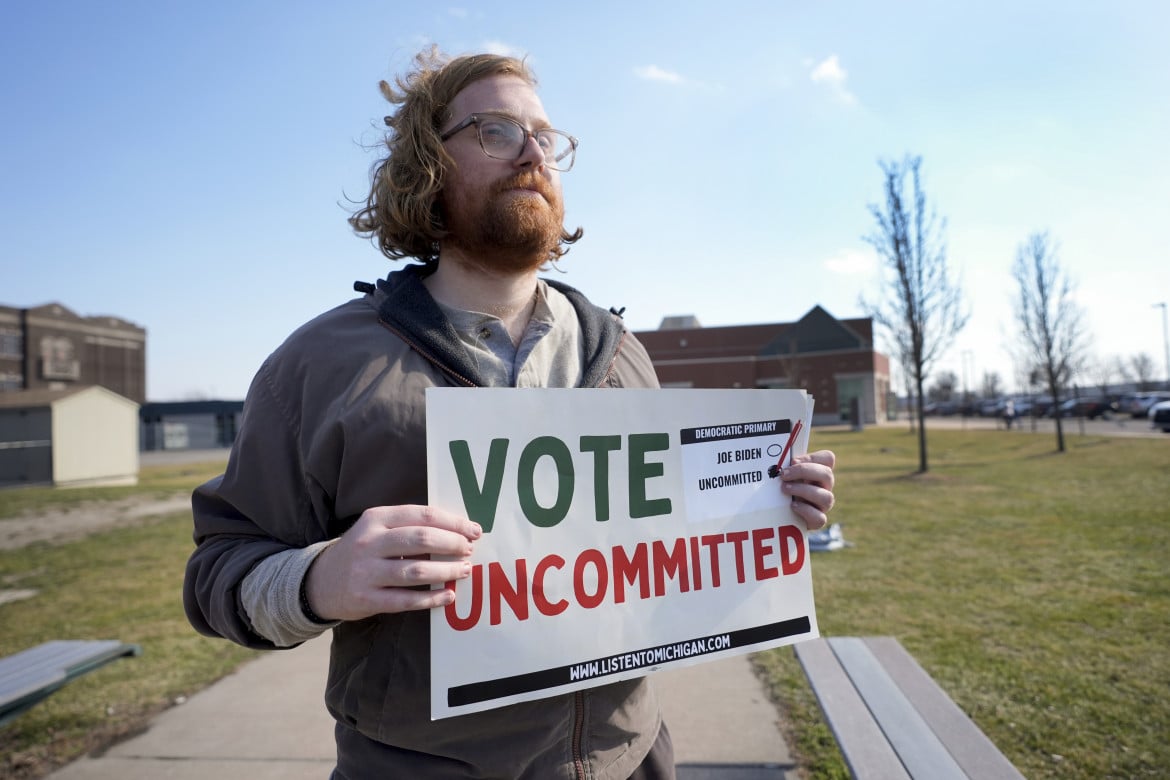Le convention sono da tempo eventi studiati per la televisione e questa di Cleveland non fa eccezione: le speranze dei giornalisti per un vero spettacolo, uno scontro di candidati, votazioni a ripetizione, magari una spaccatura del partito sono andate deluse già il primo giorno e i cronisti politici hanno dovuto accontentarsi del discorso di Melania Trump, scopiazzato da quello di Michelle Obama nel 2008, con qualche urlaccio dalla platea quando l’apparato ha impedito un voto procedurale sulla libertà di voto dei delegati, che avrebbe potuto creare imbarazzo. È una convention in tono minore, date le numerose assenze dei big repubblicani, ma comunque alla fine proietterà, per quanto possibile, l’immagine di un partito unito dietro al suo candidato alle presidenziali.
Questo risultato era prevedibile, nonostante le chiacchiere sul movimento NeverTrump e sulle minacce dei neoconservatori di abbandonare il partito: la spaccatura tra repubblicani e democratici si colloca nel profondo della società americana, dove è in atto da tempo un processo di autosegregazione politica e spaziale: se sono democratico voglio che i miei figli vadano in scuole progressiste, che i miei vicini di casa siano democratici e che il mio dentista sia democratico. Se sono repubblicano i democratici mi fanno paura, non li voglio vedere né in chiesa la domenica, né sul campo da tennis, né alle riunioni dell’associazione genitori-insegnanti.
Cleveland, nel 2012, ha votato per Obama, ma basta uscire dalla città in direzione Sud ed evitare Akron (dove ancora c’è una tradizione democratica come a Youngstown e nella vicina Pittsburgh, in Pennsylvania) per ritrovarsi in territorio repubblicano per centinaia di miglia. Si può viaggiare attraverso il West Virginia, la Virginia, il North Carolina, il South Carolina, la Georgia e arrivare in Florida senza mai trovare una contea dove i democratici siano in maggioranza. Un itinerario alternativo vi porterebbe fino al golfo del Messico attraverso il Kentucky, il Tennessee e il Mississippi senza incontrare più elettori democratici di quanti ce ne vogliano per riempire la palestra di una scuola superiore.
Questa apartheid volontaria rafforza la diffidenza e l’ostilità fra i due campi: è il motivo per cui gli elettori votano per il partito, sia che il candidato sia bianco, maschio e miliardario e senza esperienza politica (Trump) sia che sia una donna, in politica da mezzo secolo e già passata per la Casa bianca tra il 1993 e il 2001 (Clinton). Da decenni il Sud e le grandi praterie votano repubblicano, il Nordest e la costa del
Pacifico votano democratico. L’ultima volta in cui la California ha votato repubblicano è stato nel 1988, quasi 30 anni fa; l’ultima volta in cui il Kansas ha votato democratico è stato nel 1964, 52 anni fa. Nello Utah, i democratici vengono esibiti come curiosità, a San Francisco i repubblicani li mostrano ai turisti come fossero souvenir.
Una prova di questo sta nel cosiddetto Split Ticket Voting, cioè il voto per un candidato democratico alla presidenza e uno repubblicano in Congresso, o viceversa. Questo «voto disgiunto» raggiunse il massimo nel 1972, quando il 30% degli elettori scelse questo comportamento. Da allora, è diminuito costantemente: 26% nel 1984, 24% nel 1992, 19% nel 2000, 17% nel 2004 e appena 10% nel 2012.
In novembre, quindi, gran parte dell’America voterà come sempre e questo è il motivo per cui Trump, con le sue buffonate, le sue proposte improbabili (il muro al confine con il Messico) e la sua politica estera lontanissima da quella tradizionale dei repubbblicani rimane un candidato competitivo. Tutto si deciderà nei swing states, gli stati come l’Ohio dove spostamenti relativamente piccoli di voti possono far prevalere un candidato a danno dell’altro. Sono appena otto su 50, anche se insieme rappresentano 33 milioni di votanti, un quarto del totale. Si tratta di quelli dove nel 2012 lo scarto tra Obama e Romney è stato inferiore al 6%: Florida, North Carolina, Ohio, Virginia, Colorado, Pennsylvania, New Hampshire e Iowa. Gli ultimi tre sono generalmente favorevoli ai democratici: l’ultima volta che la Pennsylvania ha dato una maggioranza ai repubblicani fu nel 1988.
Anche Nevada, New Hampshire e Iowa sono «contendibili» ma è più probabile che restino nel campo democratico. Per entrare alla Casa Bianca, Trump dovrà vincere in almeno quattro di questi cinque stati: Florida, North Carolina, Ohio, Virginia, Colorado. Possibile? Sì, il 2016 è un anno dove può succedere di tutto, basti pensare a ciò che è accaduto nelle primarie, agli attentati a ripetizione, alla guerra civile strisciante fra poliziotti e giovani afroamericani. Trump ha già indicato che, dopo gli attacchi contro la polizia a Dallas e a Baton Rouge, farà campagna sul tema dell’ordine pubblico, come Richard Nixon nel 1968. Nixon non era un candidato «simpatico» e spaccava il Paese: ma vinse, favorito dalla crisi dei democratici. Quest’anno la discordia e la confusione sono nel campo repubblicano ma Hillary Clinton non è popolare e non ispira fiducia, quindi il suo vantaggio è fragile.
Ciò che lavora per lei è la demografia: la base sociale di Trump sono i maschi bianchi che non sono andati all’università, che sono molti e sono frustrati da decenni di incertezza della loro condizione economica e di sconfitte della loro cultura religiosa e conservatrice. Sono però troppo pochi per compensare il peso elettorale delle donne (che votavano a maggioranza per i democratici anche quando non c’era un candidato donna come quest’anno), degli ispanici (molto aumentati di numero e quest’anno andranno a votare in massa contro Trump) e, naturalmente, degli afroamericani. Se le previsioni vengono rispettate, Hillary dovrebbe vincere abbastanza largamente. Peccato che il 2016 non sia un anno come gli altri e che le previsioni degli analisti tendano a venire regolarmente smentite, come nel caso del referendum inglese sull’Unione Europea.