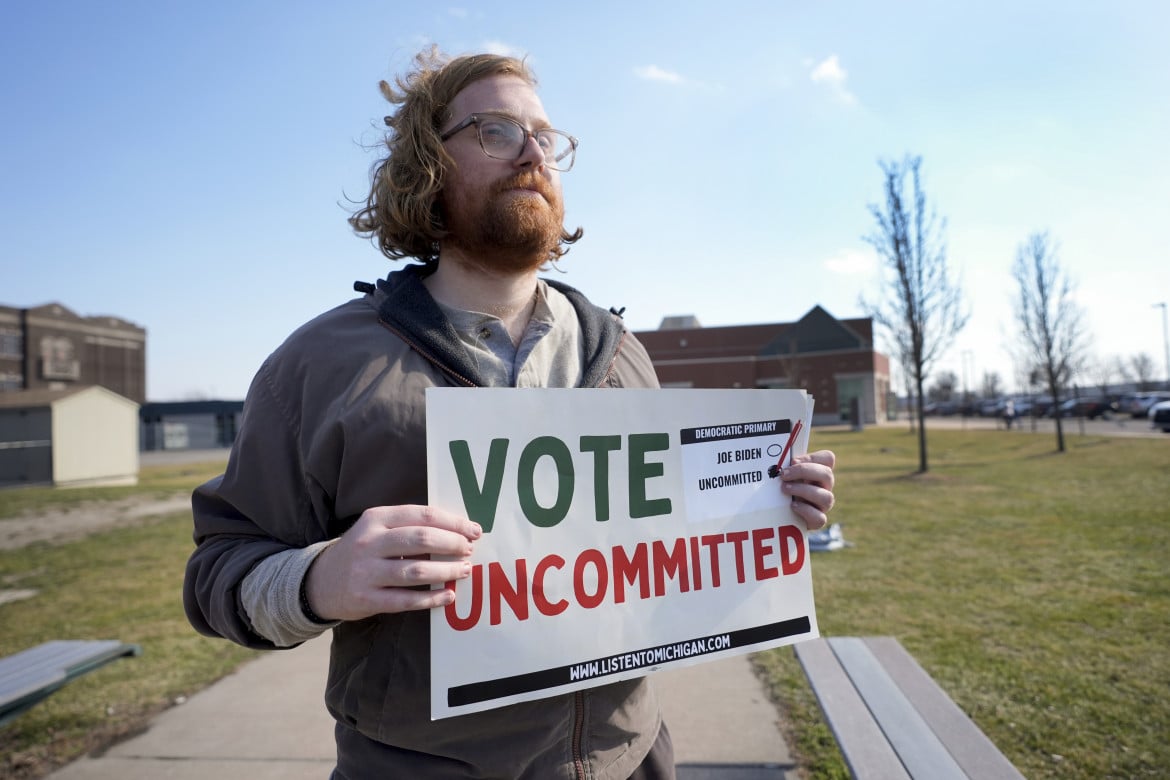Si torna a votare nelle convulse primarie presidenziali americane. Le elezioni di oggi in cui si conteggiano anche Ohio, Illinois e Florida potrebbero rivelare molto sulle effettive possibilità di Bernie Sanders, e se sia matematicamente inevitabile la vittoria di Trump o se esiste uno scenario plausibile in cui gli altri repubblicani abbiano ancora una possibilità di sbarrargli la strada. Se pure così fosse, probabilmente al massimo potranno sperare di negargli la maggioranza di delegati necessari a vincere direttamente la nomination. Sarebbe il preludio ad una convention “aperta” in cui il partito finirebbe per dilaniarsi. Solo l’ultima di una serie di possibili varianti – ognuna ugualmente disastrosa per i repubblicani.
Intanto le proteste di Chicago e di Dayton e i ripetuti episodi di violenza e contestazione che si registrano nei comizi di Donald Trump stanno dimostrando l’effetto tossico di una demagogia bullista, fondata sulla rabbiosa esclusione degli “altri”. Gli episodi hanno altresì offerto lo spunto per lo scalpore indignato quanto ipocrita degli avversari, mai prima al disopra essi stessi di identiche strumentalizzazioni. Al di là dell’attuale variante celodurista di Trump, il teorema della destra è infatti al solito predicato sulla paura necessaria a generare il panico per offrire a scudo il confortante pugno di ferro: i muri per bloccare le orde ammassate ai confini e i bombardamenti a tappeto per asfaltare i barbari che tramano la nostra distruzione.
Un egemonismo “primario” e indiscusso fa quindi parte del familiare copione riproposto nuovamente dai repubblicani per succedere alla “dottrina Obama”, il termine coniato da The Atlantic nell’articolo dall’omonimo titolo la scorsa settimana. La lunga analisi di Jeffrey Goldberg che si avvale di numerose interviste col presidente e suoi advisors, parte dalla decisione di Obama di non bombardare la Siria dopo che Assad ebbe usato gas nervino contro civili di Goutha nel 2013, per ampliare l’analisi alla politica internazionale sotto Obama.
Goldberg fa il ritratto di Obama come moderato pragmatista che seppe trasgredire in quella sede all’“imperativo morale” dell’egemonismo americano, la regola per cui ogni debolezza è un invito ai nemici e la forza l’unica tutela agli “interessi nazionali”. Obama, che ha inaugurato il proprio mandato con l’apertura “ideologica” al mondo arabo al Cairo, avrebbe poi ripiegato sempre più su un pragmatismo moderato portando a termine la promessa elettorale di “chiudere” le guerre di Bush in Iraq e in Afghanistan. Dinnanzi alle primavere arabe ha deciso di non scendere in campo a fianco di antichi alleati come Mubarak e compiuto un passo indietro come principle potenza egemonica regionale. Un calcolo influenzato dalla diminuita importanza strategica delle riserve mediorientali di petrolio alla luce del boom energetico alimentato dal fracking in Usa ma anche dalle lezioni acquisite nel “pantano” ereditato da Bush.
In questo scenario la catastrofica operazione anti Gheddafi, affidata alla fallimentare gestione di Hillary Clinton e degli alleati europei («shit show» o spettacolo di merda nella valutazione espressa dallo stesso presidente a Goldberg) , sarebbe semplicemente servita a rafforzare le avversioni mediorientali di Obama, sempre più interessato ad altri, quadranti geopolitici più politicamente fruttiferi che non a un conflitto “irrisolvibile”. Obama che ha aperto a Cuba e siglato l’accordo sul clima, spinto il trattato di libero commercio asiatico (TPP), che vorrebbe ancora chiudere la Guantanamo simbolo di una precedente politica che ha sconfessato, ha anche aperto all’Iran. Il trattato codifica la non proliferazione ma di fatto altera equilibri regionali ossificati e osa contrariare alleati precedentemente “indiscutibili”; le tensioni mai così alte con Israele e l’Arabia dei Saud ne sono la dimostrazione.
Nell’equazione manca l’occultamento della guerra, non tanto smessa quanto trasferita alla gestione occulta di Cia e forze speciali ed affidata alla massiccia escalation di missioni telecomandate per mezzo di droni. E la crescita di Isis e la riaffermazione della Russia come potenza regionale di riferimento, entrambi sviluppi che gli vengono imputati dagli avversari politici in questa stagione elettorale.
Obama afferma: «Se ci comparate a precedenti superpotenze, agiamo meno in base al semplice auto interesse. Siamo interessati a stabilire norme per il beneficio di tutti. E se è possibile salvare vite e far bene a un costo accettabile, lo faremo sempre». Ma è utile ricordare che dalla politica del «big stick» di Teddy Roosevelt alle attuali operazioni (militari americani sono attualmente stanziati in oltre 150 paesi!) le spedizioni a tutela della sacrosanta sicurezza nazionale, dalla invasione di Cuba e delle Filippine alle ingerenze golpistiche della guerra fredda, hanno sempre finito per beneficiare sinergicamente anche gli ubiqui interessi di mercato delle imprese Usa.
È difficile dire che questo sia fondamentalmente cambiato nell’America di Obama. Eppure c’è questo da considerare. L’egemonia americana si fonda su ideologie eccezionaliste e manicheiste che risalgono ai pellegrini, i profughi religiosi integralisti la cui conquista ambiva a costruire la «scintillante città sulla collina» (il sermone preferito e spesso rievocato da Ronald Reagan). Sono concetti e una disposizione che i giovani americani assorbono tuttora con gli alzabandiera nelle elementari – il giuramento di fedeltà all’inizio di giorno scolastico in ogni aula delle scuole dell’obbligo e in questi giorni nei comizi elettorali repubblicani.
Il fatto che Obama abbia comunque scalfito, se non invertito, modificato la rotta in alcuni punti chiave non è da sottovalutare. Anche perché ci sono ottime probabilità che il suo successore, chiunque sia, non sarà altrettanto disposto a farlo.