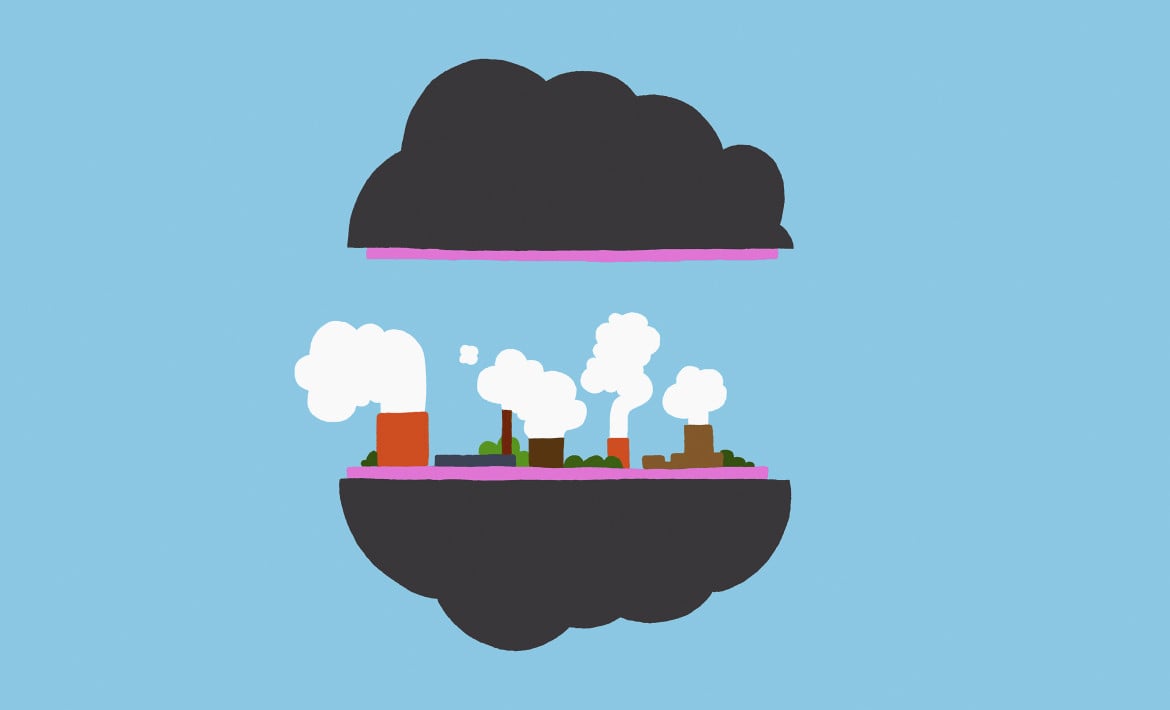È senz’altro vero che nelle condizioni date l’intervento dello Stato dovrebbe indirizzarsi verso gli investimenti e, in maniera diretta, verso i redditi dei ceti popolari, a mezzo di trasferimenti monetari permanenti ed incondizionati.
Non solo. Per fronteggiare la dura crisi occupazionale verso cui stiamo andando incontro, lo Stato dovrebbe assolvere ad una funzione di «occupatore di ultima istanza» per dirla con Hyman Minsky.
Si otterrebbero due risultati importanti: un rilancio dell’economia e una maggiore giustizia sociale. Che poi, come è stato ampiamente dimostrato, proprio nell’aumento delle disuguaglianze sta la principale chiave di lettura del fenomeno della «stagnazione secolare», riconsiderato nei suoi aspetti attuali dopo la Grande recessione del 2007-2013, con contributi molto interessanti da parte dei principali economisti americani e non solo.
Com’era prevedibile, la crisi «dal lato dell’offerta e della domanda» sta virando sempre più verso una crisi alimentata dall’insufficienza della seconda.
La gente è uscita di casa, ma spende di meno, perché il reddito è diminuito, e perché il timore del precipitare della situazione induce fisiologicamente alla prudenza per quanto riguarda gli acquisti (propensione al risparmio).
Ecco perché c’è bisogno che spenda di più lo Stato: un congruo incremento della spesa del settore pubblico determinerebbe un incremento più che proporzionale del reddito, con conseguenti e rilevanti effetti sui redditi di una molteplicità di individui, oltre che sulla fiducia degli operatori economici e dei cittadini.
Purtroppo, però, il dibattito sulla crisi sta prendendo, di nuovo, una strada sbagliata. In Italia, soprattutto.
Bonomi e la Confindustria stanno martellando a testa bassa per avere soldi, incentivi, sgravi e contratti più flessibili; il governo si fa concavo e promette attenzione prioritaria alle «ragioni» dell’impresa, col ministro Gualtieri che, addirittura, sposa pubblicamente la tesi della parte datoriale secondo cui i posti di lavoro si tutelano con più lavoro precario.
E se Conte, in base ad un ragionamento corretto, lancia l’idea di una riduzione dell’Iva, ecco il Pd che rilancia con la minestra riscaldata del cuneo fiscale da tagliare, ovvero meno tasse alle imprese, come se gli ultimi dieci anni non fossero mai esistiti.
Ma è così difficile rendersi conto (e prendere atto) che, nonostante tutti i miliardi spesi in incentivi e misure di detassazione per le imprese in questi anni, siamo arrivati all’appuntamento col coronavirus – pur volendo escludere un giudizio sulla qualità del lavoro e sui livelli di povertà ed esclusione sociale – sfiancati e con un’economia in quasi-recessione?
Se la coperta è corta, meglio gli investimenti in settori strategici e un ruolo attivo dello Stato nella creazione di lavoro e nel sostegno al reddito delle famiglie. Ma tra Conte e il Pd, meglio Conte.
A differenza delle inutili e fallimentari misure dal lato dell’offerta già largamente sperimentate in questi anni, una diminuzione ragionata dell’Iva aumenterebbe il potere d’acquisto di salari, stipendi e pensioni. E, a differenza del taglio del cuneo fiscale – e di varie forme di sgravi o detassazioni a favore delle imprese -, il minore gettito per il bilancio Statale potrebbe essere, in questo caso, più che compensato dall’aumento della produzione, a sua volta indotto dall’aumento dei consumi.
Attualmente in Italia ci sono quattro aliquote dell’Imposta sul Valore Aggiunto, dal 4 al 22%. Un intervento selettivo, intelligente, potrebbe consistere non solo nel taglio delle aliquote più alte, ma anche in una redistribuzione delle merci tra le varie aliquote, spostando verso le aliquote più basse alcuni prodotti alimentari (carne, pesce, pasticceria) ed altri comunque indispensabili, non «voluttuari» nel senso assoluto (come calzature, vestiario, elettrodomestici).
Per quanto indiretta, sarebbe una misura per il popolo, che avrebbe un senso nel discorso abusato ed ipocrita sul «taglio delle tasse», il terreno sul quale, con tutte le differenze del caso, si registrano da anni le più ampie convergenze tra le principali forze politiche del Paese.