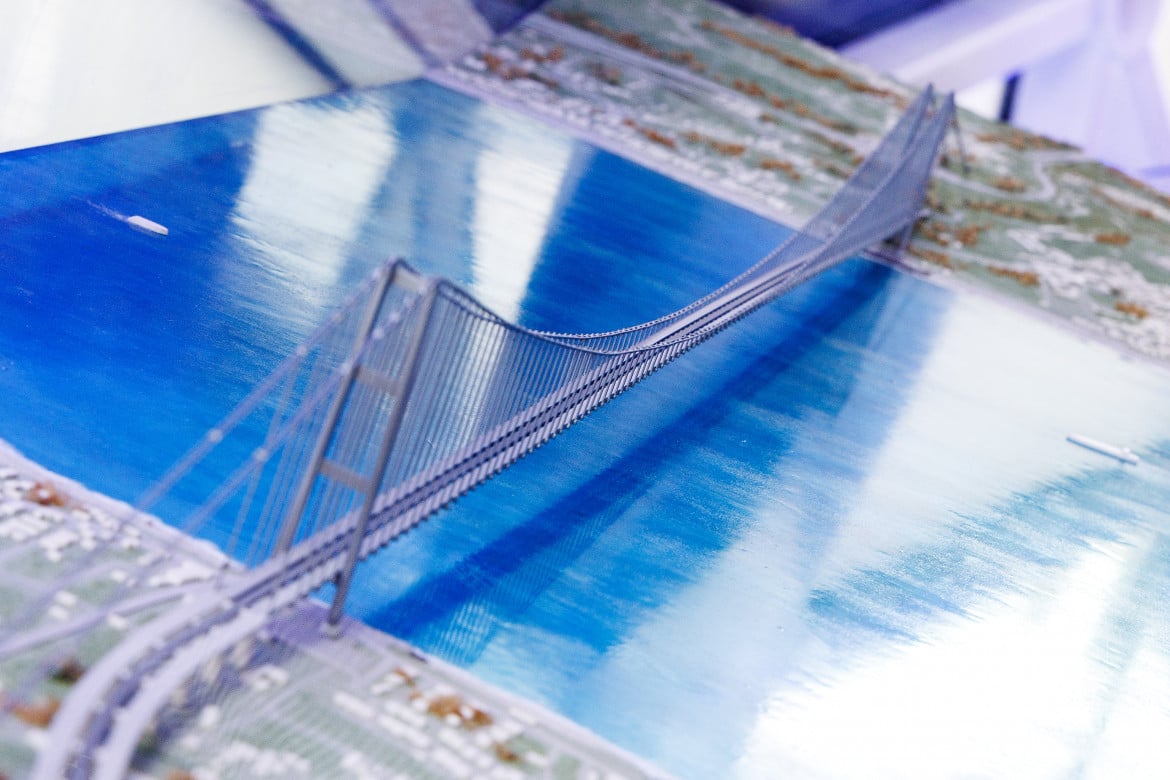Se il Pentagono dice che i cambiamenti climatici costituiscono una minaccia per la sicurezza, su chi cadranno le bombe degli Usa? La battuta circolava già a metà ottobre, quando il ministro della Difesa degli Stati uniti, Chuck Hagel, ha illustrato il rapporto sul riscaldamento globale, definito «una minaccia immediata e un moltiplicatore di minacce». Un discorso pronunciato durante la Conferenza dei ministri della Difesa delle Americhe che si è tenuta in Perù. Naturalmente, qualcuno ha ricordato che Hagel, quand’era senatore, aveva cercato di affossare il protocollo di Kyoto, il trattato internazionale sulla riduzione di gas a effetto serra, che gli Usa non hanno firmato. E che Washington produce 1/4 delle emissioni mondiali. E poi ancora che il rapporto dei militari – preoccupati per il moltiplicarsi dei conflitti ambientali e per le conseguenze («malattie infettive, disastri umanitari, mancanza d’acqua, carestia e guerre civili, nonché per l’innalzamento del livello del mare che minaccia alcune basi militari Usa) – difficilmente otterrà dal Congresso i finanziamenti necessari per far fronte alle nuove emergenze. Già prima delle elezioni di medio termine, disastrose per Obama, il presidente era stato attaccato dai conservatori per aver finanziato un rapporto sul clima piuttosto che sull’Isis, figuriamoci ora.
Le 20 pagine del “2014 Climate Change Adaptation Roadmap” suggeriscono però alcune riflessioni che si proiettano sulla Cop 20, la Conferenza delle parti Onu sul cambiamento climatico, che si conclude domani a Lima, in Perù. Dai 10.300 delegati, provenienti da 195 paesi, ci si attende un documento comune per ridurre il crescente riscaldamento globale. Una piattaforma che farà da base alla Cop21, prevista tra un anno a Parigi per sostituire il protocollo di Kyoto, considerata determinante. A novembre, Stati uniti e Cina, grandi inquinatori, hanno raggiunto un accordo per ridurre il gas serra: Washington ha promesso di portare la produzione di Co2 tra il 26% e il 28% entro il 2025. E Pechino ha assicurato che, entro il 2030, produrrà il 20% dell’energia da fonti rinnovabili. Questo potrebbe rendere più promettente e meno rituale l’incontro annuale in corso: almeno nel togliere peso all’argomento solito usato dalle grandi potenze per giustificare la propria inazione: cominci prima l’altro. E ora l’India, che ha riconosciuto apertamente il serio problema che rappresenta l’inquinamento per il paese (anche peggiore di quello in Cina) e ha manifestato l’intenzione di rendere pubblici i dati sulla qualità dell’aria, ha annunciato nuove norme sulle emissioni per le centrali elettriche.
Per frenare la corsa del pianeta verso la catastrofe, occorre ridurre dal 40 al 70% le emissioni di gas a effetto serra da qui al 2050. Ma ammesso che tutti i 190 trovino un accordo efficace, si dovranno stabilire i meccanismi di sorveglianza delle riduzioni e le sanzioni. E la questione è sempre la solita: chi controlla i controllori?
Il commercio delle emissioni è anche un grande business, che promette di riservare qualche briciola ai paesi in via di sviluppo attraverso i meccanismi della compensazione. E la cosiddetta economia verde (i contributi degli stati al Fondo verde sul clima sono comunque ancora ben lontani dai 10 miliardi annunciati nel 2009), senza un governo delle risorse che coniughi diritti economici e diritti della natura, giustizia sociale e ambientale, rimane consegnata a tutta la sua ambiguità. Lunedì, la delegazione delle Filippine (paese colpito dal ciclone Hagupit) ha chiesto a tutti i paesi l’impegno a ridurre le emissioni: «compreso a quelli in via di sviluppo», comprensibilmente preoccupati di dover pagare con la propria crescita i costi dei grandi inquinatori.
I movimenti sociali, sostenuti da alcuni governi socialisti come il Venezuela (dove si è svolto l’incontro internazionale dei popoli sul clima) propongono perciò un cambio di indirizzo, un’inversione di tendenza nel modo di produzione: «Cambiare il sistema per cambiare il clima», ha detto il presidente venezuelano Nicolas Maduro durante l’ultimo vertice Onu sul clima. E il Venezuela ha puntato il dito sulla devastante tecnica del fracking, utilizzata massiciamente negli Stati uniti per estrarre petrolio a basso costo e inondare i mercati, facendo scendere il prezzo del barile. A Lima erano presenti anche grandi multinazionali del petrolio. Intorno al clima, s’intrecciano problemi politici e finanziari. E’ arrivato anche il presidente messicano Henrique Pena Nieto, fortemente messo in causa dopo la scomparsa dei 43 studenti per le sue politiche neoliberiste che certo non intralciano gli interessi dei grandi inquinatori. Nell’ambito della Conferenza, Nieto deve parlare di affari con Barack Obama a proposito dell’Alleanza del Pacifico, di cui il Messico è perno centrale, insieme a Perù, Colombia e Cile.
Imporre un altro modello produttivo, all’insegna del «buen vivir» e non del profitto, implica un altro modo di governare le risorse e di ridistribuirle.
I movimenti, che hanno effettuato una marcia e diverse riunioni per elaborare una legge da proporre ai negoziatori, chiedono ai governi un impegno concreto: in termini di scelte politiche rispetto ai propri territori e alle multinazionali intenzionate a sfruttarli senza controllo. Le organizzazioni popolari peruviane accusano il doppio discorso del governo di Ollanta Humala: apparentemente ambientalista, ma in pratica assai disponibile ad assecondare le grandi imprese estrattive. Oltre il 40% della superficie del Perù è destinato all’estrazione del petrolio e del gas. Il 96% dei territori su cui agiscono le imprese estrattive è abitato da popolazioni native, e la conflittualità è molto alta. La lotta delle popolazioni ha portato all’interruzione di un centinaio di progetti. Il Perù è tra i paesi più vulnerabili agli effetti del cambiamento climatico, anche perché non ha la capacità di riparare in tempi brevi i danni: di «adattarsi» (altro tema su cui si discute alla Conferenza). Secondo cifre ufficiali, il paese sta perdendo il 22% dei suoi ghiacciai (in meno di 10 anni il Quelccaya potrebbe scomparire), flora e fauna dell’Amazzonia potrebbero estinguersi e i danni all’agricoltura già si vedono.
Le popolazioni indigene, i contadini e le loro organizzazioni come il Movimento senza terra del Brasile hanno portato il tema del possesso della terra e di un’agricoltura famigliare come antidoto allo sfruttamento intensivo. «Il cambiamento climatico minaccia le prospettive di sviluppo del paese», ha detto il presidente boliviano Evo Morales intervenendo alla Conferenza. «Si deve raggiungere un nuovo accordo anticolonialista – ha detto ancora – basato sul rispetto della vita e della madre terra, e in questo possiamo seguire le regole dei paesi indigeni: non rubiamoci lo spazio atmosferico». Morales ha poi invitato le popolazioni a non farsi usare dai falsi difensori dell’ambiente. Ma intanto, circola una petizione a lui indirizzata in cui gli si chiede di intervenire «per fermare i progetti di energia nucleare civile, del fracking e per fermare la deforestazione in Bolivia».