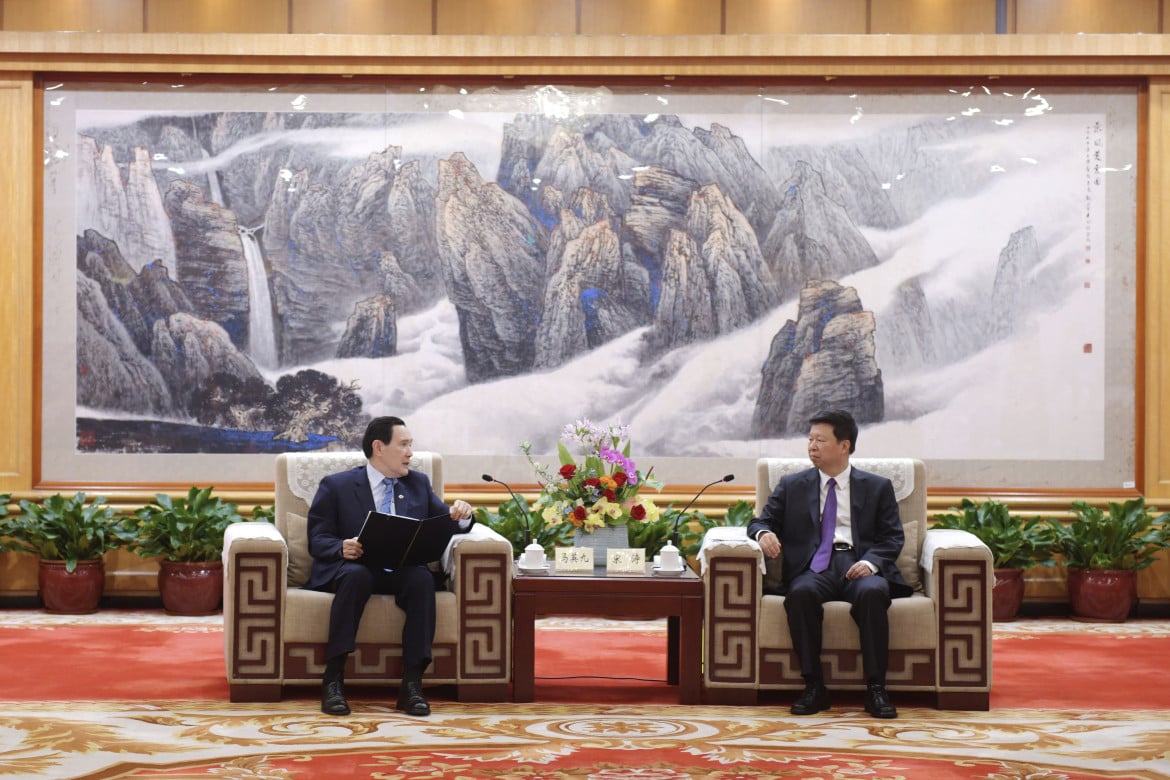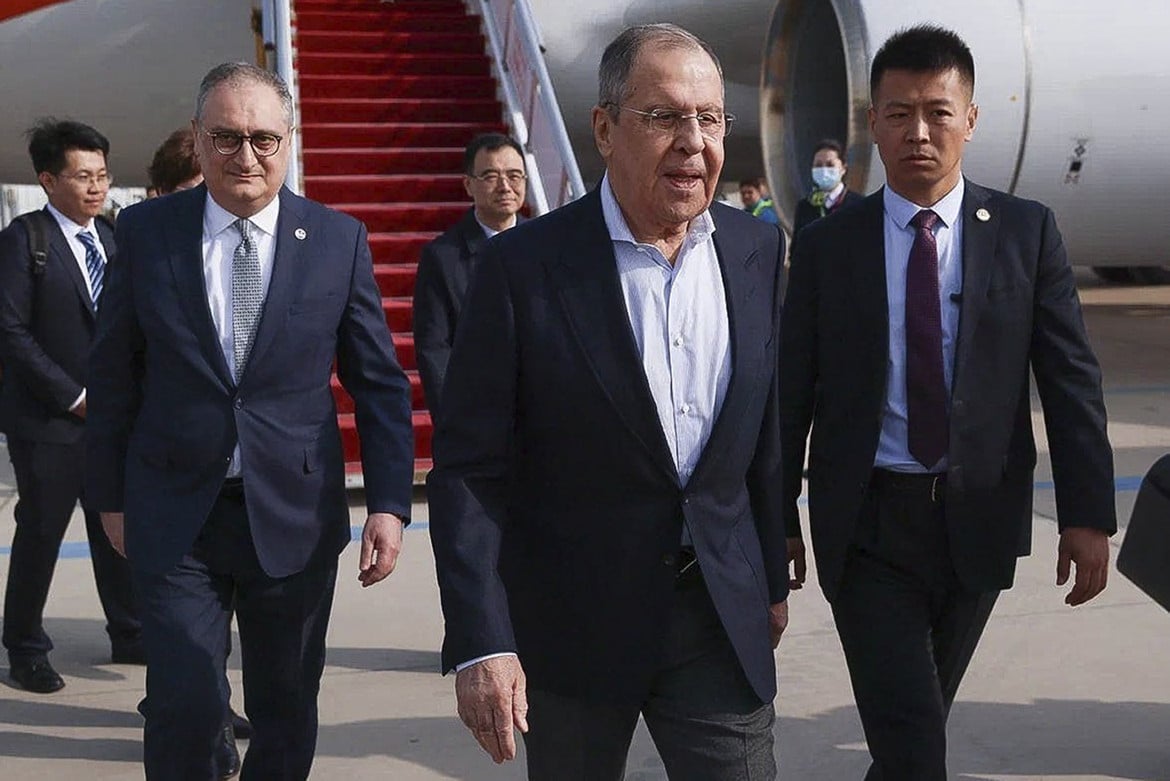Nella regione nordoccidentale cinese dello Xinjiang vive la minoranza uigura, un’etnia turcofona e musulmana.
Attualmente gli uiguri nella regione sono circa 11 milioni. Da alcuni anni Pechino ha trasformato quel territorio, antico passaggio carovaniero della Via della seta, in un immenso laboratorio sociale che – secondo alcuni studiosi – sconfina ormai nell’esperimento totalitario puro e semplice.
LA POSIZIONE DELLO XINJIANG ne determina la storia: come sosteneva Fernand Braudel, «non esiste un problema sociale che non sia da inserire nel suo quadro geografico». Analogamente lo Xinjiang, «in un’ottica non sinocentrica, ha un suo carattere dominante», dettato dal ruolo di «condotto» che ha sempre svolto: «luogo di transito, intermediario ideale ed inaggirabile tra culture e popoli diversi», come scrive Alessandro Rippa in Cuore dell’Eurasia, il Xinjiang dalla preistoria al 1949 (Mimesis, 2015).
La regione, non a caso, è la maggiormente sorvegliata del paese; in ogni zona delle città sorgono posti di polizia: telecamere ovunque, territorio militarizzato e talvolta chiuso all’esterno.
[do action=”citazione”]Oltre a una serie di disposizioni ufficiali nei confronti dell’etnia uigura, esiste poi un’operazione di natura «educativa», secondo quanto comunicato dal partito comunista: almeno un milione di cinesi di etnia han, quella maggioritaria, sono stati mandati in Xinjiang all’interno di un programma chiamato United as One Family.[/do]
Il loro compito è trasformarsi in «parente» di una famiglia dello Xinjiang, installarsi in casa e diventare un cittadino-poliziotto, il loro compito risulta fondamentale non solo per monitorare, ma anche per condannare. Un milione di impiegati statali, dalle grandi aziende di stato alle agenzie di stampa statali, stanno controllando ed educando a una cultura patriottica, in mandarino e con il sentimento devoto a Xi Jinping, un’intera popolazione, stabilendone infine un giudizio. Gli uiguri ritenuti in odore di terrorismo, vengono spediti nei campi di rieducazione.
LA PRIMA CAMPAGNA fu lanciata nel 2014, quando oltre 200mila membri del partito comunista sono stati mandati nei villaggi dello Xinjiang all’interno del piano Visiting the People, Benefit the People, and Bring Together the Hearts of the People. Nel 2016 ci fu una seconda ondata, di almeno 110mila impiegati statali. Nel 2017 una terza ondata, per un totale di circa un milione di persone.
Con la tecnologia, la polizia e l’esercito, Pechino pratica un controllo capillare sulla regione; con le persone, esercita un controllo invasivo, estenuante, interminabile. E infine condanna i colpevoli ai campi di rieducazione.
Per Darren Byler che ha intervistato alcuni di questi cinesi che decidono di fare la parte del boia «educato», si tratterebbe di una vera e propria operazione di natura totalitaria: «La tirannia che si sta realizzando nella Cina nordoccidentale – scrive il ricercatore dell’università di Washington ed esperto di Xinjiang sul sito Chinafile – mette insieme gruppi di cittadini cinesi l’uno contro l’altro in un processo totalitario che cerca di dominare ogni aspetto della vita, (…) producendo un’epidemia di isolamento e solitudine, mentre famiglie, amici e comunità vengono separati. Quando vengono introdotti nuovi livelli di non-libertà, il progetto produce nuovi standard di ciò che conta come normale e banale».
Le persone con cui il ricercatore ha parlato, inoltre, non sembrano porsi problemi riguardo la propria funzione, giustificando il proprio operato con parole che richiamano epoche sinistre: «Obbedisco a ordini e faccio il mio lavoro».
IL LORO LAVORO È IL SEGUENTE: osservare le famiglie uigure e assicurarsi che parlino mandarino, che abbiano il poster di Xi in casa e che non dicano o facciano cose sospette, specie con riferimento alla religione.
Questa pesante operazione di controllo e repressione nasce perché Pechino ritiene che nello Xinjiang ci sia il rischio di «terrorismo», giustificato di recente, secondo il Pcc, dal numero degli uiguri segnalati in Siria (numeri sui quali esistono molti dubbi: secondo alcune ricerche si tratterebbe in realtà di poche centinaia di persone). Lo Xinjiang è una regione fondamentale per la Cina: è la più estesa, confina con otto stati, è una frontiera vitale per Pechino. E lo sarà ancora di più negli anni a venire, in quanto snodo fondamentale della via della Seta. Pechino vuole non solo pacificare la regione ma anche riempirla di «spirito» imprenditoriale han.
Come ricorda il guru e investitore nel mondo tech cinese Kai Fu Lee, gli imprenditori cinesi hanno sviluppato una sorta di «mentalità» – maturata nelle particolari condizioni del mercato cinese – che ormai il governo vede come necessaria al proprio sviluppo. Conta anche quanto c’è nella regione: Alessandro Rippa ricorda infatti che «nella zona del Taklamakan si trovano giacimenti di petrolio, gas naturale, carbone, ferro e minerali che sostengono di fatto lo sviluppo cinese». Fu nella zona desertica del Lop Nor in questa regione, inoltre, che Pechino portò avanti i propri test nucleari e batteriologici fino al 1996.
LO SPOPOLAMENTO della regione della sua componente etnica uigura, rappresenta dunque un ventaglio di differenti esigenze da parte della dirigenza del partito comunista.
GIÀ NEL 2008 A URUMQI si poteva intravedere quanto sarebbe successo. Nelle zone della città popolate dagli uiguri (una minoranza nel capoluogo) imperversavano mercati, moschee, contrastate dalle parti «cinesi» della città fatte di ipermercati, palazzoni, compound squadrati. Al «Parco del popolo», parlando con alcuni uiguri, si poteva registrare la vicinanza a forme di repressione di qualsiasi famiglia uigura di Urumqi.
Il periodo era precedente alle olimpiadi a Pechino nel 2008. C’erano stati alcuni attentati, i militari presidiavano le strade. Con la presidenza di Hu Jintao (dal 2002 al 2012) Pechino aveva dimostrato di saper usare la militarizzazione del territorio, e se necessario, il pugno di ferro. Nel luglio del 2009 in Xinjiang scattò una sorta di insurrezione: alcuni gruppi di uiguri presero ad attaccare con violenza gli han; l’esercito e la polizia risposero. Centinaia di morti sul campo, centinaia seguiranno per le condanne a morte.
Nel 2009 la zona fu sigillata: era impossibile mettersi in contatto con chiunque e riportare quanto stava succedendo. All’epoca a Pechino gli uiguri preferivano non parlare, mentre gli han erano certi di quanto stesse avvenendo: gli uiguri, si diceva, stavano dando la caccia al «cinese». Il motivo scatenante degli scontri erano state le cariche su un corteo di qualche precedente che chiedeva un’indagine vera sulla morte di due uiguri uccisi nel Guangdong.
CON LA REPRESSIONE MILITARE, però, Pechino – in linea generale – aveva scelto la strategia che fino ad allora sembrava la migliore: all’epoca ai cinesi sembrava che pagando, si potesse ottenere qualsiasi cosa.
Solo nel 2017 Pechino ha investito oltre 80 miliardi di dollari nella regione, più 19,6 per cento rispetto all’anno precedente. Nel 2012 – intanto – era arrivato al potere Xi Jinping e diversi fattori hanno operato per una sua soluzione più muscolare a tutto tondo (nel 2014 ci furono di nuovo scontri che di fatto finirono per legittimare le recenti politiche di Pechino nella regione).
LA POLITICA DI XI JINPING ha inoltre potuto contare su novità recenti in Cina: Big Data e intelligenza artificiale sono diventati una straordinaria arma di controllo, prevenzione ed eventualmente di repressione. Human Rights Watch aveva già denunciato il programma di raccolta dati – compreso il Dna – in atto nella regione autonoma cinese a fronte della sperimentazione di veri e propri modelli predittivi: «Per la prima volta, scriveva Hrw, siamo in grado dimostrare l’uso, da parte del governo cinese, di Big Data e di una predicting policy che non solo viola in maniera evidente i diritti alla privacy ma autorizza i pubblici ufficiali a procedere ad arresti arbitrari».
[do action=”citazione”]Di fronte a queste operazioni, «le persone nello Xinjiang non possono opporre resistenza o contrastare la crescente intrusione nella loro quotidianità. Molti non sanno nulla di questo programma e non sanno come funzioni». Per l’organizzazione, il ricorso alle tecnologie più moderne ha consentito alle autorità di attuare controlli sempre più profondi.[/do]
UNO DEI «CERVELLI» dietro l’«esperimento Xinjiang» è senza dubbio l’attuale segretario del partito nella regione. Si tratta di Chen Quanguo, classe 1955, arrivato in Xinjiang dopo essere stato segretario in Tibet. Si devono a lui – si dice – tanto la sperimentazione delle nuove forme di controllo sociale, quanto l’aumento dei prigionieri nei campi di lavoro. È di sicuro una sua invenzione il posizionamento sul territorio delle convenience police station, stazioni di polizia poste ovunque in grado di controllare in maniera pervasiva le città. È stato sotto la guida di Chen che la polizia ha avuto un picco di assunzioni e di acquisto di materiale tecnologico per rendere il controllo sociale sempre più sofisticato. In un solo anno, lo Xinjiang ha fatto annunci per oltre 90.866 posizioni legate alla sicurezza, (dodici volte il numero nel 2009).
PER QUANTO RIGUARDA I CAMPI di rieducazione, lo stesso partito comunista ne ha riconosciuto l’esistenza. In una recente intervista alla Xinhua, il governatore della regione ammette l’esistenza, ma per il Pcc in questi luoghi tutto è bello; gli «ospiti» studierebbero e imparerebbe a sganciarsi dall’abbraccio feroce del terrorismo. Secondo altri le cose sono ben diverse. Jerome A. Cohen, uno dei massimi esperti mondiali del sistema legale cinese, ha definito i campi «il più grande programma di detenzione di massa in Cina da 60 anni».
SUL SUO SITO HA SCRITTO: «Forse l’ultima volta che così tante persone sono state detenute al di fuori di un processo formale è stato nella campagna anti-destra del 1957-59». Conta poco, scrive Cohen, «che ciò che viene fatto dovrebbe essere inteso come una violazione dei diritti procedurali ai sensi dell’articolo 37 della Costituzione, nonché delle varie libertà sancite dalla Costituzione».
Il caso dei campi di rieducazione e della schedatura di massa è emerso nel luglio del 2018, grazie alla testimonianza di una cinese di etnia kazaka, Sayragul Sauytbay, scappata dallo Xinjiang nel Kazakhstan. Secondo la sua testimonianza, «Lo chiamano un campo politico, ha raccontato, ma in realtà era una prigione in montagna».