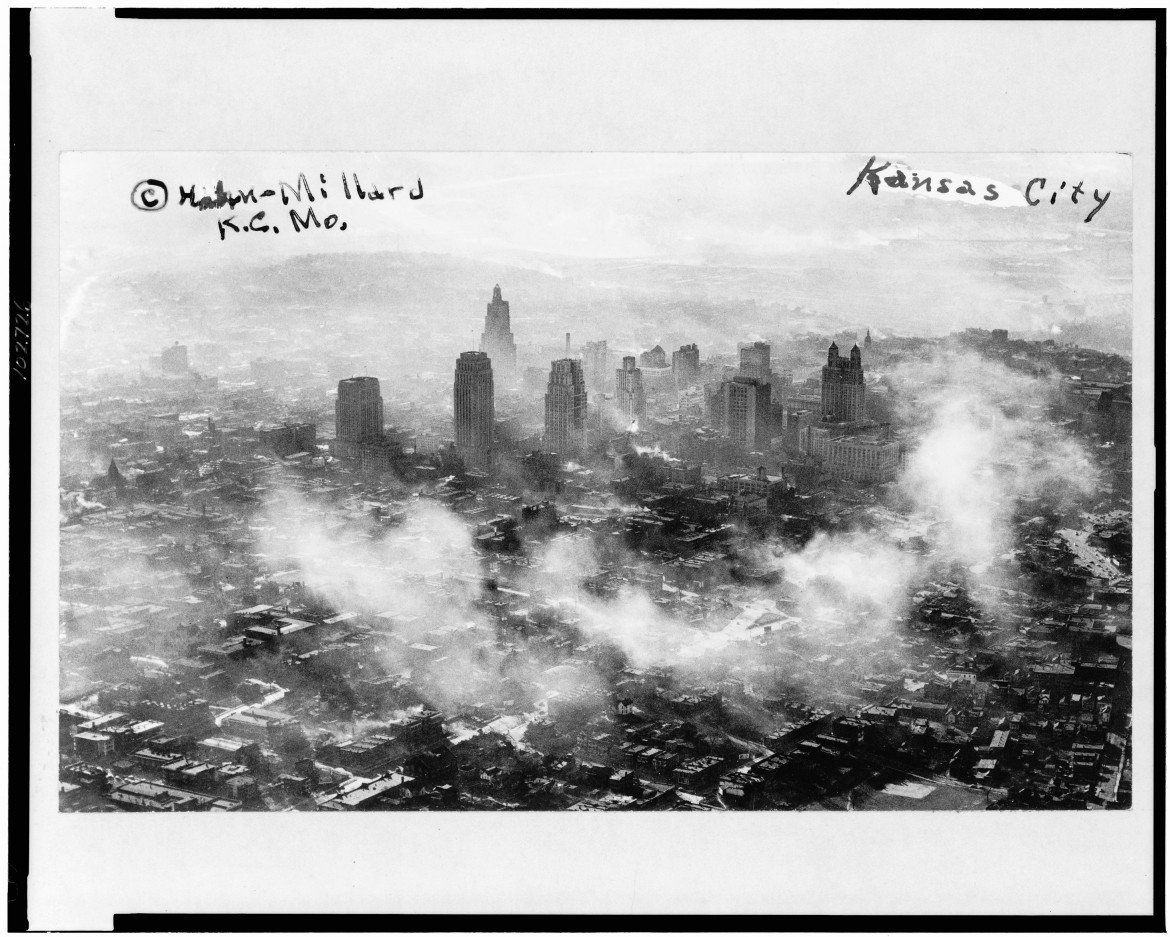Per indagare sulle milizie anti-immigrati ha passato giorni e notti lungo il confine tra Messico e Stati uniti, indossando una mimetica, con una radio in spalla e una carabina Roger Mini-14 tra le braccia. Per scoprire perché migliaia di detenuti avevano iniziato uno sciopero della fame in tutto il paese, ha vestito la divisa dei guardiani in una delle prigioni private più vecchie e temute del profondo sud.
Per Shane Bauer il giornalismo è una questione di pelle e non solo di principi. Se per arrivare a scoprire qualcosa c’è bisogno di mettersi in gioco fino in fondo, lui non si tira indietro.

36 anni, già studente di Berkeley, giornalista investigativo di Mother Jones, una delle voci più significative della stampa progressista, dopo aver lavorato a lungo in Medioriente per diverse testate statunitensi e aver passato, dal 2009, quasi due anni nelle prigioni iraniane insieme ad altri due free-lance, Bauer – che è stato quest’anno tra gli ospiti del Festival di Internazionale a Ferrara -, ha indagato alcuni degli aspetti più inquietanti della realtà del suo paese, dove la violenza, il feticismo per le armi e le ideologie dell’odio dominano la scena, fino a comporre il ritratto di una società violenta in cui si può morire ogni giorno quasi per caso.
Reporter di guerra in Medioriente e giornalista investigativo in patria, come sono andate le cose?
Quando sono tornato nel mio paese, dopo aver passato molto tempo tra Kurdistan, Iraq, Siria e Iran, mi sono accorto che solo un lavoro sotto copertura mi avrebbe consentito di arrivare alle informazioni che volevo; far luce su delle realtà scomode o complesse. Erano in corso rivolte e scioperi della fame in diverse prigioni e ho capito che solo entrando in quei posti avrei potuto documentare quello che accedeva. La stessa cosa è successa con le milizie: solo dall’interno potevo capire cosa covava in quegli ambienti. E non è stato neppure difficile. Per il posto da guardiano ho inviato una domanda e mi hanno preso in un paio di settimane, mentre per contattare le milizie mi sono creato un profilo facebook e con quello ho conosciuto dei militanti. Nessuno mi ha fatto troppe domande. Qualcosa ho certamente rischiato, ma alla fine è andato tutto bene.
Il no all’immigrazione ha portato Trump alla Casa Bianca; lei ha passato mesi tra i miliziani della «3% United Patriots» lungo il confine con il Messico. Gruppi pericolosi e legati in che modo con la politica?
Le milizie paramilitari «patriottiche» sono nate nella prima metà degli anni Novanta ma hanno conosciuto uno spettacolare revival dopo l’elezione di Obama. Nelle loro fila ci sono anche dei suprematisti bianchi, ma più che la questione razziale in quanto tale, la loro vera ossessione sono i migranti irregolari e il timore che le autorità possano regolamentare il possesso di fucili e pistole. Per lo più si tratta di maschi bianchi della working class, xenofobi e anti-musulmani, ostili anche a movimenti come Black Lives Matter e alle femministe. Si fidano poco dei politici, ad esclusione del solo Trump, e si stanno preparando al peggio, addestrandosi come un esercito.
Nel 1995 da simili gruppi emersero i responsabili della strage di Oklahoma City. Una storia che rischia di ripetersi?
Quel terribile attentato che fece 168 vittime fu compiuto da persone che si opponevano a Washington e al presidente dell’epoca che era Bill Clinton, mentre oggi gli estremisti sembrano in sintonia con la Casa bianca. Temo piuttosto un conflitto all’interno della società, che i razzisti se la prendano con chi si oppone loro, come è accaduto a Charlottesville il 12 agosto. E la grande circolazione delle armi può fare il resto, alimentando nuove stragi di innocenti, come accade ogni settimana.
Lei ha seguito anche un recente raduno della Alt-Right, si tratta di un ambiente così lontano da quello delle milizie?
In questo caso abbiamo a che fare con dei giovani del ceto medio, spesso si tratta di studenti universitari che hanno avuto a lungo come obiettivo quello di una rielaborazione ideologica del vecchio suprematismo bianco. I gruppi della Alt-Right operano nei campus e sui social mescolando riferimenti alla Storia americana e alla nuova destra europea. Perciò, si tratta di un ambiente diverso da quello delle milizie, anche se oggi, grazie alla presenza di Trump, tutte queste realtà finiscono per battersi per le stesse cose: contro la sinistra, contro gli immigrati e i musulmani.
Prima di infiltrarsi tra le milizie, ha fatto per 4 mesi il guardiano in una prigione privata della Louisiana. Ha capito qualcosa in più del suo paese?
Certamente, che si tratta di una società violenta e ingiusta. Quel carcere si trova in una contea povera di uno Stato tra i più poveri del paese. I lavori più ambiti sono la segheria, Wal-Mart e il carcere. La vita dentro la prigione era durissima, regolata solo dalla logica del profitto. Gli stipendi dei guardiani erano da fame e i detenuti che stavano male non erano portati in ospedale perché altrimenti bisognava pagare le spese del ricovero. C’era pochissimo personale, spesso ragazzini appena usciti da scuola. Ho visto molta violenza, ma soprattutto disinteresse, anche da parte della direzione. Il responsabile delle guardie ripeteva di continuo, «che senso ha rischiare la pelle per meno di 9 dollari all’ora. Se i detenuti si vogliono accoltellare a vicenda, lasciamoli fare».
Ma nell’America delle «fakenews» e di Trump c’è ancora spazio per il giornalismo investigativo?
In realtà credo che proprio ora questo lavoro possa assumere un significato ulteriore. Ogni volta che delle informazioni su un soggetto di interesse pubblico non sono ottenibili altrimenti, il muoversi sotto copertura diventa l’unica strada. Le inchieste sulle prigioni private e sulle milizie non avrebbero potuto essere realizzate in altro modo. Sono convinto che il nostro ruolo come giornalisti sia quello di chiedere conto a chi detiene il potere di quello che sta facendo. E forse questo è il momento più opportuno per farlo.