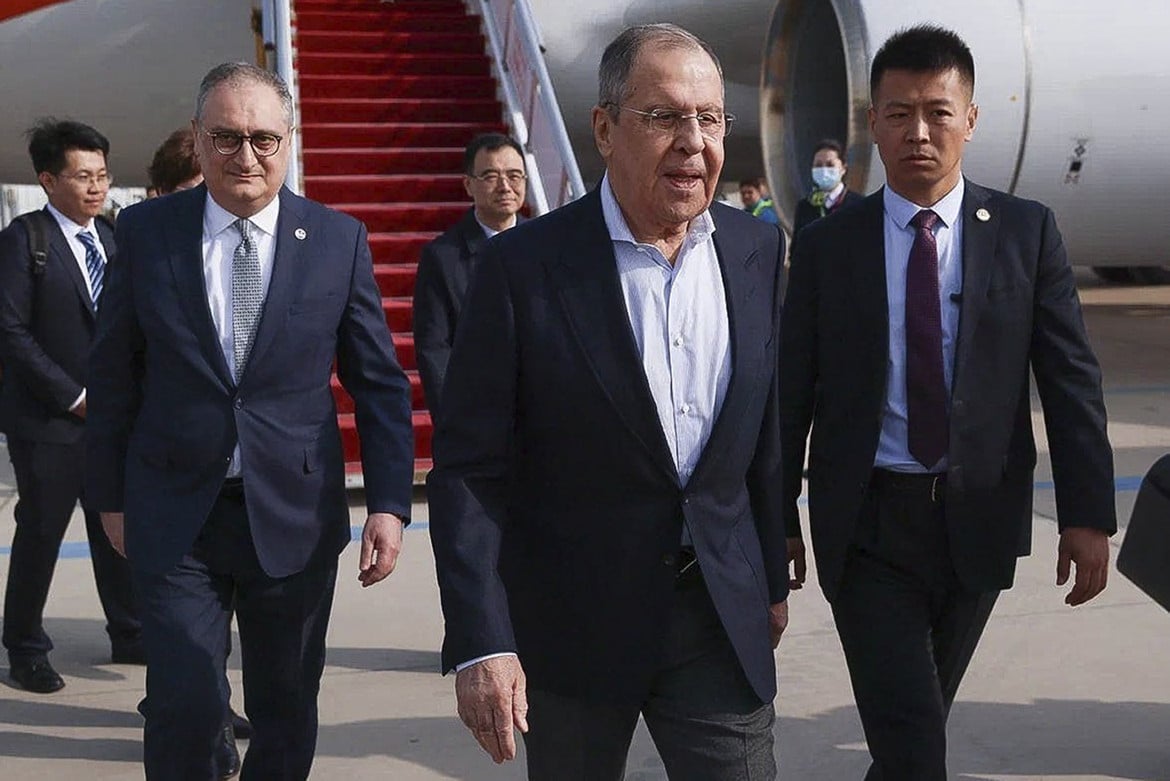Sono le canzoni che cantava in macchina fin da bambina, seduta a fianco della madre o della nonna mentre correvano da una parte all’altra delle campagne del Kansas per non arrivare in ritardo all’ennesimo lavoretto sottopagato. In Una forza della natura (Black Coffee, pp. 154, euro 20, traduzione di Federica Principi) l’appassionata indagine che ha dedicato a Dolly Parton e al modo in cui ha dato voce e per molti versi incarnato le donne della working class e delle zone rurali d’America, Sarah Smarsh ha pagato molto più che un debito affettivo contratto nella propria giovinezza. La giornalista e scrittrice che ha già raccontato con straordinaria forza la storia delle donne della sua famiglia in Heartland (Black Coffee, 2021) rende questo complice omaggio ad una delle figure più importanti della storia della country music, autrice della gran parte delle canzoni che ha portato al successo nel corso di una carriera iniziata alla fine degli anni Sessanta, un inedito viaggio tra le vite, i sogni e le lotte delle donne della classe lavoratrice degli Stati Uniti.

Lei definisce Dolly Parton una «femminista implicita», una donna che ha espresso con le proprie scelte quel femminismo che le appartenenti alla working class, specie nelle campagne, hanno praticato a partire dal loro quotidiano pur non avendo modo di incrociare il movimento delle donne né le sue teorizzazioni.
Da femminista, attivista e donna che è nata e cresciuta nelle campagne povere del Kansas non posso fare a meno di sottolineare come negli Stati Uniti l’attivismo politico sia stato molto spesso appannaggio della classe media. Movimenti come il femminismo hanno fatto a lungo ricorso ad un linguaggio accademico esclusivo sviluppato da docenti di studi di genere o si sono basati su tattiche organizzative, come le marce indette nei giorni feriali, a cui la maggior parte delle donne della working class non avevano accesso o a cui non potevano partecipare visto che non avevano nessuno a cui lasciare i figli o non potevano prendersi una giornata libera dal lavoro. Da questa situazione deriva il fatto il femminismo di una donna della classe operaia si può presentare in modo diverso. È ciò che illustro attraverso la figura di Dolly Parton, mostrando come in molti casi queste donne abbiano partecipato della stessa lotta pur non indossando una t-shirt con uno slogan, senza partecipare ad una manifestazione e talvolta non utilizzando neppure il termine «femminismo».
Lei spiega che le donne che Parton racconta nelle proprie canzoni, come molti dei personaggi che ha interpretato al cinema – su tutti quello di Doralee in «Nine to Five» del 1980 – esprimono, pur se in condizioni molto difficili, una ricerca di indipendenza, libertà e autonomia quanto alle proprie scelte che parla alle vite di milioni di donne americane.
Senza alcun dubbio. Soprattutto i brani che hanno scandito la prima fase della sua carriera, per capirci dagli anni ’60 ai primi anni ’80, ruotavano principalmente attorno alla necessità di liberazione delle donne dai vincoli economici e culturali. Senza contare che canzoni famose come «Just because I’m a Woman» (1968) e «The Bargain Store» (1975) descrivevano il doppio standard utilizzato nei confronti della donne per giudicarle in base alla loro sessualità, mentre «Down From Dover» (1970) mostrava l’atteggiamento che la società riservava ad una donna non sposata che rimaneva incinta, mentre il suo partner poteva andarsene senza che questo suscitasse alcuna ripercussione. Queste canzoni rappresentavano all’epoca altrettante dichiarazioni radicali, tanto che alcune furono trasmesse a fatica o addirittura bandite dal circuito della radio dedicate alla country music. Ma raccontavano la storia di tante donne che conosco.

Allo stesso modo lei sottolinea come Parton abbia costruito il proprio aspetto rovesciando gli stereotipi dei quali era oggetto e facendo del suo corpo un atto di affermazione di sé, una sorta di sfida all’oggettivazione maschile.
Dolly Parton è nota per sembrare una «bambola a buon mercato». E lei è talmente consapevole della percezione che la circonda che l’ha abbracciata e coltivata fino in fondo. In questo senso si potrebbe dire che è stata la prima «femminista della terza ondata», rifiutandosi di reprimere la sua femminilità o di alterare un aspetto maschile per adattarsi al mondo plasmato dagli uomini. In quanto artista brillante prima e imprenditrice di successo poi, il suo aspetto costringe il resto del mondo a conciliare gli stereotipi negativi dell’ambiente povero e rurale da cui proviene con la donna potente e intelligente che è.
A proposito delle origine della cantante, nel corso della sua carriera sembra aver dato voce ai due istinti opposti che l’animavano: «tirarsi fuori da un luogo claustrofobico e al tempo stesso continuare ad appartenergli». Come definirebbe il rapporto di Parton con la realtà delle campagne del Tennessee da cui era fuggita per cercare fortuna a Nashville?
In un Paese enorme e con vaste aree rurali come gli Stati Uniti in molti sono costretti a lasciare la propria casa anche solo per sopravvivere o per cercare di inseguire il successo nelle grandi città. Il caso di Dolly Parton si situa a metà strada tra questi due estremi, eppure lei, per quanto avesse desiderato così tanto di andarsene, non ha mai dimenticato davvero da dove veniva. E il suo rapporto con le campagne del Tennessee orientale dove è nata e cresciuta è ancora oggi segnato da un grande affetto e anche da una sorta di riconoscenza verso le proprie radici.

Lei ha attraversato un periodo davvero molto difficile durante i suoi primi anni a Nashville. Ha lavorato duramente, suonando in ogni occasione, esibendosi con le sue canzoni anche per pochi dollari nei locali e, come ha raccontato nella sua autobiografia, è stata costretta perfino a rubare del cibo per sopravvivere. Quindi ha colto la sua prima grande opportunità come co-protagonista nello show televisivo del cantante Porter Wagoner. Brava com’era lo ha però rapidamente surclassato e ha utilizzato quell’occasione per lanciare la propria carriera. Una cosa che però all’epoca, tra la fine degli anni Sessanta e i primi Settanta, fece quasi scandalo nell’ambiente musicale. Senza contare che in un contesto nel quale le donne guadagnavano meno dei colleghi maschi e non vedevano spesso riconosciute fino in fondo le proprie capacità, la sua determinazione ad esigere i diritti di pubblicazione per le canzoni che scriveva ha rappresentato qualcosa di rivoluzionario anche per quelle che sono venute dopo di lei.

In «Heartland» ha raccontato la storia e gli sforzi fatti dalle donne della sua famiglia per una vita libera e dignitosa. Sente di avere dei punti in comune con Parton?
Come lei sono una donna progressista che nutre un profondo rispetto per la povera realtà di campagna in cui è cresciuta. L’attitudine liberal e la cultura radicata in queste campagne rappresentano probabilmente elementi tra loro in contrasto, ma la mia famiglia è composta da persone con idee innovative e una profonda attenzione per la giustizia. Allo stesso tempo, le donne che mi hanno cresciuta non potevano permettersi di perdere il lavoro e andare in città per partecipare alla Marcia delle Donne. Eppure quella determinazione e quella forza le hanno messe nelle loro stesse vite. E Dolly Parton è una delle poche celebrità che può capire davvero quell’intersezione tra classe sociale, luogo di provenienza e genere.