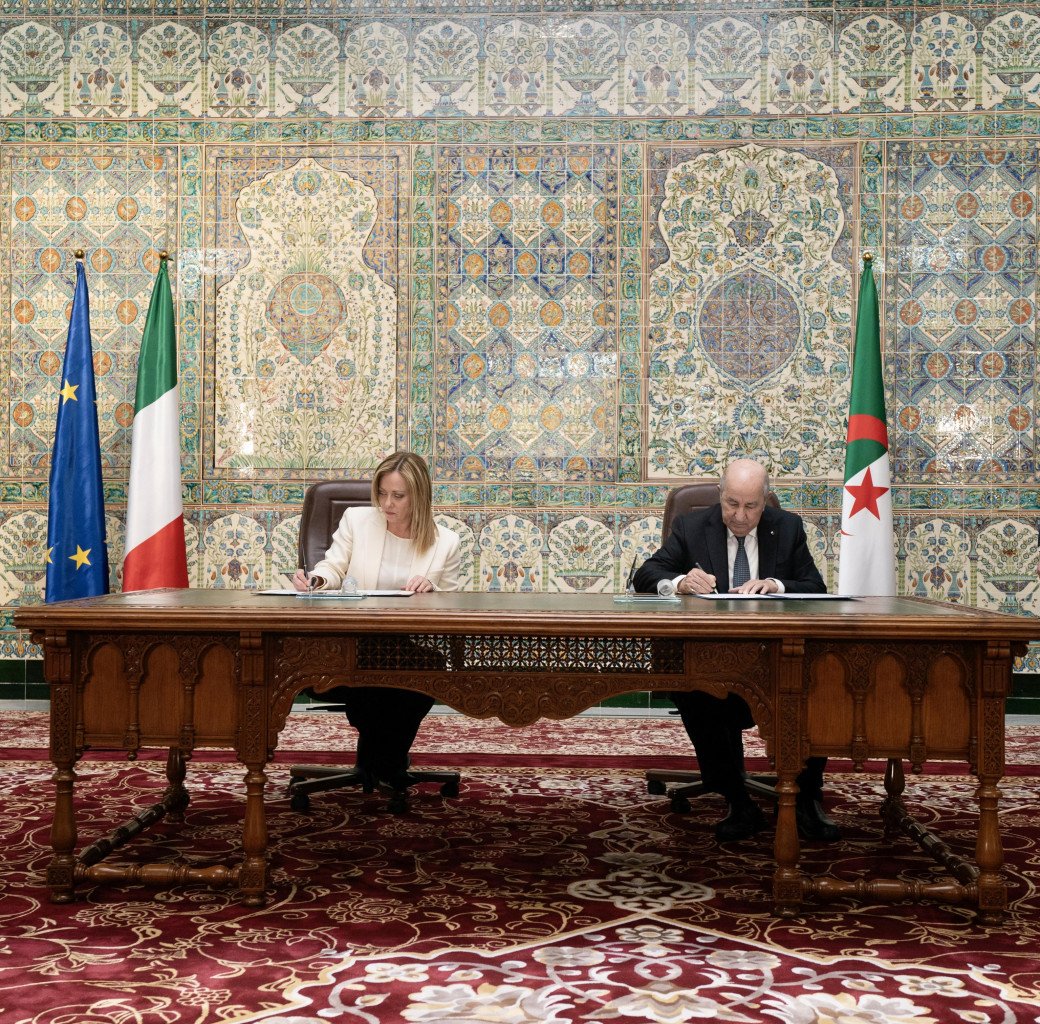Quando Non conosci Papicha è stato presentato a Cannes, nel maggio 2019, il presidente algerino Bouteflika aveva da poco rinunciato a candidarsi alle elezioni per un quinto mandato in seguito alle imponenti manifestazioni di piazza suscitate dall’annuncio della sua candidatura: «È stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso – ci aveva raccontato in quei giorni la regista del film Mounia Meddour – i cittadini, e specialmente i più giovani, si sono sentiti davvero umiliati perché Bouteflika non rappresentava più i desideri di cambiamento e le aspirazioni di una società moderna. E con l’aiuto dei social network le manifestazioni pacifiche sono diventate sempre più popolose: le persone si sentivano oppresse da un presidente che non le rappresentava».
In precedenza, il malcontento era rimasto sopito a causa del timore inculcato nella popolazione di tornare al «decennio buio» dell’Algeria, il periodo della guerra civile negli anni Novanta in cui lo scontro fra esercito e islamisti aveva mietuto decine di migliaia di vittime. Proprio l’epoca in cui è ambientato Non conosci Papicha.
La protagonista Nedjma studia lingua francese all’università di Algeri – e vive nel campus universitario con altre ragazze – ma la sua vera passione è confezionare vestiti, che vende alle amiche nel bagno della discoteca. Mentre il mondo circostante diventa sempre più ostile alla libertà femminile, rifiuta di piegarsi alle nuove regole: «Sorella, la tua immagine ci sta a cuore. Curala, altrimenti lo faremo noi» recitano i volantini che raffigurano una donna velata e che Nedjima strappa puntualmente dalle pareti dell’università. E invece che chinare la testa impaurita, decide di organizzare una sfilata delle sue creazioni.
Nei giorni in cui Non conosci Papicha faceva il suo debutto a Un Certain Regard, Meddour – che vive in Francia – era fiduciosa nella buona accoglienza del film in Algeria, dove le era stato possibile girare con il sostegno del Ministero della cultura. Candidato agli Oscar per il paese nordafricano, il film si è visto però negare il permesso per uscire nelle sale dell’Algeria a settembre, compromettendo anche la sua possibilità di partecipare ai premi Oscar – ma uno speciale permesso dell’Academy in sostegno della libertà d’espressione ha evitato che venisse escluso.
Come nasce la storia del film?
La trama di Non conosci Papicha ha una base autobiografica: negli anni Novanta studiavo giornalismo in Algeria, avevo un piccolo programma radiofonico e vivevo in una residenza universitaria dove condividevo la stanza con altre cinque ragazze. C’erano persone di ogni genere lì con me, da quelle interessate alla politica a chi pensava più alle feste: un microcosmo della società algerina di allora. Per me era importante che nella storia del film fossero inserite informazioni su quel contesto storico, sulla situazione nell’Algeria di quegli anni, e dato che vengo dal documentario volevo che quei dettagli fossero il più veritieri possibile.
È stato difficile mettere in piedi il progetto?
Inizialmente abbiamo incontrato delle difficoltà organizzative perché si tratta di una coproduzione francese, algerina, belga e qatarina. Per gli standard algerini di produzione era un budget molto importante, superiore a quanto di solito si spende per un film. Ma io volevo un buon budget perché si tratta di un lavoro in costume: abbiamo «ricostruito» l’Algeria degli anni Novanta. E anche il casting è stato impegnativo: ci sono tanti personaggi e volevo che fossero molto diversi tra loro, non solo fisicamente ma anche a livello psicologico perché riflettessero la complessità della natura umana.
Gli argomenti trattati sono ancora un tabù in Algeria?
Quello di Non conosci Papicha è un periodo della storia del Paese che è stato trattato, e raccontato, molto poco. Sono pochi i film ambientati nell’Algeria degli anni Novanta, ed è sicuramente inedito un punto di vista femminile, di resistenza, sugli avvenimenti di allora. Trovo invece che per gli algerini sia necessario riflettere su quegli anni, anche in modo da trasmetterne la storia alle nuove generazioni, per evitare che facciano gli stessi errori. Speravo quindi di riuscire ad aprire uno spiraglio su un periodo, pur recente, non abbastanza conosciuto, e specialmente sul ruolo che hanno avuto le donne nel resistere e lottare.
Una delle colleghe di Nadjima definisce l’Algeria «Una grande sala d’attesa».
All’epoca tutte le persone che incontravo erano in attesa di qualche cosa: come dice la ragazza nel film poteva essere una visita medica, un passaporto, una chiamata. Ma anche un sogno, o una storia d’amore. Non c’era evoluzione, movimento in avanti – e se c’era era terribilmente lento. La società era bloccata, nonostante la grande energia delle persone. E oggi la situazione non è migliorata: credo che questa immobilità sia alla radice delle proteste dei più giovani: una generazione ancora una volta piena di energie, ma che sente di essere impossibilitata a fare ciò che vuole, seguire le proprie ambizioni.
Nedjima però non vuole andar via, lasciare il Paese, non cova il sogno della maggior parte dei suoi coetanei.
Se si vogliono cambiare le cose bisogna restare al loro interno. Nedjima è felice in Algeria: ha un sogno da realizzare, degli amici – per questo rifiuta di andarsene. Ciò che le accade è simile alla situazione che ho attraversato in prima persona, ma a differenza di Nedjima ho dovuto lasciare l’Algeria per motivi familiari: mi sentivo in mare aperto, mi sono dovuta lasciare alle spalle tutto ciò che avevo costruito, integrarmi in una nuova società. Lei invece rifiuta tutto questo, anche se a un certo punto le viene offerto dal ragazzo con cui si sta frequentando, che le propone di andare all’estero con lui: Nedjima sa cosa vuole. Ciò che mi interessava nel fare un film di fiction era proprio avere l’opportunità di raccontare l’esperienza di donne come lei, che hanno fatto una scelta eroica per poter cambiare le cose.