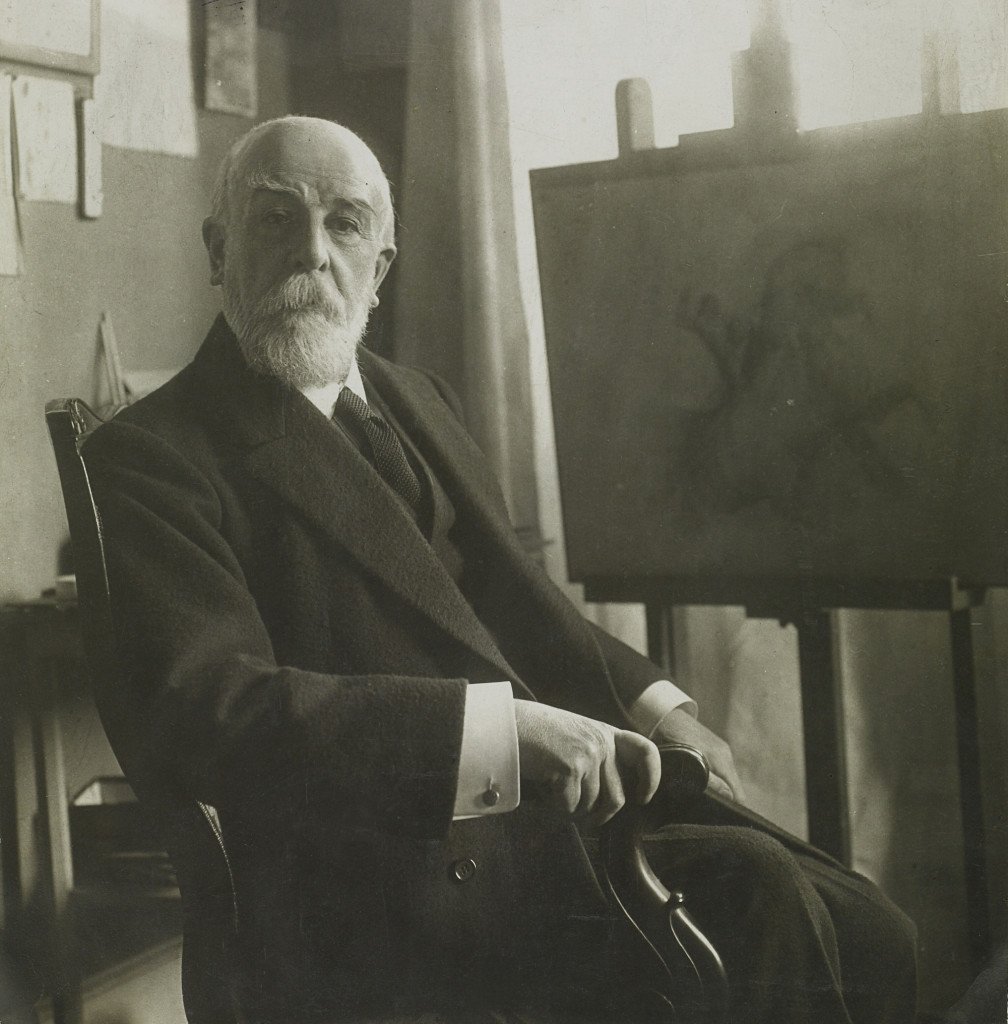

Fra le relazioni familiari nelle vite degli artisti non esiste forse caso più toccante del rapporto che legò Odilon Redon a suo figlio Arï. L’investimento particolare del padre si spiega in parte con la perdita, a poche settimane dalla nascita, del primogenito Jean, dagli «occhi imbevuti di splendore notturno»: era nato nel maggio 1886. Un anno dopo, nel suo diario, Redon esprime tutta la sua desolazione: «… nel silenzio, al primo momento indolente, il richiamo si fa sensibile e il male apre la piaga… Mi sembra che nell’ultimo giorno, quando mi addormenterò, come lui, nello stesso ignoto, delle onde invisibili, provenienti da lui e da me, si avvicineranno, si confonderanno».
Passano due anni e nasce Arï, le cui fattezze di ragazzino conosciamo dal meraviglioso cartone, circa 1897, che lo ritrae au col marin, una delle opere che meglio spiega il culto per Redon della nuova generazione, i Nabis. La dolcezza del rapporto padre-figlio, gli anni gioiosi, vengono straziati, nel 1914, dalla chiamata alle armi di Äri. L’angoscia di Odilon è tutta nelle lettere al giovane soldato al fronte, la cui diretta partecipazione, nel 1916, alla battaglia di Verdun, si rovescia sullo stato di salute del vecchio pittore: che muore nell’estrema inquietudine, senza aver potuto rivedere il figlio, il 6 luglio di quello stesso anno.
Äri non si occupò direttamente di arte. Al contrario del padre, spirito contemplativo, era uomo di velocità: appassionato di aviazione, possedeva un apparecchio. Nondimeno, rimasto a vivere nell’ultima dimora parigina di Redon (129, rue de Wagram), coltivò devotamente l’eredità paterna: assieme alla madre Camille Falte, pubblicò nel 1922, a sei anni dalla morte dell’artista, gli scritti fra diario, autobiografia e critica À soi-même (la buona edizione italiana è a cura di Stefano Chiodi, Abscondita, 2004), rivelando un grande peintre-écrivain. Äri ospitava con gentilezza, come testimoniò Roseline Bacou, autrice nel 1956 di una luminosa monografia di Redon, chiunque volesse ammirare e studiare l’insieme dei lavori rimasti di proprietà della famiglia: un nucleo di 542 numeri che Äri, senza figli, decise di legare ai Musées Nationaux, ciò che avvenne nel 1982, dieci anni dopo la sua morte: resta un catalogo, 1984, redatto con rara competenza proprio dalla Bacou.
Un aspetto poco noto dell’arte di Redon venne a essere illuminato da questo lascito: il paesaggismo, genere che l’artista aveva coltivato per la massima parte entro il 1890, in parallelo ai visionari chiaroscuri (carboncini e incisioni), i Noirs. Solo in tempi recenti, 2016-’17, con una mostra specificamente dedicata (Bordeaux, poi Quimper), il ruolo di questa produzione all’interno dell’opera complessiva ha potuto trovare verifica al vivo, nella presentazione di un notevole insieme di pezzi .
Considerando i paesaggi études pour l’auteur, come li definiva con modestia, Redon preferiva trattenerli nella sfera privata, nel chiuso del suo laboratorio. Dalle sue stesse parole sappiamo però dell’affetto da lui nutrito per queste prove, che rivestono una certa importanza nello sbocciare della sua personalità. Esse documentano la dedizione di Redon verso le espressioni fenomeniche; provano in modo incontestabile, pur nella continenza e rarefazione, che egli sente la radice del ‘fantastico’ nel dato di natura, blandito con un occhio innamorato, assediato con un singolare impegno nelle procedure tecniche. Il suo celebre assunto riferito all’invenzione dei «mostri»: «gli esseri inverosimili secondo le leggi del verosimile… la logica del visibile al servizio dell’invisibile», si comprende assai meglio prestando attenzione, come si deve, ai paesaggi.
«Mio padre mi diceva spesso: “Osserva queste nubi, non vi scorgi, come me, delle forme mutevoli?” Mi mostrava allora nel cielo variabile apparizioni di esseri bizzarri, chimerici e favolosi». È fin troppo facile, sulla scorta di una ricezione ‘letteraria’ dura a morire, che rimonta a Huysmans e fu rinforzata, e ideologicamente sigillata, dai surrealisti, trattenere, di questo ricordo d’infanzia di Redon, le «apparizioni», lasciando cadere quell’osserva. L’osservazione è il primo cruccio di un artista che nel 1864, a ventiquattro anni, volle recarsi da Corot, scelto a suo mentore: «vada ogni anno a dipingere nello stesso luogo; copi lo stesso albero». Consiglio che, con abbondanti studî d’après nature, egli seguì religiosamente. Nel segno di Corot sono i primi paesaggi au fausin: «Con alcuni tocchi di carbone sfumato che fanno cantare il colore opaco del foglio camoscio o blu, l’artista dona alle sue foreste un riflesso mobile e argentato; come Corot, egli predilige l’ora indecisa del crepuscolo e il fogliame vibrante degli alberi bianchi» (Bacou).
Può sembrare incredibile: negli stessi anni in cui Redon, sotto la spinta iniziale di Fantin-Latour, concepisce le serie litografiche che stabiliscono con le loro allucinazioni, i cambi di scena subitanei propri dell’esperienza onirica, le figure galleggianti nello spazio cosmico sotto l’imperio della Sfera, la novità clamorosa del suo linguaggio, ‘si attarda’ sui paesaggi. Li realizzava perlopiù su cartone, nel piccolo e medio formato: se ci soffermiamo, se rinforziamo poi con la lettura degli scritti che egli dedicò al paesaggio contemporaneo (fra le cronache del Salon del 1868, stese per un quotidiano di Bordeaux, e i brani specificamente dedicati comparsi in À soi-même), risulta l’esperienza singolarissima di una inattualità impregnata di futuro. I termini ideologici di questa inattualità, oggetto di un accurato saggio di Émilie Vanhaesebroucke (2016), restano abbastanza sfuggenti, nutriti insieme di istanze retrospettive (il temporeggiare sul paysage historic) e di una critica chiaroveggente dei fenomeni in atto.
L’aspra polemica di Redon con gli impressionisti a lui coetanei (Monet nacque il suo stesso anno, 1840) avverte i rischi della sottomissione al motif, della fede assoluta nella percezione ottica, in anni in cui la novità non è ancora assodata. Per un artista antiaccademico e ‘del proprio tempo’ come Redon non era facile, intellettualmente, prendere le distanze da una corrente sbeffeggiata, della cui funzione storica si rendeva perfettamente conto. Ma è troppo fedele a se stesso, ai suoi richiami interni, a «quanto palpita sotto la fronte di un uomo che si ascolta e si raccoglie». Sullo stesso Courbet, di cui nel 1882 fa una specie di apologia, non riesce a trattenere che «si sviluppò con vigore in un unico ordine di attività». Questa posizione altra farà di Redon, come si sarebbe espresso Maurice Denis, «l’ideale della giovane generazione simbolista, il nostro Mallarmé».
Cercando sponde che giustifichino il suo sentire idealizzante, Redon incrocia esperienze d’arte nobili e sommesse: Antoine Chintreuil, paesaggista allievo di Corot, «genio tenero e dolce», e soprattutto Jean-Charles Cazin, intrinseco di Puvis de Chavannes. Tenendo a freno i riflessi di un facile avanguardismo, si avrà la pazienza di addentrarsi nel «gusto morale», nelle immagini austere e temperate, sospese fa realtà e idea, di questi fini pittori di transizione, oggi remoti. Su Cazin l’investimento di Redon è speciale: «il dolce sentimento mistico (…) poteva far credere alla presenza della pittura di un primitivo sperduta tra le nostre». Fra i soggetti di storia, biblica soprattutto, fu anche pittore di dune, lande, luoghi del silenzio, eternati in un’ora crepuscolare, anzi indefinita, la cui luce spenta divenne un’antonomasia nella critica dell’epoca: «l’ora di Cazin».
Come quelli di Chintreuil e Cazin, i paesaggi di Redon, pur fedeli alle apparenze di natura, sono nondimeno stati d’animo, in linea con la tradizione romantica: essi realizzano una topografia sentimentale. Nell’antica tenuta paterna di Peyrelebade, regione della Mèdoc, capoluogo Bordeaux, l’artista aveva trascorso con un vecchio zio, lontano dai genitori, un’infanzia solitaria e sognante: racconta che, malaticcio, non poteva fare sforzi di nessun tipo, intimidito dal mondo fuori cercava riparo nel silenzio, nei luoghi d’ombra interni. Ma la Landa, che si estendeva sterminata oltre i confini del podere, esercitava su di lui l’attrazione dell’ignoto: scrive di «un oceano di terra», pensa all’Atlantico, «che copriva un tempo questi spazi deserti», che «ha lasciato nell’aridità delle loro sabbie un alito di abbandono, di astrazione»… quel mare dove aveva rischiato di nascere, nel bastimento che riportava i genitori dalla Nouvelle-Orléans.
Del territorio bordolese, fu dunque la Landa e non la Vigna a colpire la sua immaginazione: una scena madre, che torna più volte nei paesaggi, sussurrate descrizioni di un vuoto, scompartito in due fasce orizzontali, il cielo e la terra. L’agente atmosferico, oltremodo variabile, si fa specchio del cuore ma discretamente: nessuna pretesa soggettivistica. Per quanto studî, i paesaggi sono lavorati di fino, l’olio è come appoggiato, un sottile strato con lievi notazioni in punta di pennello. Giuste le riflessioni di Redon sull’importanza del formato (egli critica la sproporzione fra soggetto e misura dell’opera; rifiuta che la grande arte si calcoli in quantità di supporto), mai come in questi cartoni i centimetri utilizzati si fanno essi stessi espressione poetica.
Se la Mèdoc rappresenta per Redon il legame indissolubile con l’infanzia, segnato nel 1897 dalla vendita del maniero familiare, vissuta insieme come ferita immedicabile e liberazione creativa, altre tre regioni disegnano il ‘sentire’ dell’artista piuttosto stanziale che fu: i Paesi Baschi, nelle due dorsali della frontiera; la Bretagna; le coste charentaises, con il loro charme, la luminosità, i pini marittimi, forse il luogo di maggior serenità nell’immaginario redoniano (qui, nel delizioso villaggio di pescatori Saint-Georges-de-Didonne, fissato in due tersi tableaux, egli affittò per una decina d’anni una casa estiva dopo la perdita di Peyrelebade: villa Goa, da lui ribattezzata villa Goya).
Quattro i viaggi di Redon nei Paesi Baschi, fra 1862 e 1878: essi sollecitano la vena romantica del fervente di Delacroix. Gli appaiono «una patria antica dove, certamente, io ho vissuto, sofferto e amato». Riporta la maestà delle vette e la crosta minerale in una serie di lapis e carboncini, circa 1865, che documentano gli intensi ricordi del primo soggiorno basco, ma soprattutto l’influenza di Rodolphe Bresdin, l’incisore visionario su cui egli esemplò il suo ideale di artista negli anni di formazione. In gran parte delle opere, Bresdin ambienta le scene, bibliche mitologiche allegoriche, entro recessi montagnosi, la cui descrizione maniacale, quasi di un geologo prestato all’arte, Redon riconsidera studiosamente, per esempio nell’acquaforte La Peur del 1866.
Bresdin: per penetrare nei moventi profondi della vocazione di Redon, bisogna leggere i brani da lui dedicati a questo nato sotto Saturno dalle dita affusolate e aristocratiche, estremamente povero, che vive nell’isolamento della periferia bordolese, in una strada «di antica denominazione», rue Fosse-aux-Lions, «che egli mi faceva notare scherzando, con un sorriso». Nella bella stagione, di prim’ora, «il cielo chiaro, la luce limpida», il ventenne Redon peregrinava «lungo le stradine solitarie, dagli stretti marciapiedi», che lo portavano da lui; lì imparava i primi rudimenti, più del rame che della pietra, vedeva Bresdin attento soprattutto alla pulizia dell’operare, «circondava il liquido di riguardi…, ne eliminava tutta la polvere», funesta.
La sabbia, l’erba rasa, le ginestre spinose, le rocce, le scogliere a picco sul mistero dell’Oceano: la Bretagna, l’universo finistérien, è per Redon innanzitutto ricerca di un’anteriorità dove l’«impronta» sul «suolo che si calpesta», come scrive in una lettera alla moglie del giugno 1883, «è per così dire la prima…». Il nutrito «fondo bretone» di olî e disegni dice più che l’interesse per le antiche contrade, che pure affascinano Redon con lo scabro dei loro muri, il silenzio in cui si perdono le vie polverose, o per certe emergenze antropiche come i mulini, lo stupore dell’umana solitudine, dell’individuo perduto nel cosmo, che gli aveva suggerito, prima di avventurarsi nei Noirs, di tradurre visivamente i Pensieri di Pascal (del progetto resta una sorprendente matita, circa 1870).
«Nato nel Midi con un filo d’anima del Nord», Redon in Bretagna sente di perdere l’ubi consistam. «Bruma eterna, cielo scuro e mutevole, offuscato, agitato da venti contrastanti…»: celebre l’appunto di diario con il diapason «No, non è questo il mio paese: è triste, qui». Invece è proprio il suo paese, o almeno il paese che rispecchia in una diversa ma penetrante nuance, la profonda inquietudine metafisica del suo periodo ‘nero’, prima della riconquista del colore, sotto il segno dei fiori, nell’ultimo decennio del secolo.

