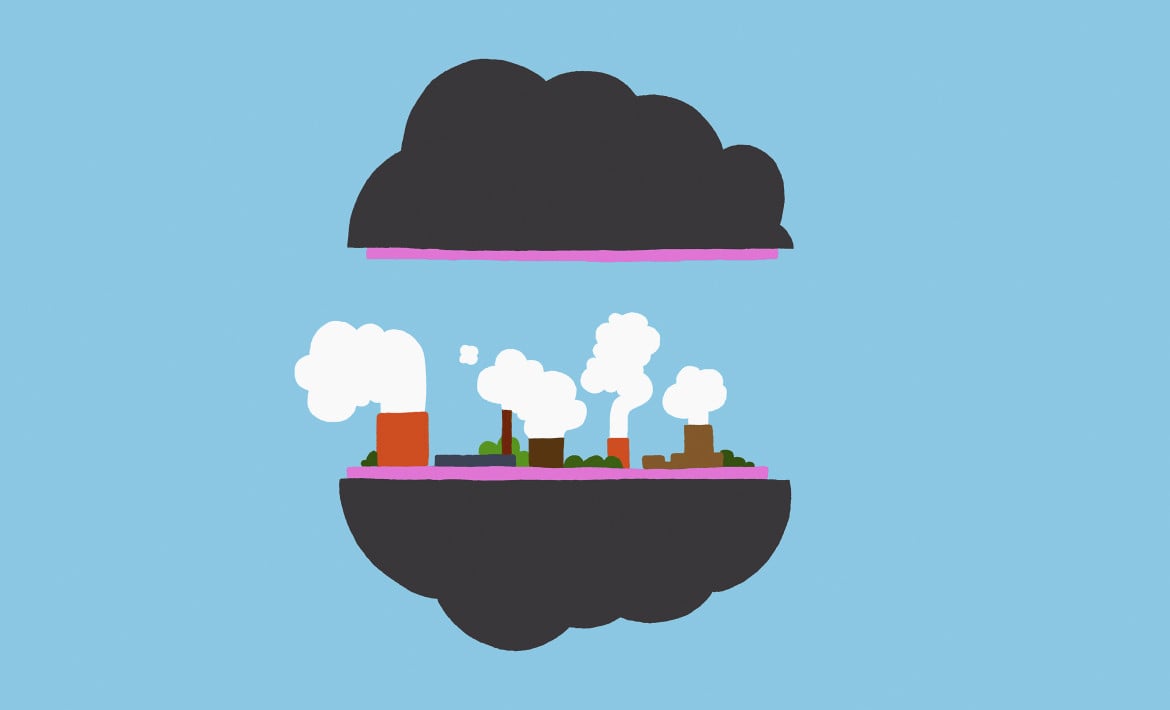Mettiamoci nei panni di un lavoratore o una lavoratrice che il 5 dicembre 2011 ha saputo di punto in bianco di dover lavorare 5 o 6 anni di più. È chiaro che la prospettiva – rafforzata da un Def con deficit al 2,4 per cento – di poterci finalmente andare con qualche anno di anticipo rispetto al traguardo sempre più lontano fissato dalla riforma Fornero sia una manna per centinaia di migliaia di persone.
Con «Quota 100» versione 62 anni di età Salvini e Di Maio contano di mandare in pensione 400mila persone, il doppio di quanti sono andati in pensione nel 2017. Una stima che pare esagerata agli esperti, specie se verrà confermato il tetto massimo di due anni di contributi figurativi, quelli che coprono i periodi di maternità o assistenza dei familiari per le donne o di ammortizzatori sociali. Un paletto non da poco che ridurrà la platea di beneficiari ben al di sotto, per qualcuno addirittura dimezzandola a 200mila.
Il ritorno del sistema delle Quote – introdotto da Cesare Damiano nel 2007 e cancellato da Elsa Fornero – è comunque un colpo duro e costoso alla riforma voluta dal governo Monti su richiesta della Bce. Il costo in manovra dovrebbe essere di 7-8 miliardi per il solo 2019.
La norma è stata fortemente voluta dalla Lega. Il perché è presto detto: la maggior parte dei beneficiari si concentra al Nord fra i lavoratori (poche saranno le donne) che non hanno subito la crisi: operai di piccole imprese e dipendenti pubblici, mentre i lavoratori autonomi rischiano di trovarsi con assegni molto bassi per i pochi contributi versati – il ricalcolo contributivo viene dato per scontato anche per ridurre la spesa.
Sotto la spinta del M5s esiste un altro capitolo di spesa previdenziale in manovra: la cosiddetta «Pensione di cittadinanza». In parallelo con l’avvio del Reddito omonimo, servirà ad innalzare a quota 780 euro al mese le pensioni di tutti coloro che hanno un assegno al di sotto. La misura costa molto meno – circa 1 miliardo – perché coloro che hanno la sola pensione sociale (453 euro nel 2018) sono pochissimi, potendo conteggiare su «integrazioni al minimo» per chi ha meno di 13mila euro di reddito o 32mila se coniugato.
Il capitolo «taglio delle pensioni d’oro» – con il ricalcolo contributivo delle pensioni sopra i 4.500 euro lordi per creare un fondo per innalzare le pensioni più basse – non è invece parte della manovra e viaggia su un binario parlamentare.
Ieri sui piani previdenziali del governo è arrivato l’anatema del presidente dell’Inps Tito Boeri che ha denunciato l’ingiustizia generazionale. «C’è una grande iniquità nelle scelte del governo sulle pensioni: ammesso e non concesso che per ogni pensionato creato per scelta politica ci sia un lavoratore giovane – ha spiegato Boeri – bisogna tenere conto che chi va in pensione oggi in media ha una retribuzione doppia di quella di un giovane».
La sortita di Boeri coglie un elemento reale – la totale mancanza di provvedimenti per giovani e precari (ormai anche 50enni) alle prese col regime contributivo che taglierà le loro pensioni – ma dimentica come il taglio dei salari sia figlio delle politiche di austerità e del Jobs act che lo stesso Boeri da presidente dell’Inps in epoca renziana non ha mai criticato. Se dunque è sacrosanto mandare in pensione chi ha lavorato una vita ed è stato beffato dalla Fornero, va garantita a giovani e precari una «pensione di garanzia» – non di «cittadinanza» – a chi è stato «attivo» per 30 o 40 anni ma ha contributi persi e sparsi a causa della crisi: la proposta di Michele Raitano garantirebbe un assegno dignitoso (980 euro con 40 anni di attività) a tutti, chiamando lo stato a pagare i contributi mancanti al momento del pensionamento. Il costo? Zero euro fino al 2040, anno che scavallerebbe la famosa gobba della spesa previdenziale. Ma né Lega né M5s ci stanno pensando.
Quota 100 premia il Nord, nessuno pensa ai precari
Pensioni. Potranno lasciare il lavoro operai e impiegati pubblici, quasi tutti maschi. Boeri attacca: è iniquo per i giovani che hanno redditi molto più bassi. Ma dimentica il Jobs act

Poche donne potranno utilizzare Quota 100 a causa del tetto di soli 2 anni di contributi figurativi
Pensioni. Potranno lasciare il lavoro operai e impiegati pubblici, quasi tutti maschi. Boeri attacca: è iniquo per i giovani che hanno redditi molto più bassi. Ma dimentica il Jobs act
Pubblicato 6 anni faEdizione del 29 settembre 2018
Pubblicato 6 anni faEdizione del 29 settembre 2018