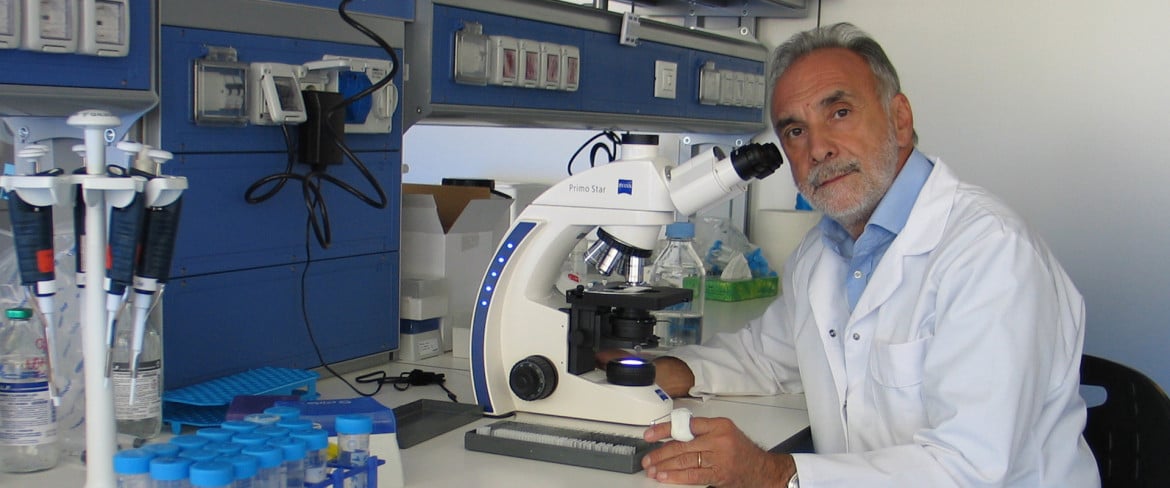Il “Mario Negri”, l’istituto di ricerca lombardo fondato da Silvio Garattini, è una delle eccellenze della medicina italiana. Oggi lo dirige Giuseppe Remuzzi, 71 anni, forse il clinico italiano più noto al mondo per le sue ricerche sui reni. L’Istituto ha sede a Milano e a Bergamo, dove Remuzzi è nato e ha sempre lavorato. Proprio dall’epicentro del focolaio italiano di Covid-19, oggi il medico offre al manifesto la sua prospettiva sull’attuale fase della pandemia, in cui i casi positivi segnano una crescita graduale ma costante in tutta Europa. «Però non bisogna confondere i casi positivi con i malati, perché spesso si tratta di persone asintomatiche, non sempre e non necessariamente contagiose. Come a marzo, l’epidemia ha tre manifestazioni diverse tra nord, centro, sud, ma oggi la situazione è rovesciata: al nord, e in particolare a Bergamo, il virus circola meno. L’Italia è messa meglio di altri paesi anche perché siamo stati più attenti con mascherine e distanziamento. Abbiamo poco più di 250 persone in terapia intensiva a fronte di circa ottomila posti letto. Quindi siamo lontanissimi dal dover essere preoccupati. Inoltre, i malati in terapia intensiva oggi hanno una mortalità del 5%, mentre a marzo avevano una mortalità del 40% negli ospedali migliori.
Abbiamo imparato a curare meglio i pazienti?
Non c’è una cura. Certo, oggi sappiamo che cortisone ed eparina sono utili, e anche il remdesivir ha un effetto positivo. Soprattutto, è calata la pressione sui reparti. Questo consente di curare molto meglio i malati. Molti malati si perdono per sepsi o sovrapposizioni batteriche che non si riesce a controllare quando il personale è esausto e deve assistere troppi pazienti.
Con l’occasione del Recovery fund si sta discutendo del rafforzamento del servizio sanitario. Bisognerebbe aumentare i posti letto in terapia intensiva?
Oggi ce ne sono dodici ogni 100 mila abitanti, meno numerosi che in Germania ma al di sopra della media europea. Secondo me non serve aumentare i posti letto ma la flessibilità degli ospedali, al fine di convertire rapidamente reparti di terapia semi-intensiva. E dobbiamo soprattutto avere il personale capace di assistere i pazienti. In ogni caso, i posti in terapia intensiva dovrebbero essere l’ultima cosa da rafforzare, se tutto il resto del sistema sanitario funzionasse a dovere. Questa malattia si sarebbe potuta curare a casa, in presenza di una forte medicina del territorio. Basterebbe attuare i principi di cura primaria fissati dall’Oms nella conferenza di Alma Ata del 1978: una concezione delle cure primarie che includeva la prevenzione delle malattie, le cure riabilitative, palliative e la salute mentale. In altre parole, occorre mettere al centro la medicina di comunità e creare un rapporto tra la medicina di cura primaria e quella ospedaliera. In Lombardia abbiamo privilegiato gli ospedali, perché non abbiamo sviluppato una visione globale del problema.
Anche la sanità della Lombardia sarà riformata. Ci sono sistemi regionali che potrebbero fungere da modello?
In Trentino, il direttore della Asl del Trentino Paolo Bordon ha creato un gioiello, basato sulla continuità assistenziale, sul territorio, sugli infermieri di comunità. Ha chiuso piccoli ospedali che non servono e messo in collegamento medici di famiglia e medici ospedalieri. Un altro sistema che funziona bene è quello dell’Emilia-Romagna. Si potrebbero applicare questi modelli in tutte le regioni d’Italia e il problema della riforma del Servizio Sanitario Nazionale sarebbe risolto.
In passato lei si è schierato a favore dell’obbligo vaccinale introdotto dal decreto Lorenzin. Ha la stessa posizione anche a proposito dei vaccini anti-Covid in corso di sperimentazione?
Un conto è il morbillo, in cui conosciamo benissimo l’efficacia. Ma con i vaccini per il Covid la situazione è molto diversa. Il vaccino non sarà efficace al 100%, saremmo contenti se arrivasse al 50%. Né sarà sicuro al 100%, perlomeno nei primi tempi. E non si riuscirà a distribuire a tutti sin da subito. È dunque prematuro parlare di obbligatorietà per un vaccino che avrà il problema di non poter raggiungere tutti quelli che dovrebbe raggiungere, cioè gli operatori sanitari, le persone a contatto con il pubblico gli anziani, chi lavora o è ospite in case di cura.
Se vuole dirsi “universale”, il servizio sanitario deve includere davvero anche la popolazione migrante. Eppure molti ritengono che gli immigrati abbiano avuto un accesso più difficile ai servizi sanitari durante l’emergenza. È un problema reale?
A Bergamo non abbiamo ricoverato nemmeno una persona afro-discendente, nonostante la popolazione migrante sia integrata e acceda ai servizi. Inoltre, la pandemia non ha avuto la diffusione che si temeva in Africa. Ma non è una questione genetica: gli afro-americani, che assumono lo stile di vita statunitense, si ammalano più del resto della popolazione. È possibile che la popolazione africana sia esposta a stimoli immunologici tali da sviluppare un sistema immunitario più attrezzato. E il vaccino anti-tubercolosi potrebbe conferire qualche protezione. Ma il problema della medicina delle migrazioni va al di là del Covid. Già nel 2014 Barack Obama parlò del rischio di malattie potenzialmente mortali trasmissibili per via aerea e della necessità di un’infrastruttura globale che consenta di isolare rapidamente i patogeni e organizzare la risposta. D’altronde l’uomo ha sempre migrato alla ricerca di una vita migliore. Desmond Tutu, premio Nobel per la pace, nel 2015 inaugurò il congresso della società mondiale di nefrologia di cui ero presidente salutandoci con le parole “Welcome home”, benvenuti a casa: perché dall’Africa proveniamo tutti. Per questo una reazione in stile “America First” non funziona più: contro la pandemia è necessaria una reazione globale.