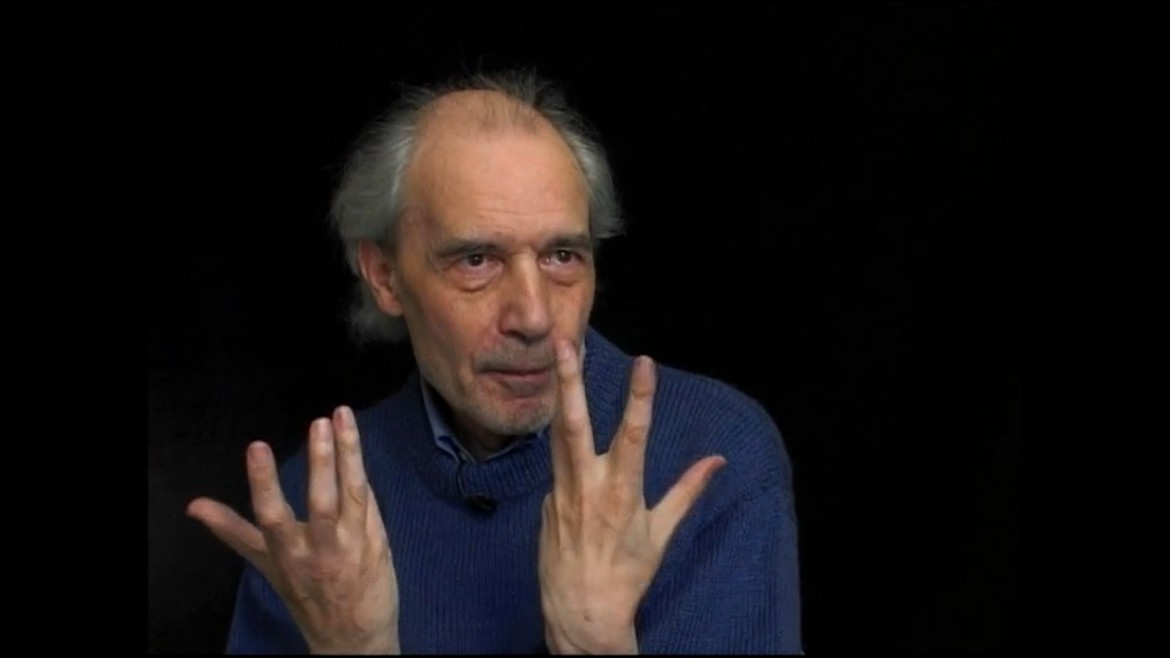Molto prima di morire, Jacques Rivette si era già trasceso nel proprio aggettivo: rivettiano. Non è tra i più noti del cinema moderno. Meno di godardiano. Molto meno di felliniano. Ma ha un vantaggio: rivettiano indica un concetto chiaro e distinto. Si tratta dello spirito della società segreta e del complotto. Rivettiano è quel cinema che non smette di misurarsi con la presa del potere politico; e di pensarsi come l’espressione di una comunità d’uomini che tramano nell’ombra e nei quali rivivono i misteri di Parigi, l’Histoire des Treize di Balzac ma anche la storia dei Cahiers du cinéma (di cui Rivette si è appropriato con un famoso «colpo di stato» ai danni di Rohmer).
Quella della presa del potere è l’immagine rivettiana per eccellenza. E quest’immagine, nel suo cinema, è indissociabile da una città: Parigi. Prendere Parigi, appropriarsi della capitale, è per prima cosa riprenderla. Ovvero filmarla. Ma come? Il «piano» rivettiano è un movimento di macchina e un gesto umano: salire in alto, abbracciare, passare d’un sol colpo dai bassifondi al tetto del mondo. In Paris nous appartient (1958), Gianni Esposito passeggia sul tetto dello Chatelet, dominando la città dall’alto. Mezzo secolo dopo, Jeanne Balibar sfugge da un’appartamento uscendo da un lucernaio. E tra queste due immagini c’è Bulle Ogier che parla dell’arco di trionfo come di una falesia in Pont du Nord (il solo film di Rivette che ha sempre messo tutti d’accordo).
È curioso e forse ingenuo come questo movimento d’ascensione sia in fondo un’antitesi al famoso «travelling di Kapo». La storia è nota. Rivette è l’autore di uno degli articoli più feroci della storia della critica. Come ricorda Daney, l’articolo non parla tanto del film di Pontecorvo ma solo di una scena. Dove afferma: «l’uomo che al momento in cui l’eroina si getta sul filo elettrificato fa un movimento di macchina in avanti per inquadrare il cadavere, avendo cura di far sì che la mano si iscriva perfettamente nell’inquadratura finale, quell’uomo non merita altro che disprezzo». Non entriamo nei dettagli della polemica.
Certo il colpo è riuscito – l’articolo è entrato nella storia della critica. È probabile che Rivette avesse in mente l’idea di «moralizzare» la messa in scena da tempo. E che il film di Pontecorvo gli abbia solo offerto l’occasione di illustrarla. Ma è anche questa la logica della presa del potere. Anche questo è rivettiano. Ora, il cinema di Rivette non ha mai ceduto alla tentazione di diventare una dissertazione politica. Anche quando, come in Ne touche pas la Hache (2007), ce n’erano tutti i presupposti.
Adattando La Douchesse de Langeais, Rivette taglia le quaranta pagine di teoria politica con le quali Balzac regola i conti con l’aristocrazia francese. Il cinema di Rivette non espone teoricamente un complotto. Il cinema è complotto. Nel senso che è sempre un lavoro occulto e misterioso di cui non si vede che l’ascensione, l’emergenza e che non cessa in questo apparire di rivelare la propria origine nascosta. Quale origine? Il teatro ovviamente. Per tutto il film la gamba di legno di Guillaume Depardieux, martellando il parquet del palazzo della duchessa, non smette di ricordarcelo: è da lì che viene il cinema. Il cinema ha preso il posto del teatro. È stato il suo coup de théâtre: uscire fuori dal teatro e fare tutt’altro. Ma è da lì che viene.
Rivette ha sempre guardato in avanti. «Rivettien» forse vuol dire questo: essere contro il vecchio perché giovani, passare dalla marginalità al centro della scena, avere la sfrontatezza di prendere il potere. Non un pezzo: tutto. È per questo che nei film di Rivette – come in nessun altro cinema – vive lo spirito della Nouvelle vague allo stato puro. Che cos’è la Nouvelle vague se non un gruppo di giovani che è riuscito a spazzar via d’un sol colpo tutto il vecchiume? Ma è uno spirito che va sempre rinnovato. Il complotto non è mai finito, bisogna – Rivette lo sapeva – sempre ricominciare a tramare contro i parrucconi.