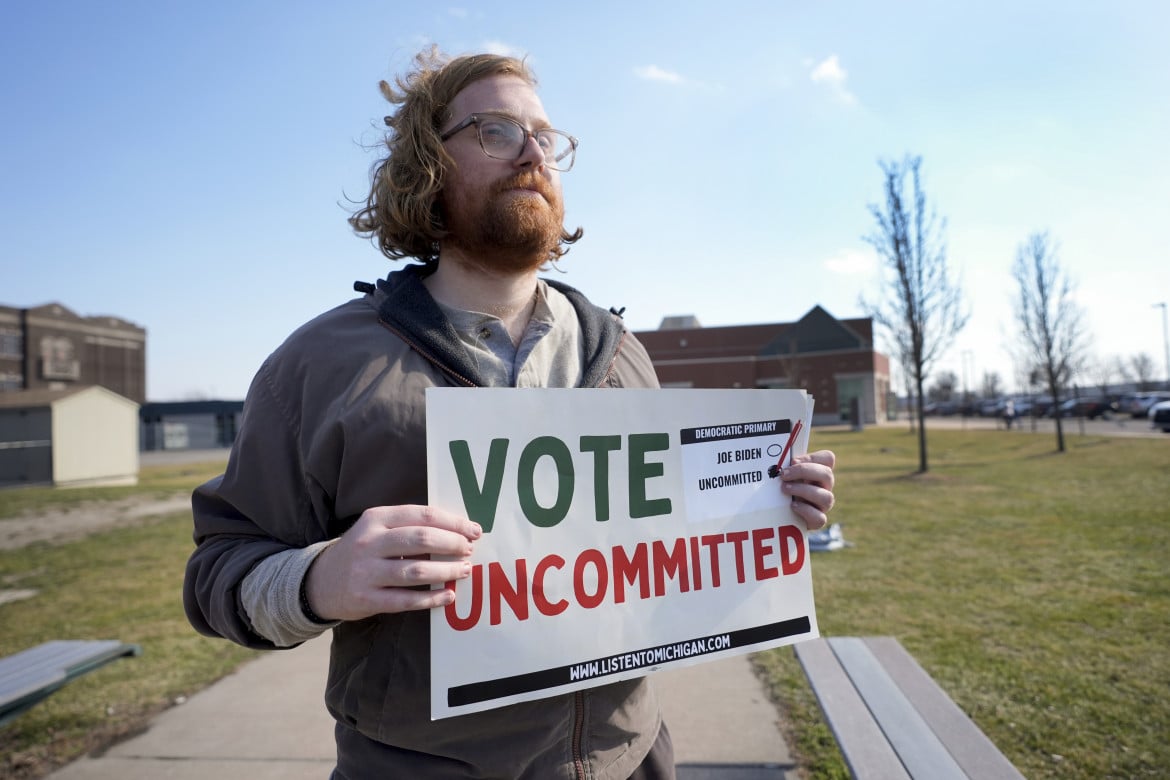È l’anno degli outsider, nella politica americana, e gli outsider si sono fatti sentire nel cosiddetto super martedì, nell’occasione inventata precisamente per tenerli fuori dai giochi che contano. I risultati del Super Tuesday, una serie di primarie e caucus concentrati in una sola giornata, sono chiari: sul fronte repubblicano Trump ha umiliato i concorrenti arrivando primo in sette stati su undici e facendo un sostanziale pareggio con Cruz in Alaska. I due senatori che ancora gli contendono la nomination sono rimasti indietro: Cruz ha vinto in Texas (il suo stato) e nel vicino Oklahoma, Rubio ha ottenuto il suo premio di consolazione vincendo in Minnesota. Trump ha 285 delegati alla convention, più degli altri quattro candidati messi insieme.
Ora, il problema è: il personaggio che il New York Times definisce un «pomposo, losco, bugiardo» può diventare presidente degli Stati Uniti? La risposta è che sì, è possibile. Prima di tutto eliminiamo una questione dalla scena: Trump è un buffone e quindi non può sul serio essere eletto. Risposta: per vent’anni Berlusconi ha dominato la scena politica italiana e la nostra penisola ha una certa tendenza a fare da laboratorio politico per il resto del mondo, cioè a mostrare in anticipo cose che solo più tardi appariranno altrove (per esempio, il fascismo). Non solo: in una società dello spettacolo, dove la politica è prevalentemente una forma di intrattenimento, essere uno showman è un vantaggio e non un handicap.
Un secondo problema è il fatto che esistono delle leggi non scritte della politica americana: per esempio si sa che quando un partito è rimasto per due mandati alla Casa Bianca, ottenerne un terzo è più difficile. Se guardiamo alle elezioni presidenziali del dopoguerra, questa situazione si è verificata sette volte: nel 1952, 1960, 1968, 1976, 1988, 2000 e 2008. In tutti e sette i casi, il partito di opposizione ha fatto un balzo in avanti nei suffragi.
Se escludiamo due elezioni anomale come il 1968 e il 1976, quando il partito all’opposizione avrebbe vinto anche presentando come candidato il cavallo di Caligola, ci restano cinque elezioni di cui quattro sono state vinte dallo sfidante, che in media ha ottenuto ben 7 punti percentuali in più della tornata precedente. Non sempre è stato sufficiente: per esempio nel 1988 i democratici fecero effettivamente un balzo in avanti del 5% ma nel voto popolare prevalsero comunque i repubblicani, dando la vittoria a George Bush padre.
Quindi, se le tradizioni verranno rispettate, nel 2016 i repubblicani dovrebbero incrementare la loro percentuale di voti ma questo è in contraddizione con un’altra legge della cultura politica americana, quella secondo cui una elezione in cui si contrappongono un candidato dell’establishment e un outsider, il primo vince a mani basse. Accadde nel 1964, quando il democratico Lyndon Johnson travolse Barry Goldwater, e nel 1972, quando il repubblicano Richard Nixon battè facilmente George McGovern. La mia tesi è che, quest’anno, le cose andrebbero diversamente.
Il motivo è che negli ultimi 35 anni, la polarizzazione politica negli Stati Uniti è fortemente aumentata. In altre parole, i democratici votano per il candidato democratico e i repubblicani per il candidato repubblicano, chiunque egli sia. Non è sempre stato così: ancora nel 1992 gli elettori repubblicani erano assai pragmatici nelle loro scelte: il 27%, più di un quarto di loro, votò per Bill Clinton o per Ross Perot invece che per Bush padre. Nel 2012 lo erano molto meno: appena il 7% di loro votò per Obama.
A sua volta, gli elettori democratici che nel 1980 tradirono massicciamente Carter (il 33% di loro votò per Reagan o per Anderson), nel 1996 erano diventati piuttosto fedeli al partito (solo il 15% votò per un candidato diverso da Bill Clinton) e si sono comportati in modo “bulgaro” nel 2012 quando solo l’8% tradì Obama.
Questo significa che un candidato Trump, nonostante la sua dubbia credibilità, il suo estremismo e la sua retorica incendiaria potrebbe alla fine portare alle urne tutti gli elettori repubblicani, o quasi, e non è certo che Hillary sia capace di fare lo stesso con gli elettori democratici. In ogni caso, le elezioni sono decise nel collegio elettorale: quelle americane sono elezioni di secondo grado, i cittadini votano per i delegati del loro stato, che a loro volta votano per il presidente e anche piccoli spostamenti possono rovesciare il risultato.
Per esempio, se i repubblicani riuscissero a vincere in Florida e in almeno altri due grandi stati come Ohio e North Carolina, dove nel 2012 prevalse Obama, otterrebbero 63 delegati in più nel collegio elettorale, che sommati ai 206 di partenza (supponiamo che tutti gli stati che hanno votato per Romney nel 2012 rivoterebbero per i repubblicani anche quest’anno) farebbe 269.
Sarebbe un pareggio (i delegati sono in tutto 538) e le sorti della presidenza, come vuole la costituzione, verrebbero decise dalla Camera dei rappresentanti, che però è controllata dai repubblicani: questo è uno degli scenari di una possibile vittoria di Trump, sia pure sul filo di lana.