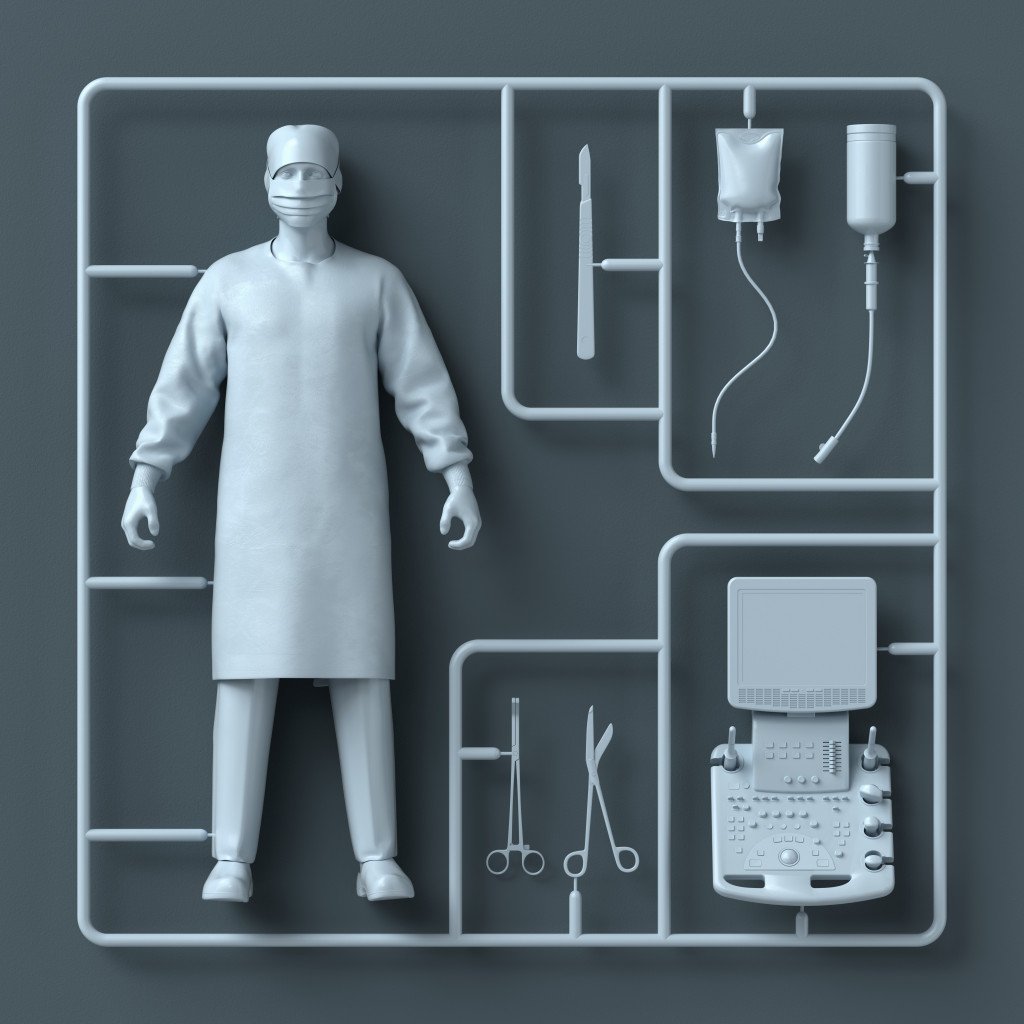Nessuno allo stadio, nessuno alla partita. Così cantavano oramai venticinque anni fa Elio e le storie tese. Si era alla vigilia dei Mondiali di calcio di Usa 1994, e dato lo scarso interesse degli americani per il soccer si pensava che gli stadi sarebbero rimasti desolatamente vuoti.
Invece fu record di pubblico. I quasi 70mila spettatori di media che seguirono ogni partita restano di molto avanti a Brasile 2014 e Germania 2006, che seguono a 53mila.
Quello che invece successe a Usa 1994 è che si palesò un nuovo tipo di pubblico nascente, lo spettatore appunto, che per diversi motivi aveva definitivamente sostituito il tifoso. Ora che nessuno sa se e quando il calcio potrà riprendere in Europa – al solito tutti litigano perorando i propri interessi e disinteressandosi del pubblico, chi vuole sospendere lo fa perché vuole risparmiare sugli stipendi o è in una pessima situazione di classifica, chi vuole ripartire subito nasconde i motivi opposti – una sola cosa è certa: si giocherà a porte chiuse, per lungo tempo. Almeno un anno, probabilmente più.
E dopo questa ennesima rivoluzione nella spettatorialità, un calcio giocato in stadi vuoti e silenziosi, lo spettacolo non potrà più essere lo stesso. Né in campo, né fuori. Cambierà il modo di giocare a pallone e cambierà il modo di raccontarlo.
Come tutti i prodotti dell’industria culturale, infatti, mutando i rapporti sociali ed economici con la spettatorialità mutano di conseguenza la messa in scena e i codici dello spettacolo stesso.
La storia del pallone può infatti essere letta anche attraverso la storia del suo pubblico. Le prime proteste per l’aumento del prezzo dei biglietti dello stadio in epoca vittoriana raccontano di come il calcio, con l’avvento del professionismo – e la possibilità di giocare anche per il proletariato, e non solo per i ricchi figli delle public school britanniche – stia mutando da sport elitario a sport di massa.
La sua consacrazione come prodotto di largo consumo avverrà poi in Italia durante la dittatura fascista.
Come in Russia Anatoly Lunacharsky punterà tutto sul cinema per glorificare la rivoluzione bolscevica, in Italia sarà il deputato fascista Lando Ferretti a comprendere come il pallone abbia la capacità di interpellare le masse e costruirne l’ideologia. Nascono infatti in quegli anni la Serie A a girone unico, il professionismo, il calciomercato, gli stadi costruiti con sovvenzioni statali. Nasce il primo calciatore idolo, Giuseppe Meazza, capace di rivaleggiare in celebrità dentro e fuori dal campo con i divi del cinema.
Muta la percezione politica del pallone, quando vince i Mondiali 1934 e 1938 e le Olimpiadi 1936 lo spettatore fascista è convinto di ritrovare nella squadra nazionale la presunta grandezza del suo paese. Lo stesso accadrà con i trionfi mondiali delle sanguinarie dittature brasiliane e argentine.
Nel dopoguerra si ha un’ulteriore rivoluzione semiotica, la cui genesi è sempre in Gran Bretagna: l’operaio massa del processo produttivo automatizzato trova nella partita di pallone la possibilità di sviluppare nuovi ideali comunitari – spesso machisti, gerarchici, patriottici, aggressivi e violenti – e ritrovare in esso una vitalità sepolta dalla catena di montaggio.
Nascono le prime tifoserie organizzate, le bande e il fenomeno dell’hooliganismo, che sarà poi trasformato in marketing affettivo, politico ed economico.
Mentre in Italia, a seguito della politicizzazione delle fabbriche e dell’assalto al cielo dei movimenti, quando si inizia a portare il conflitto fuori dai classici processi di produzione capitalista, ovvero nei rapporti di produzione della vita di tutti i giorni, si sviluppa la cultura ultras destinata poi a fare proseliti nel nord Europa. Si cristallizza quella figura mitica del tifoso, non certo eterna e durata in realtà una ventina d’anni e non di più, destinata poi ad essere spazzata via nel peggiore dei modi.
Il pallone – come lo sport in generale, le Olimpiadi in particolare – è diventato un business globale, e i padroni capiscono che con i giusti accorgimenti si può aumentare a dismisura il giro di affari, affiancando i migliori prodotti dell’industria culturale come la musica e il cinema. Intanto sono cominciate anche le prime trasmissioni televisive, che hanno sempre più seguito: la nascita del calcio televisivo è lì pronta a venire, ma manca un qualcosa.
Lo spettacolo, come insegna James G. Ballard, può essere generato solo dalla catastrofe. E allora ecco che nel calcio inglese avvengono due immani tragedie, prima l’Heysel e poi Hillsborough, entrambe di accertata responsabilità della polizia e delle forze dell’ordine, che permettono di uccidere letteralmente il tifoso e di sostituirlo con lo spettatore.
Prima in Gran Bretagna e poi nel resto del mondo, come sempre, arrivano tutta una serie di regole per l’accesso allo stadio e la fruizione della partita, sostenute dalla costruzione di nuovi impianti e dall’aumento vertiginoso del costo dei biglietti, che espellono definitivamente la working class dagli stadi.
Il nuovo pubblico, per lo più silenzioso, che non canta e non urla più ma che batte placido le mani o al massimo se le porta alla bocca in un gesto di ostentata meraviglia, è quello che il capitano del Manchester United Roy Keane definì sprezzante di «mangiatori di sandwich ai gamberetti»: è un turista del pallone, interessato a uno spettacolo diverso.
E così cambia anche il modo di giocare.
La passione per il calciatore operaio che lotta, per il gregario che esce con la maglia sudata – «uno di noi» – è sostituita dalla feticizzazione dello schema e dall’attesa spasmodica del gol: il plusvalore del calcio elevato a forma d’arte.
Allo stesso modo la televisione, prima con la telecamera che si sposta sempre più verso il basso, in un ossessivo close up per meglio inquadrare gli sponsor sulle maglie e sui cartelloni, e con la sua insistenza parossistica sugli highlights – il gol, la punizione, il singolo gesto tecnico agli albori, la lavagna tattica, le catene laterali degli esterni poi – muta la fruizione del prodotto per adattarlo ai nuovi gusti del pubblico da casa.
Si gioca in maniera diversa e come nella famosa camera oscura non è stato il campo a influenzare il pubblico ma viceversa: lo spettacolo si adatta alle richieste dei nuovi spettatori. O meglio, le due cose si compenetrano e influenzano a vicenda.
E ora? Cosa succederà con gli stadi vuoti? Come cambierà il calcio, anche a livello di campo oltre che di racconto?
È bene subito sgomberare il campo da un grosso equivoco. La rivoluzione televisiva c’è già stata, ed è stata trent’anni fa, e il Mondiale di Usa 1994, il primo Mondiale televisivo della storia – si giocava a mezzogiorno, sotto un caldo allucinante, per essere trasmesso nel prime time catodico europeo – a dispetto di quello che cantavano Elio e le storie tese non ha svuotato gli stadi, anzi.
La televisione teme il vuoto, forse perché ci si specchia.
Un esempio per tutti, i finti cartonati con i tifosi disegnati apparsi in alcuni stadi di provincia, o i seggiolini colorati appositamente per coprire a colpo d’occhio gli spalti vuoti, li pretende la tv. O basta anche ricordare come sia stata la televisione, all’inizio della pandemia, a spingere perché le partite non si giocassero a porte chiuse.
E ora che, dopo il tifoso e l’ultras, anche lo spettatore sarà suo malgrado espulso dallo stadio, e per lungo tempo, i più ottimisti infatti prevedono che alla riapertura le capienze saranno ridotte per permettere il distanziamento tra le persone, anche il gioco del pallone sarà destinato nuovamente a mutare pelle. A diventare qualcosa di completamente diverso.
Quella cui assisteremo sarà l’ulteriore rimodulazione della semiotica calcistica, l’ennesima riscrittura dei suoi codici.
Senza pubblico si giocherà in maniera diversa. I bisogni del nuovo spettatore, i suoi desideri, saranno differenti, e questo influirà sui movimenti dei giocatori in campo. Non sappiamo quando ricominceranno i campionati di calcio e non sappiamo a che spettacolo assisteremo, di sicuro non l’avremo mai visto prima.