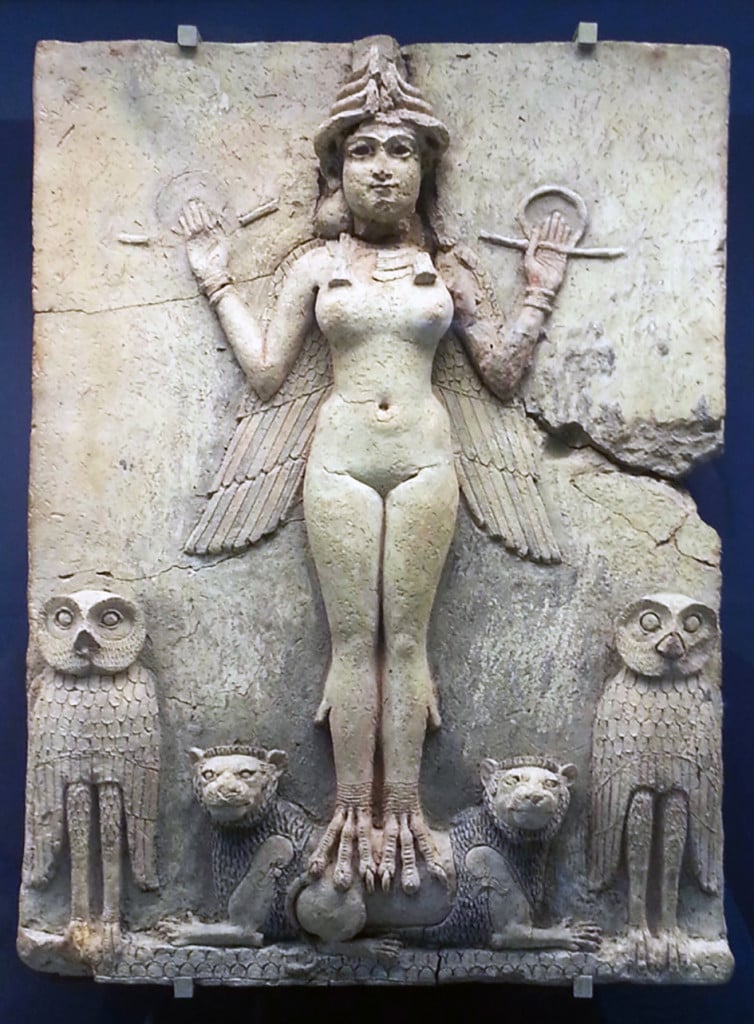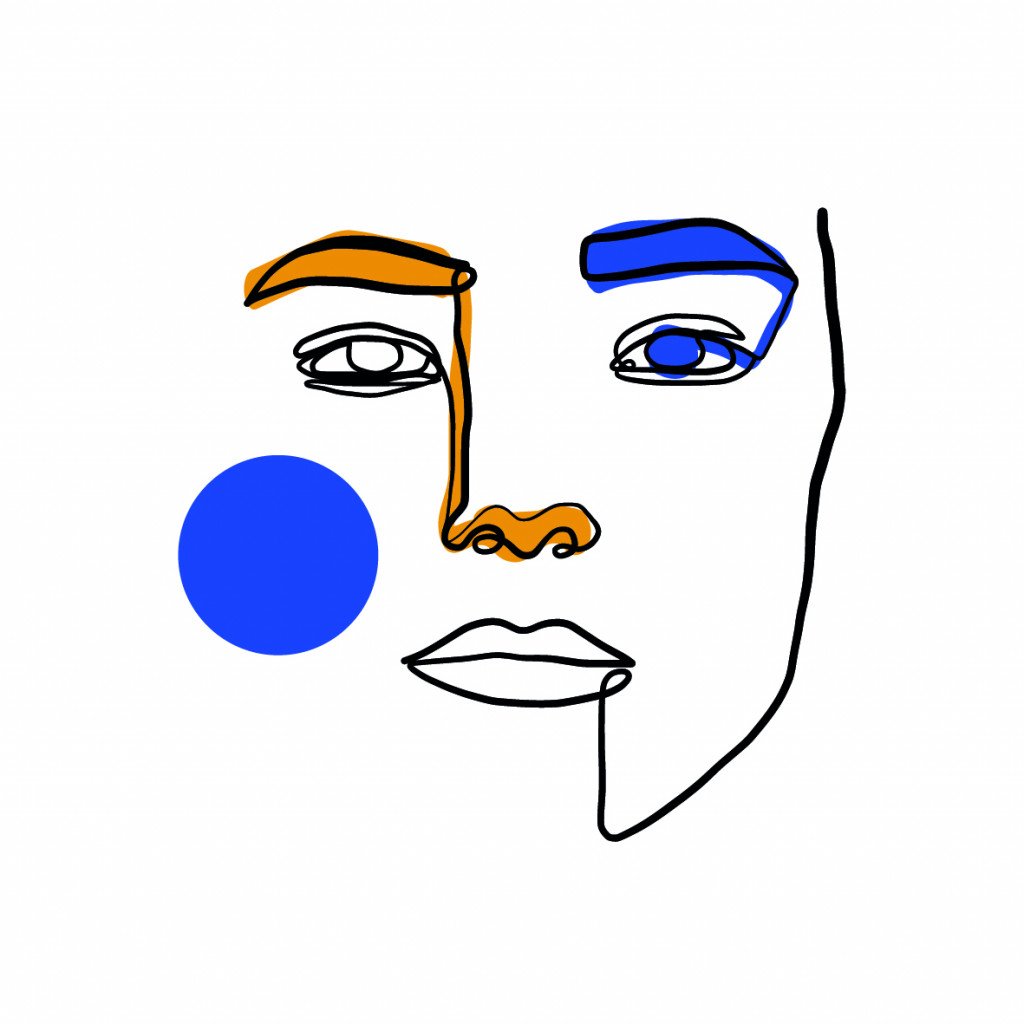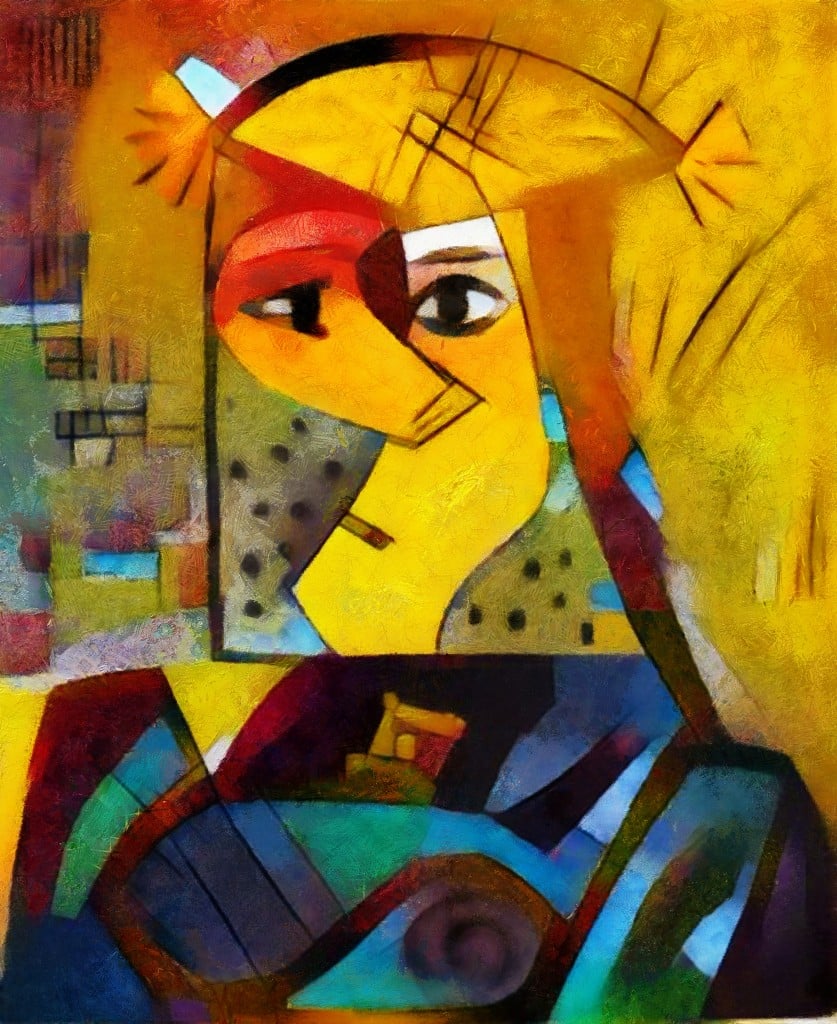Siamo soggettività in relazione, per cui il nostro sguardo, anche quando costretto a riflettere soprattutto su di sé come nell’inedita condizione di confinamento domestico in cui la pandemia ci ha precipitato per due mesi, non può non allungarsi sulle vite degli altri. Mentre, come mi ha insegnato la pratica femminista, parto dalla mia esperienza, provo anche a segnalare i punti nodali che sono emersi con prepotenza dalla crisi epidemica che ha messo a nudo, soprattutto per almeno tre o quattro generazioni di «senza trauma» (secondo la felice espressione di Daniele Giglioli), la vertigine di un cambio di passaggio storico, del salto temporale tra un prima e un dopo.
Io penso e scrivo da un privilegio, da una posizione agevolata dal fatto di poter continuare la mia vita dislocando «in remoto» molte delle mie attività principali, a cominciare da una parte consistente del mio lavoro. Una condizione di vantaggio rispetto a tante altre persone che come chi scrive, ma con effetti diversi, talvolta devastanti, sono state travolte dalla pandemia di COVID-19 che ne ha trasformato vita, ritmi, bisogni, aspettative, progetti in pochissime settimane. Quello che faccio per professione – ricerca e didattica, pensare e insegnare la storia del pensiero, leggere e scrivere – può esser fatto con altri metodi e l’utilizzo di tecnologie dalla mia postazione casalinga, adattando le pratiche consuete a qualche radicale ma necessario cambiamento. Anche se nessuno in questo paese lo ha ancora riconosciuto, l’Università è stata l’istituzione che ha reagito forse con più rapidità all’evento imprevisto e imprevedibile che ha scompaginato la nostra routine e nel giro di una settimana o poco più ha trasferito praticamente tutta la didattica, oltre alla maggior parte delle numerosissime altre attività che la impegnano, in modalità «a distanza», favorendo per milioni di persone (la comunità accademica tutta, docenti, discenti, personale tecnico e amministrativo) quel salto improvviso nella fase del «distanziamento sociale» e del «confinamento domiciliare», apparsa sin da subito la più concreta possibilità per tentare di arginare il contagio epidemico. Quella stessa Università italiana da decenni sotto finanziata, e per lo più scarsamente o affatto considerata come parte integrante e vitale del paese, ha risposto senza esitare e con estrema rapidità a quanto si è reso indispensabile in una condizione mai sperimentata prima in cui tutta la sua operatività è stata spostata, nel pieno di questo indimenticabile secondo semestre dell’a.a. 2019/20, «a distanza» e in modalità telematica. Questo non significa naturalmente che la comunità accademica – spazio vitale di persone che si incontrano, di collettività di ricerca, di scambi d’apprendimento e conoscenza, di saperi condivisi, di corpi che interagiscono in un’interconnessione fluida e feconda tra generazioni, percorsi, mentalità differenti – non consideri una iattura le conseguenze concrete del «distanziamento» subito, ma le va riconosciuto che ha saputo reagire con agilità adattiva e adeguata flessibilità alla sfida feroce e inattesa della pandemia virale.
Il modo in cui l’epidemia si è manifestata ha fatto apparire immediatamente e con limpida chiarezza che il virus avrebbe fatto pagare all’intera collettività un prezzo proibitivo per lo smantellamento del welfare a cui si è proceduto con ottusa protervia nelle ultime decadi, per esempio, indebolendo drasticamente non solo i comparti scuola, università e ricerca, ma in particolare la sanità pubblica. Settore in cui sono stati, riducendone all’osso alcuni servizi essenziali, disattivati scientemente e irresponsabilmente percorsi e spazi collaudati di prevenzione e intervento, per lo più allo scopo di favorire l’impresa privata, consentendo a quest’ultima di fare profitti immensi sulla salute collettiva e inducendo, al contempo, con tragica efficacia una vera e propria demolizione del principio stesso che il benessere sociale è al contempo bene comune e diritto inestinguibile, caratteristica che accomuna per l’appunto istruzione, ricerca, cultura e salute.
Questa crisi epocale ci offre l’imperdibile occasione di riattivare la critica radicale alle politiche di distruzione e cancellazione del welfare e di ricominciare a pensare agli interventi più urgenti da cui un paese che si risveglierà dal lockdown in una condizione economica e sociale paragonabile a un dopoguerra non può non ripartire, a cominciare proprio da interventi di rifinanziamento e sostegno corposo a settori come sanità, istruzione, ricerca e cultura, ambiti in cui gli investimenti mancati si sono tradotti in un’autentica debacle collettiva, in alcuni casi in un totale e drammatico azzeramento (penso a teatri, cinema, musei). Ma la crisi sociale innescata dalla pandemia di COVID-19 sarà terribile per tante e tanti perché trattasi di crisi sistemica, del fallimento tangibile di un modello di sviluppo basato sulla crescita illimitata e sull’evanescenza crudele dei capitali finanziari. Il paradigma economico neoliberista predatorio che ha modellato le politiche governative dell’ultimo ventennio ha mostrato crepe vistose e contraddizioni insanabili, con la conseguenza d’aver quantomeno sgretolato la certezza infondata che lo dava per autoriproduttivo, immodificabile ed eterno.
È proprio per questo che oggi si impone un radicale ripensamento che sia in grado di immaginare il futuro prossimo, quello che comincia domani, a partire da una proposta di reddito di base incondizionato, individuale e universale che consenta a molte/i di riprendersi, anche di reinventarsi, poiché in tanti settori la crisi ha fatto tabula rasa, penso all’imprenditoria culturale, ai mestieri della creatività non garantita, ai tantissimi ambiti ove la precarietà indeterminata e illimitata è la norma. Penso alle tantissime donne che, come in ogni periodo in cui la crisi economica morde, restano fuori o saranno espulse dal mercato del lavoro. Penso al lavoro agricolo nei campi e a quello di cura domestica nelle case, per lo più appaltato a donne e uomini migranti maggioritariamente irregolari, che operano senza garanzie se non addirittura in condizioni di palese ed estremo sfruttamento a cui ora, senza dilazioni, occorre trovare risposte concrete, contratti equi, diritti non rimandabili e riconoscimento reale con una massiccia sanatoria che riconosca valore a queste persone costrette all’invisibilità, pur rappresentando un sostegno vitale alla sopravvivenza di tutte/i noi, sia per il ruolo che ricoprono nella filiera alimentare che nella sfera più ampia della riproduzione sociale.
Quello che si è stagliato con nettezza sullo sfondo della storica crisi da COVID-19 è che i diritti minimi di cittadinanza vanno riformulati come diritto all’esistenza e a condurre una vita dignitosa e che questo implica un grande progetto di redistribuzione delle risorse che contribuisca, dopo il vero distanziamento sociale di questi due mesi, cioè l’ineguaglianza che aumenta a ritmi esponenziali, ad accorciare in tempi rapidi le distanze economiche, a contenere le crescenti sperequazioni e ad ampliare lo spettro delle possibilità offerte a ciascuna/o, cercando alternative reali all’attuale modello economico il cui fallimento, come abbiamo constatato, mette concretamente a repentaglio la stessa sopravvivenza individuale. Ricominciare a ricostruire dai luoghi sociali e dagli spazi comuni, quelli visibili e quelli invisibili, quelli noti e quelli che si ignorano deliberatamente, in cui l’ingiustizia e l’ineguaglianza si sono manifestate in tutta la loro brutalità con un grande progetto di restituzione, redistribuzione e giustizia sociale.
*
Francesca R. Recchia Luciani è docente di Storia della filosofia dei diritti umani all’Università di Bari Aldo Moro e direttrice del Festival delle Donne e dei Saperi di Genere.