Nell’attuale contesto culturale capitalista che ha caratterizzato gli ultimi secoli della storia umana, il processo di creazione culturale si è trasformato in produzione programmatica di intrattenimento. Emarginando sempre di più l’estro artistico dei creativi, nel tempo ci siamo affidati sempre di più alle indagini di mercato, ai sondaggi dei consumatori, ai feedback tecnici di chi non aveva un’idea o un messaggio da proporre, ma un prodotto da distribuire in un mercato fatto di target di consumo e indici di gradimento.
Quest’approccio produttivo alla creatività si è talmente radicato nella nostra dieta mediatica che quando oggi ci dedichiamo all’analisi dell’intrattenimento, teniamo sempre ben a mente che le esigenze della casa produttrice siano in primis quelle economiche, e solo in secondo luogo creative e comunicative.
I grandi attori dell’industria videoludica cercano dunque di far coesistere velleità artistiche e urgenze di profitto, spesso rinunciando con una certa semplicità alle prime, pur di agguantare con ingordigia le seconde.
Metro: Exodus, pur nella straordinaria qualità della sua messa in scena, rappresenta uno degli esempi più concreti di questa sbilanciata dicotomia: varie filosofie di storytelling interattivo si scontrano per tutta la durata dell’esperienza, rendendo difficile coglierne il significato più esplicito, il messaggio che lo studio desiderava comunicare.
E dire che 4A Games cerca di utilizzare tutte quelle tecniche che negli ultimi anni si sono dimostrate efficaci per garantire credibilità alla messa in scena: l’interfaccia grafica è stata ripulita di orpelli extradiegetici, cercando di rendere sempre più protagonista il giocatore, e l’eroe dell’avventura è stato ridotto a mero avatar, silente e afono anche nei momenti più concitati. Al contempo, diventa incredibilmente loquace nelle sessioni di narrazione testuale, e viene costantemente interpellato dai vari comprimari, tanto da risultare persino parodistico. Inoltre, le numerose mancanze tecniche, come ad esempio l’intelligenza artificiale deficitaria, rendono meno impattanti le pur apprezzabili scelte di design, trasformando in alienanti momenti del racconto che dovrebbero invece essere particolarmente coinvolgenti.
Tra le orrorifiche incursioni nelle anguste metropolitane russe ed esaltanti fughe tra le lande devastate del Kazakistan, l’esperienza si lascia interagire con piacere, ma senza mai riuscire a esprimere qualcosa che vada oltre qualche semplice e mal recitato monologo, o una piccola sequenza cinematica priva di coerenza con il giocato che la seguirà. Come in molti videogiochi, avremo a che fare con decine di armi, personaggi, mostri e luoghi straordinari, riprodotti con fedeltà estrema e cura maniacale, facendoci strada silenziosamente tra accampamenti di schiavisti e tane di mostri mutanti emersi negli anni successivi alla distopica guerra nucleare che ha devastato il pianeta, antefatto alla base della serie letteraria di Metro, che ha poi trovato ulteriore fortuna nella sua controparte videoludica. Ma quelle che in apparenza appaiono come profonde riflessioni sulla precarietà dell’esistenza umana trovano il loro spazio solo nelle pause tra una sparatoria e l’altra, senza avere il tempo per esprimersi in modo adeguato, e il racconto del gruppo di soldati e soldatesse protagoniste della vicenda risulta essere più un pretesto per lanciarci nell’apocalisse, che non il vero desiderio creativo dello studio. Sebbene sia dunque così evidente, perché forzare tra loro prospettive e scelte di design così contraddittorie? Perché la critica all’eroismo convive con il più stereotipato dei machismi individualistici? Probabilmente, ciò accade proprio perché l’opera è in realtà un prodotto, che risponde a esigenze di indagini di mercato perfettamente integrate tra di loro, dedicate a un’utenza oramai assuefatta a giocare per consumare e non per assorbire opere con messaggi e significati ben precisi. Forse perché oggi dover comunicare fuori dalla nostra bolla da social network da sempre più fastidio.
Metro: Exodus produrre e creare
Games. Sparatutto in prima persona della 4A Games, difficile coglierne il messaggio
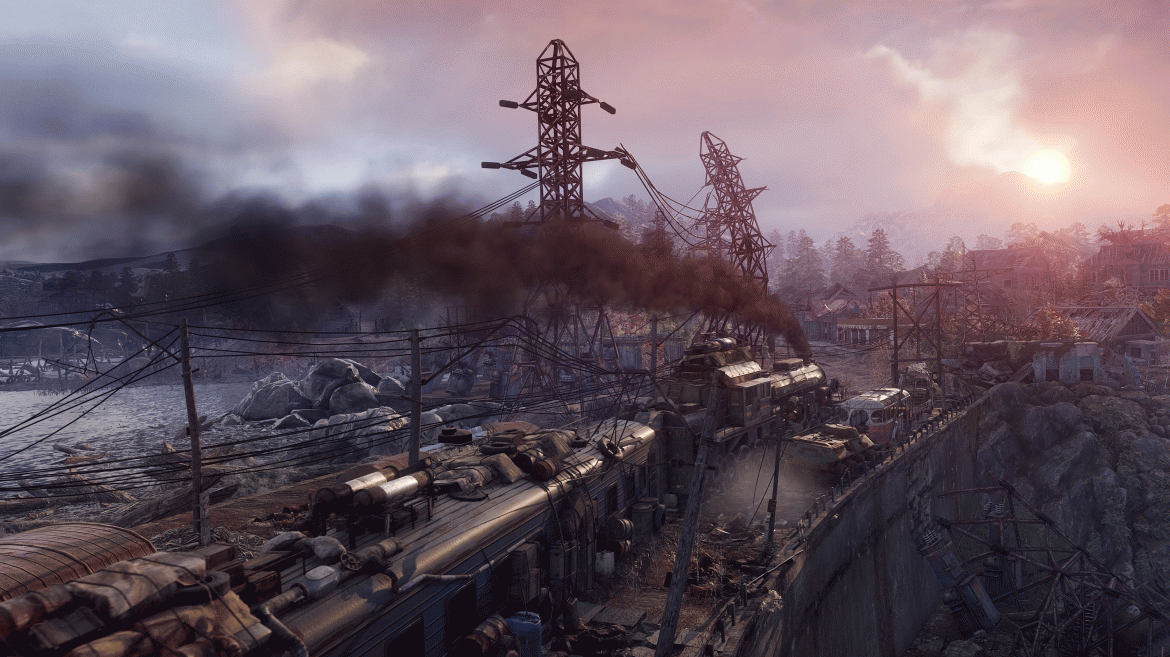
Games. Sparatutto in prima persona della 4A Games, difficile coglierne il messaggio
Pubblicato 5 anni faEdizione del 27 aprile 2019
Pubblicato 5 anni faEdizione del 27 aprile 2019
