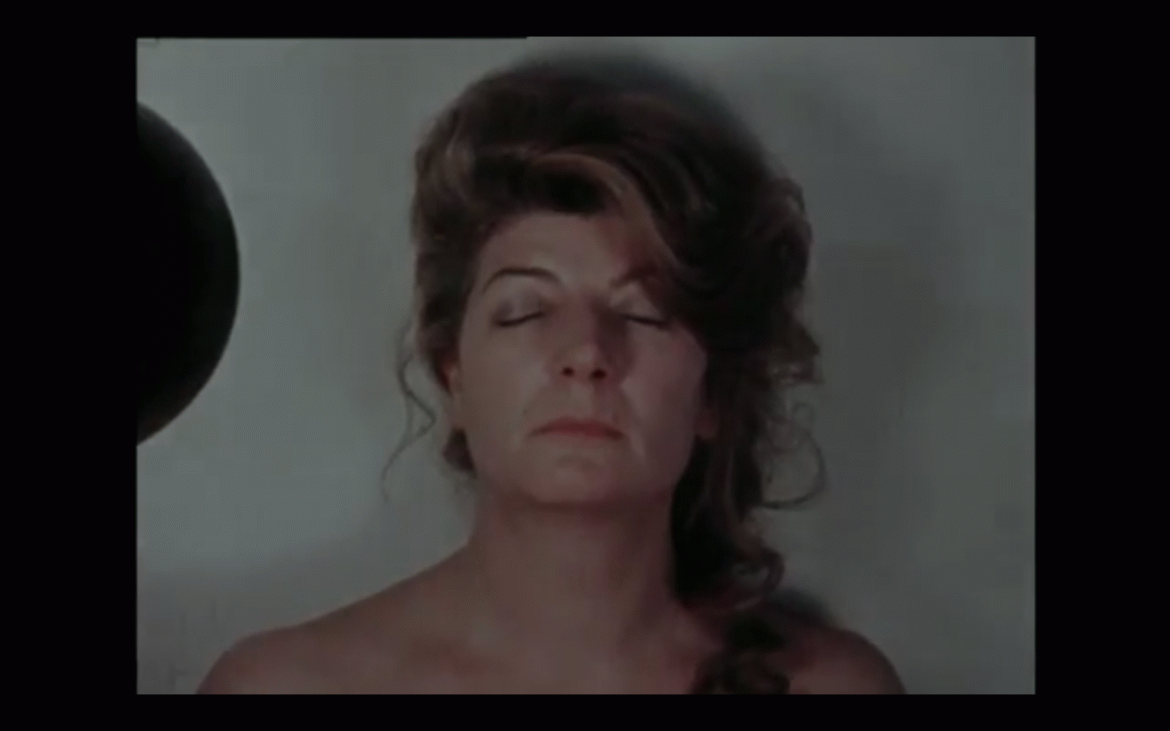Per chi ama l’immagine in movimento in tutte le sue forme o declinazioni, c’è una mostra che merita e a cui non si può mancare, quella del cinema sperimentale di una grande e sempre poco citata artista italiana, Marinella Pirelli (1925-2009).
L’allestimento lo si trova a Milano, al Museo del Novecento, fino al 25 agosto, e si tratta di una occasione unica per vedere o meglio ammirare una parte del percorso di una artista che, al di là dei giudizi di valore che si possono applicare al suo lavoro, è riuscita a creare un corpus di opere (cortometraggi) che toccano alcune delle maggiori tendenze che si sono riscontrate nel cinema di ricerca dal secondo dopoguerra. Dall’animazione (Gioco di dama, 1961-63; Pinca e Palonca, 1963-64) alla ritrattistica (Narciso, film esperienza, 1966-67; Doppio autoritratto, 1973-74), passando per molte altre opere e operazioni artistiche fra cui, soprattutto, l’anticipazione del cosiddetto «cinema espanso» (il progetto Film Ambiente, a partire dal 1967).
In tutto ciò, val la pena far il punto su alcuni temi che emergono da quanto visto.
A come attenzione
Una prima impressione che potrebbe scaturire dalla mostra è quella di trovarsi di fronte un campionario di visioni alla cui base ci sarebbe l’evidenza delle componenti che producono la salienza dell’immagine filmica, proposti in modalità diverse: luce, movimento. Inoltre, queste due parole compongono il titolo del libro che accompagna la mostra, a cura di Lucia Aspesi e Iolanda Ratti. Si tratta di una pubblicazione che raccoglie punti di vista critici diversi – contemporanei, storici – sul cinema sperimentale dell’artista, includendo anche la sua filmografia commentata, a cura del francese Érik Bullot, filmmaker e studioso di immagini in movimento (da leggere il suo Le film et son double).
A partire dalla rilevanza data alla luce e al movimento, lo sguardo di Pirelli sembra spesso essere teso a configurare un piano visivo in cui il particolare – diciamo: un intervento oppure una invenzione – tende a sublimare l’universale – per esempio: quello rappresentato da una situazione, o narrazione. In un certo senso, non sarebbe sbagliato dire che si potrebbe trattare di un modus operandi riscontrabile non di rado in chi fa animazione.
Ora, una prospettiva del genere sembrerebbe delineare una poetica precisa. In merito Lucia Aspesi scrive: «L’attenzione per i dettagli, siano essi germogli su un ramo, foglie al vento o piccoli e apparentemente insignificanti oggetti domestici, testimonia altresì nel lavoro di Marinella Pirelli una meditazione di tipo introspettivo, che sembrano sottolineare una volontà di distacco dall’attualità, in cui pure è immersa, ma verso la quale si pone come attenta osservatrice.»
B come bruciatura
Nel suo commentario, Bullot fa una analisi molto incisiva a proposito di uno dei film di Pirelli, Bruciare (1971), presente alla mostra, in cui al centro dell’osservazione c’è l’azione di un uomo che si accende una sigaretta e ne avvicina l’estremità incandescente ad alcune tipologie di fiori, dando il là a reazioni cromatiche di varia natura. Il francese scrive: «Ancora una volta ritroviamo il gioco delle opposizioni tanto caro all’artista: da una parte, la delicatezza delle tonalità, l’attenzione per le forme vegetali, il lirismo; dall’altra, l’intensità distruttiva, la sofferenza, la violenza.» Poi continua: «Basandosi su una semplice suggestione visiva, questo breve film rientra tra i gesti cinematografici dell’artista e ha il valore di un enunciato.» Ma allora, quale sarebbe l’enunciato in questione? Stando sempre a quanto dice Bullot, si potrebbe far riferimento ad una frase di Pasolini: «Fare del cinema è scrivere su della carta che brucia.» Seguendo il ragionamento e sviluppandolo, il cinema di Marinella Pirelli sarebbe un qualcosa che alla fine si consumerebbe attraverso una messa in tensione degli elementi in gioco, considerando tanto quelli dentro il quadro dell’immagine quanto quelli fuori.
A questo, andrebbe aggiunta una considerazione su come interpretare la bruciatura evocata nella citazione dal poeta italiano. Il termine potrebbe essere letto come sinonimo di una instabilità delle condizioni che permettono all’artista di esprimersi ma che, contemporaneamente, ne influenzano la forma. Dalle sue stesse parole, che Ratti riporta nel suo contributo critico: «Fermare l’attimo. Ecco, capisco star dentro un linguaggio – costruirsi un limite – ma per natura dell’artista (io lo sono?), ecco allora diciamo “per la mia natura”, questo non è possibile. Sono costretta a provare e non ripetere, ogni inizio è la voglia e il piacere dell’avventura, avventura come cosa da scoprire – nel fare – e poi perché il proposito non è ancora il progetto, né il progetto è l’opera, checché ne pensino i concettuali.» Questo interesse ha forse il suo apice in Doppio autoritratto.
C come cinema
Doppio autoritratto è un film a colori – durata: tredici minuti – che l’artista ha realizzato poco dopo la morte del marito Giovanni Pirelli. L’opera sembra restituire una immagine duplice della sua autrice. Da un lato, la troviamo attrice, assoggettata alla forma del ritratto (primo piano), vista la presenza di una serie di sue inquadrature frontali fisse, come fosse una sorta di «China Girl» senza barra cromatica – nell’industria cinematografica, l’espressione identifica un tipo di prova su pellicola, raffigurante volti di donne e utilizzata da tecnici di laboratorio. Dall’altro lato invece, Marinella Pirelli è anche operatrice. Ci mostra il suo corpo, ma lo fa a partire da un movimento incontrollato della cinepresa tutt’intorno, un movimento che ne restituisce in modo confuso dei dettagli, su una partitura sonora che comprende pezzi di Vivaldi e Monteverdi. Il film è dedicato a quel grande artista concettuale che fu Vincenzo Agnetti, con rimando all’opera Quando mi vidi non c’ero (1971).
Ora, a proposito di Doppio autoritratto, quello che si può forse dire è che si tratta di un lavoro dove, tra stasi e cinèsi, si percepisce una sorta di abbandono all’idea di cinema come linguaggio automatico che non si domina e che ci domina. Cioè ci usa. Ponendosi come tema del suo film, l’artista ci presenta un autoritratto in cui sembra sublimarsi e, forse, sparire. «La cinepresa era il mio partner: ognuno di voi è ora il mio partner.» Così finisce la sua dichiarazione che si legge nel cartello introduttivo al film. Si direbbe allora una specie di tentativo di transfert psicologico? Oppure un desiderio di empatia visiva per rompere la mediazione dello schermo? Va da sé che le suggestioni possono essere diverse. In merito si potrebbe intanto osservare come tutto ciò non ci restituisca alcuna pretesa di introspezione. Guardando quest’opera, mi è tornata in mente una frase di un genio che, credo, sarebbe piaciuta all’autrice: «Cinema è quando gli occhi miei si chiudono solo a guardami dentro.»