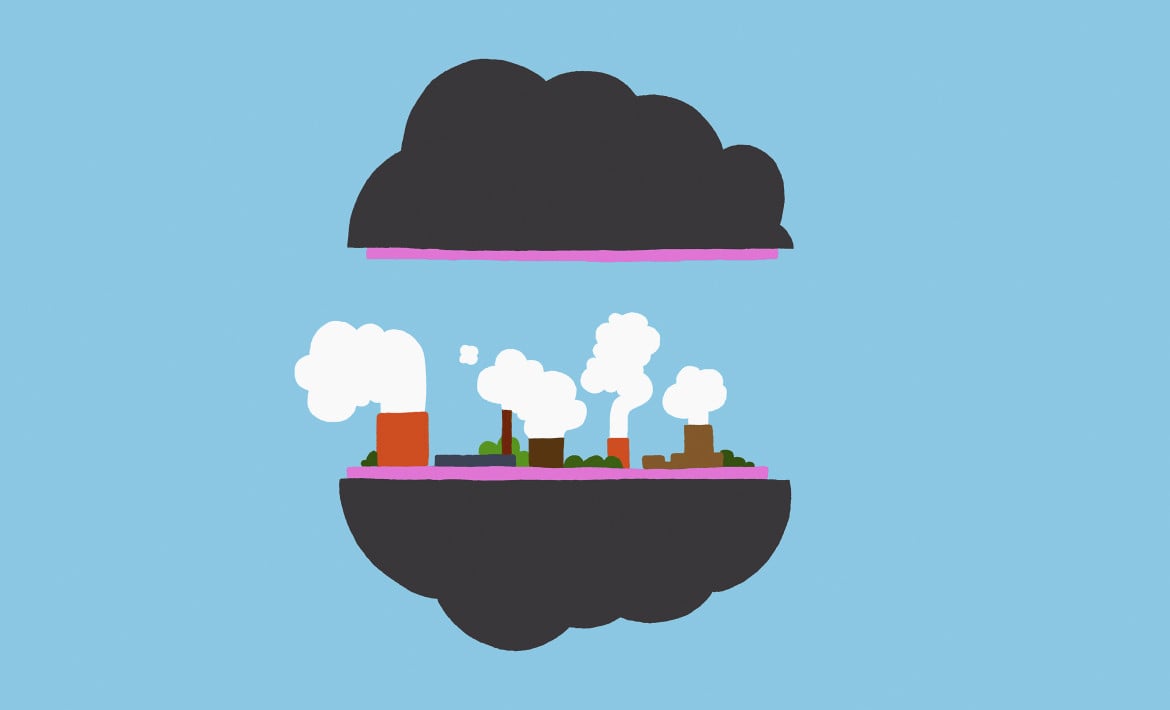Neanche Gulliver, nei suoi straordinari viaggi, si è mai imbattuto in un paese in cui scontrini e castelli occupassero il centro del dibattito politico. Del resto quando si procede lungo binari obbligati e compatibilità senza varianti trovare oggetti di disputa richiede un sempre maggiore sforzo di fantasia.
Così il premier avrebbe fatto marcia indietro sulla detassazione dei primi castelli. Non l’aveva mai prevista? Si è lasciato convincere?, si interroga la stampa più maliziosa. Nel secondo caso la sinistra dem avrebbe inferto un colpo mortale al feudalesimo solo 226 anni dopo la Rivoluzione francese. In entrambi i casi è evidente che la questione conta meno di zero. Ragion per cui occupa da giorni editoriali, commenti, vignette, indignate dichiarazioni su gran parte dei media italiani. Insomma sta in buona compagnia, quanto a rilevanza effettiva, con tutti gli altri “successi” conseguiti dalla sinistra del Pd sotto il regno di Matteo Renzi.
Intanto la legge di stabilità striscia nell’ombra verso l’approvazione garantita dalla fiducia. Furbetta, a volte roboante, nei confronti delle severe regole europee, ma tutto sommato piuttosto obbediente. Bruxelles potrà anche storcere il naso sulla detassazione della prima casa (che essendo un bene di consumo, contrariamente ad altre rendite da capitale, figura tra i bersagli prediletti dall’ideologia fiscale liberista dedita a garantire l’accumulazione del capitale) ma sa bene che il terreno perso potrà essere recuperato tra tagli, privatizzazioni e tassazioni indirette. Queste ultime, causa scatenante di innumerevoli rivolte nel corso della storia, godono oggi di un certo anonimato e scarsa attenzione. In fondo nessuno ti chiama a pagare per nome e cognome. Mal comune mezzo gaudio. Su questo piano siamo tutti ampiamente mitridatizzati e non c’è governo che non lo sappia.
Dunque, insiste Bruxelles e Roma recepisce, bisogna detassare il lavoro. Lo sgravio si sdoppia però in due voci: favorire i profitti d’impresa o la busta paga dei dipendenti, o entrambi in determinate proporzioni. Il risparmio fiscale delle imprese si suppone indirizzato agli investimenti e dunque a nuova occupazione. Si suppone perché trattasi di un risultato del tutto aleatorio. In primo luogo e nel migliore dei casi gli investimenti possono essere indirizzati alla sostituzione di lavoro vivo con lavoro morto. In secondo luogo, così come le enormi somme di denaro immesse nelle casse delle banche, i risparmi fiscali possono prendere la via del circuito finanziario. Infine, tasse o non tasse, se il mercato e cioè i consumi non “tirano”, gli imprenditori si guarderanno bene dall’assumere nuovo personale, come hanno più volte dichiarato. Consumi che dovrebbero invece crescere grazie al ridotto carico fiscale sulle buste paga, ma che, se fortemente tassati a loro volta come prescritto dalla dottrina liberista, non produrrebbero alcun effetto espansivo. C’è naturalmente la scommessa sul primato dell’export. Ma chi ci crede nell’attuale congiuntura globale? O nelle retoriche del «facciamo meglio della Germania»?
A forza di vantarci di non essere «come i Greci», sembra che lo stratosferico debito pubblico italiano sia completamente scomparso. Sono lontani i tempi in cui il «signor Spread» era più popolare delle star del calcio e oggetto di accalorate discussioni in ogni bar del paese. Compiti fatti, problema risolto. Questa l’orgogliosa narrazione governativa. Occupatevi, se vi garba davvero litigare, di manieri e scontrini.
E se, invece, fosse proprio l’esame e la rinegoziazione di quel debito e le regole di rientro stabilite dalle «istituzioni» europee il tema principale da affrontare quanto alla pressione fiscale e ai suoi effetti recessivi?
Certo non è facile, dopo aver sbeffeggiato Atene e sacralizzato gli interessi dei creditori, immaginando di poter rosicchiare in cambio qualche margine di tolleranza a Francoforte e Bruxelles. Magari sulla pelle dei migranti. «Quali tasse e quali tagli, lo decidiamo noi!», tuona il premier. Ma è evidente che non è affatto così, che la decisione sia imposta per via diretta o indiretta. Né prima, né durante, né dopo la crisi greca vi è stato alcun discorso serio sull’Europa e le sue politiche economiche e finanziarie da parte del governo di Roma, impegnato, semmai, in una gestione meschina (e perdente) del vantaggio nazionale. Cosicché la questione fiscale ci viene riproposta in termini assolutamente arcaici, quando non interessatamente banali, prescindendo allegramente dal peso della rendita finanziaria e dal dumping fiscale all’interno dell’Unione. Come una partita che possa risolversi all’interno dei singoli paesi o nella loro autonoma e furbastra contrattazione con Bruxelles. E’ il paradosso di quell’europeismo nazionalista che ha disgraziatamente occupato il campo del progetto di integrazione europeo.
Il governo di Atene ha appena licenziato la direttrice dell’agenzia delle entrate sulla quale sono state aperte due delicate inchieste giudiziarie. Si temono veementi reazioni da Bruxelles perché l’autonomia dell’organismo tributario dal governo ne risulterebbe minacciata. Organismo che si suppone debba, invece, sottostare alle ragioni indiscusse dell’austerità e dunque a quelle dei creditori. Ma non è il caso di preoccuparsi: «Noi non siamo mica la Grecia!»