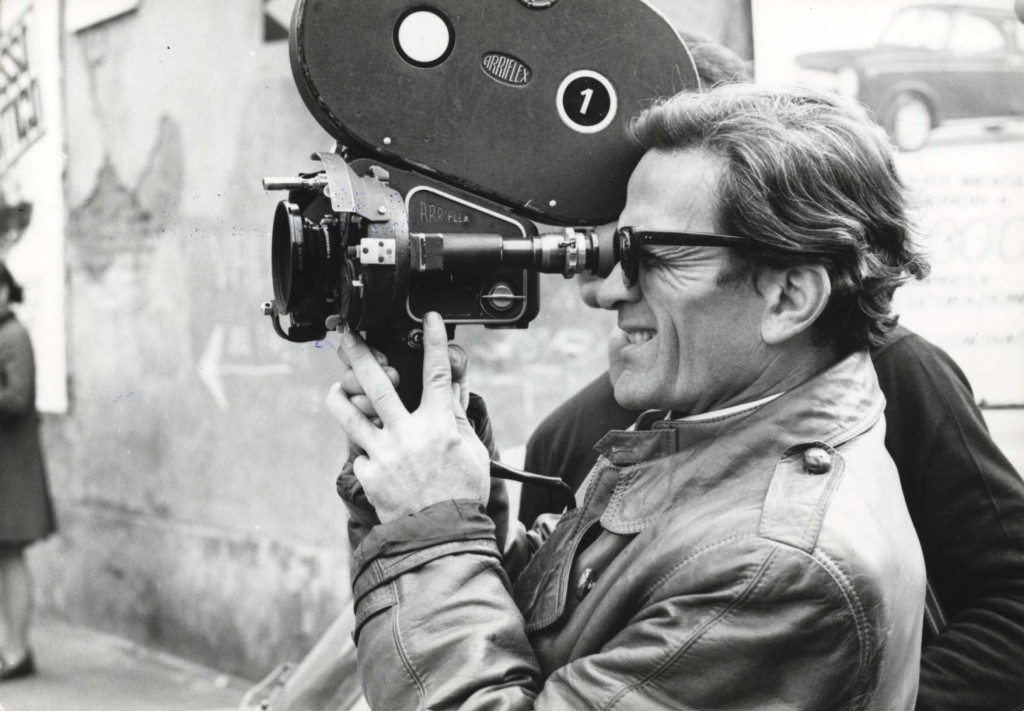Dal 16 ottobre 2013 al 26 gennaio 2014, la Cinémathèque française ospita Pasolini Roma: un esposizione, una retrospettiva dei film scritti e/o diretti da Pier Paolo Pasolini, una selezione di fiction e documentari sul tema. L’esposizione si trova al quinto piano. Ma il giro pasoliniano comincia prima ancora di staccare il biglietto. Il palazzo, inaugurato dieci anni fa, si trova a Bercy, in un’area situata tra la Gare de Lion e la Place d’Italie; che più che di un quartiere, si tratta di una terra di nessuno dove sono stati costruiti, accanto ad orribili palazzi moderni, la Biblioteca Mitterand e il Palazzo dello Sport. Arrivando, tornano alla mente le parole di Orson Welles ne La Ricotta e l’ultima inquadratura di Mamma Roma: quel controcampo sul quartiere nuovo dove la prostituta Roma Garofolo pensava di rifarsi una vita.
Negli anni, la Cinémathèque ha avuto molte sedi, la più famosa è senza dubbio Chaillot, ognuna in sincronia con la cinefilia del proprio tempo. Oggi, entrando, chi non è invitato si mette in fila davanti a casse che in nulla differiscono da quelle della FNAC. Le sale sono quanto di meglio la tecnica possa offrire per rendere giustizia al suono e all’immagine di un film. Una parte importante è pensata per ospitare incontri e occasioni mondane: strano ritorno dell’ambiente luminoso dell’entreacte, del teatro – quello che i primi cinefili rifuggivano riparandosi nelle sale oscure.
Entrando nella mostra vera e propria, è un testo di Pasolini a dare la direzione. In pochi versi, ecco ritratto il trasferimento a Roma «con la madre, una valigia e qualche gioiello che in seguito si è rivelato falso». Così, con un colpo di penna che sembra autoinferto, tutto un periodo della vita di Ppp è cancellato: la giovinezza, gli anni del Guf, i quaderni di Casarsa, la poesia in dialetto, ovvero il primo atto di antifascismo. Girando l’angolo, qualche ritaglio rimedia illustrando la morte del fratello e lo scandalo che porta l’esclusione dall’insegnamento e dal Pci – nella stessa sala, alcuni disegni e due autoritratti sono tra le cose migliori di tutto l’expo. Ma il dado è tratto.
Di Pasolini, qui, interessa la discesa a Roma. Coerente con il titolo spudoratamente felliniano, la mostra avanza seguendo una topografia precisa di cui la capitale è, come ricorda l’introduzione di uno dei tre dei curatori, Alain Bergala, «il fulcro». Ecco che il percorso è tappezzato da un lato di carte di Roma com’era negli anni sessanta e dall’altro di video realizzati recentemente dallo stesso Alain Bergala a Roma e dintorni. Al denominatore, comune a tutta la mostra, della città eterna, se ne aggiunge allora un altro. La mappa di Roma con le puntine numerate e le foto è di quelle che non possono mancare in un polizesco, dietro la scrivania del questore.
Le riprese di Alain Bergala al Pigneto ricordano la videosorveglianza tanto che molti, passando, si domandano se si tratti in effetti di immagini in diretta. Certo, per tutta la vita Pasolini è stato vittima del Codice Rocco e dei suoi fanatici esecutori. Certo, Pasolini è morto di morte violenta. C’è bisogno di utilizzare un metalinguaggio poliziesco per raccontarlo? Questi due segni, Roma da una parte e la retorica giudiziaria dall’altro, rivelano un’intenzione e un’ideologia.
Il linguaggio poliziesco sostituisce allora la guida Michelin, rassicura il consumatore che si tratta di un’autore [do action=”citazione”]L’intenzione di legare Pasolini ad una città che il francese semicolto ha visitato o ha voglia di visitare, ma non come un cinese qualunque, e l’ideologia localistica secondo la quale, come le trattorie per i turisti, una cosa non è vera se non è legata ad un territorio.[/do]maudit di origine controllata. Torna alla mente il sottotitolo della mostra: «Roma vista dal più scandaloso artista italiano del XX secolo». Dove Pasolini e Roma sono rispettivamente la sorpresa e il cioccolato di un uovo Kinder, entrambi trasformati in prodotto e pubblicità l’uno dell’altro. La sorpresa, in questo caso, è la territorializzazione di Pasolini, operazione legittima e nondimeno indigesta ché riduce a folklore e emozione il suo approccio politico e filosofico alla questione della cultura popolare. Che questa operazione sia il frutto di leggerezza, cinismo e incultura – più che di una cosciente revisione intellettuale, non stupisce. Come dice una celebre formula del libro 1 del Capitale, l’ideologia consiste in questo: «non sanno cosa fanno, ma lo fanno lo stesso».
Buona in sé l’idea di insistere sul Pasolini sceneggiatore – cui fa eco la retrospettiva. Ma la pista non va lontano. Questa volta, meno per limiti autoimposti che per semplice negligenza. Tra vari esempi di errori, salta agli occhi la teca con estratti della sceneggiatura delle Notti di Cabiria. È noto, perché Hervé Joubert-Laurencin ne parla in un articolo pubblicato nel numero 11 di Théâtre au cinéma (Bobigny, 2000), che ne esiste una versione di estremo interesse per capire la posizione di Pasolini rispetto ai cineasti e agli autori con cui lavorava perché Pasolini chiosa a mano il testo: «troppo realista», «troppo zavattiniano». Ci si aspetta di trovare questo esemplare. Altrimenti, perché mostrarla? Invece, ci si trova davanti un dattiloscritto muto.
Curiosamente, Hervé Joubert-Laurencin, che studia Pasolini da molti anni e che è l’autore, tra tanti libri e articoli preziosissimi, di un libro che da solo vale mille e un expo – Pasolini, portrait du poète en cinéaste (Editions de l’Etoile, 1995) – non è tra i curatori della mostra. Ci sono il già citato Alain Bergala, veterano della trasformazione del cinema in expo pubblicitari, accompagnato qui dal critico musicale Gianni Borgna e da Jordi Ballò: nessuno di questi ha dedicato un’opera monografica a Ppp. Nessuna competenza in realtà spiega la scelta di questi tre curatori se non quello che in Francia si chiama copinage.
Ma come è possibile che la Cinémathèque sia caduta così in basso? La risposta va cercata lontano nel tempo ma arriva qualche passo più in là, nella sala che illustra il momento in cui Pasolini, all’indomani degli scontri di Valle Giulia, dichiara (il Pci ai giovani) di stare dalla parte dei poliziotti. Studente che lotti, hai gli occhi di tuo padre: in questo verso c’è il ritratto dell’attuale direttore della Cinémathèque, Serge Toubiana. Entrato ai Cahiers du cinéma in quanto estremista di sinistra (subito dopo il 1968, cinefili e critici puri come Serge Daney e Jean Narboni si fanno impressionare da quelli che avevano esperienza politica), è il primo a convertirsi al nuovo corso e da quel dì a definire l’epoca maoista una sciagura.
Critico modesto ma scaltro politico allinea i Cahiers du cinéma alla politica culturale di Jack Lang. Con lui alla testa, i Cahiers si trasformano, da rivista di lotta e di critica, in un pantheon del cinema d’autore e, insieme, in un formidabile strumento di autopromozione sociale del proprio direttore e dei suoi collaboratori (che da allora diventano una corte). Alla testa della Cinémathèque, impone il suo stile e la sua capacità, impareggiabile, di produrre un’eterogenesi dei fini. Il motto di Langlois era: tutto il cinema va mostrato. Quello della nuova Cinémathèque è: tutto quello che mostriamo è cinema.