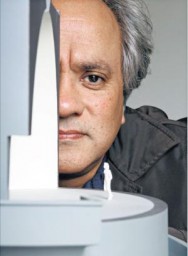Un suono che arriva da lontano, opprimente e allo stesso tempo liberatorio, accompagna il movimento dell’acqua che ruota verso il basso. Il vortice gira su se stesso, traducendo visivamente la drammaticità del ritmo sonoro. Alla II Biennale di Kochi-Muziris 2014, l’acqua di Water vortex veniva pompata direttamente dal mare, ben più complesso il meccanismo dell’installazione Descension (2015), che dà il titolo alla mostra personale di Anish Kapoor (Mumbai 1954, vive e lavora a Londra), in corso fino al 5 settembre alla galleria Continua di San Gimignano. Una mostra che presenta una serie di nuove sculture in alabastro, specchi, fiberglass e pigmenti, accanto a Endless Column (1992) con cui l’artista anglo-indiano coinvolge il pubblico nelle sue riflessioni giocate sui paradossi, o meglio sulla ricerca del superamento delle dualità. Che la sperimentazione fosse un aspetto fondamentale del lavoro di Kapoor era noto, ma vederlo al lavoro intorno al grande buco nel pavimento ligneo della platea dell’ex cinema teatro, osservando per quasi due giorni la gamma degli stati emozionali che si riflettevano sul suo volto, è stata un’esperienza preziosa. Sfida, ansia, delusione, perseveranza… finché non è arrivato il momento magico. Allora Anish Kapoor, circondato dal team di tecnici, ha calzato i guanti azzurri di lattice, ha preso in mano la busta trasparente con il pigmento nero e ha gettato il colore nell’acqua in movimento. Una performance privata che racconta il rapporto empatico tra l’artista e l’opera. Gli occhi scuri che brillano, il sorriso, la tensione allentata, un bicchiere d’acqua e, finalmente, è arrivato il momento per rispondere alle domande.
L’alchimia è anche un percorso di liberazione e crescita spirituale per chi la pratica. Il suo lavoro è spesso messo in relazione con questo antico sistema filosofico esoterico…
Non mi piace parlare in questi termini. Una delle cose che l’arte prova a fare è proporre le possibilità del materiale nel comunicare una condizione emozionale. In questo senso è alchemica. Però, sento di non avere niente da dire come artista. Non sono alla ricerca di messaggi da consegnare al mondo: se fosse così, il mio lavoro ne risulterebbe bloccato. È molto meglio lasciare che il processo di scoperta apra la possibilità dei significati, permettendogli di essere presenti. Ma, tornando all’idea che non ho niente da dire, di base sono un artista che lavora in studio, è la sperimentazione il vero processo attraverso cui arrivano continuamente le cose. Non dal punto di vista visivo o di riferimento, ma nel modo in cui i concetti profondi si ripetono. L’idea è quella che gli oggetti, qualsiasi oggetto nel mondo, non siano semplicemente tali. Occupano uno spazio a metà tra oggettività e possibili significati. Io li chiamo «non oggetti», sono in uno stato intermedio. È un qualcosa che torna sempre, anche se non lo faccio consapevolmente.
Nella sperimentazione del lavoro di studio si può parlare anche di gioco?
Il lavoro in studio è una pratica quotidiana. E ogni pratica creativa implica il gioco, almeno così dovrebbe essere. Prendersi troppo sul serio significa essere arroganti, spiritualmente e intellettualmente. Mi sembra giusta la vecchia idea che l’artista sia folle (ride). Come artisti quel poco che conosciamo non è molto interessante: un po’ di politica, un po’ di filosofia… Ah, che noia! Il nostro lavoro è avere un’intuizione rispetto a quello che non conosciamo, pensare che forse sia possibile. Proprio come fa un folle. Qualche volta, non sempre, arriva un momento di magia. Questo è il ruolo dell’artista: riconoscere quel preciso momento. Un momento in cui si vede anche la bellezza. Non ci si alza la mattina dicendo «oggi creo qualcosa di bello». Credo che anche Einstein abbia parlato di qualcosa di simile: la scienza lavora in maniera analoga. Il problema è che gli scienziati si prendono troppo sul serio. I grandi problemi dell’umanità – come la distruzione dell’ambiente, le guerre – finora sono stati messi nelle mani di politici e scienziati perché venissero risolti. Può darsi che sia ora di metterli in quelle degli artisti, che potrebbero risolverli in maniera eccentrica (ride).
Ha affermato di essere un pittore che è uno scultore. La scoperta dei pigmenti risale alla fine degli anni ’70, durante un viaggio in India: un incontro viscerale che si ripete nel tempo e che ha segnato profondamente il suo lavoro. Quali sono le possibilità del colore nel dialogo con forma e materia e qual è la relazione con il buio?
Sono molto interessato al colore in quanto fenomeno, ma l’ho sempre cercato come condizione. Il colore non è una superficie. Il rosso, ad esempio, è così rosso che è una condizione di rosso. Quando ci si confronta con il rosso è come entrare in quel colore. Quando facciamo la doccia l’acqua ci bagna, allo stesso modo voglio che il colore ci avvolga. La condizione del colore indica un aspetto fondamentale dell’astrazione. È interessante, perché il colore è immaginario, non è reale. E, inoltre, crea spazio. Se si passa una mano di rosso, blu, nero o qualsiasi altro, a un oggetto che è allo stato naturale questo muta. Può diventare più piccolo o più grande. Mi sembra una cosa molto curiosa, perché ci informa che non vediamo i colori solo con gli occhi, il colore è una condizione mentale astratta. Leggiamo così rapidamente che non m’interessa la composizione o l’accostamento di un colore a un altro, ma la totale condizione del colore che porta all’astrazione e al concetto filosofico. È una condizione molto sottile. Anche l’oscurità e l’assenza ne fanno parte. Ho realizzato tanti lavori in rosso: ha un’oscurità che è psicologicamente più profonda di quella del blu o del nero, che sono universali. Il rosso ha un che della nostra oscurità interiore, che è molto più buia di qualsiasi altra oscurità esteriore.
Oggetto, superficie, sguardo: momenti dell’esperienza funzionali alla creazione dell’opera e alla sua fruizione. Qual è la sfida maggiore nel trovare il loro equilibrio?
Sono sempre interessato all’idea che l’oggetto descriva se stesso attraverso la sua pelle. Non è la sua oggettività a parlare dell’oggetto, ma la superficie. Che sia uno specchio o un colore parliamo soltanto di micromillimetri, la pelle è come una membrana trasparente tra noi e il cosmo, tra mondo interno ed esterno. Come artisti quello che pensiamo di capire della realtà esterna è solo la proiezione interna del nostro cosmo personale e, come dicevo, la pelle è il passaggio tra l’uno e l’altro.
Alla base della sua idea di opera come luogo fisico e psichico in uno spazio illusorio, si scorge il pensiero orientale che, diversamente da quello occidentale, non si basa su un’idea di arte che ha come traguardo la certezza. Piuttosto sulla consapevolezza che non si arriva da nessuna parte se non si vive pienamente il presente. È così?
Non saprei esattamente cosa rispondere, certamente sono interessato a ciò che è incerto. È naturale che cerchiamo la certezza perché ci fa essere sicuri, mi sembra però che l’incertezza sia molto più stimolante se abbiamo la possibilità di tenerla a bada. Il traguardo dell’arte è profondamente misterioso. Non dobbiamo provare a fare qualcosa di interessante, perché che lo sia o meno non ci riguarda. Quello che facciamo è provare a cambiare il tempo. Questo è veramente importante, non è casuale che Barnett Newman abbia scritto del «nowness» dell’oggetto, ovvero dell’essere radicati nel presente dell’oggetto. Anche lo stesso Newman quando scrive del concetto del sublime parla del tempo che diventa più lungo. Il nostro senso temporale cambia quando ci relazioniamo a una poesia, alla musica e a un oggetto artistico. Quando siamo veramente presi, il tempo è qualcosa di mistico. Il tempo cambia come muta lo spazio. Un’opera prova simultaneamente a trattenerci nel qui e ora e a portarci in un’altra dimensione.
In una società dominata dall’horror vacui, qual è la sua strategia nella ricerca del silenzio interiore?
La maggior parte delle cose che ci circondano è robaccia. Siamo strapieni di cose non solo fisicamente, anche mentalmente. Da artista, come dicevo, sono sempre interessato a tutto, in particolare al «void object» (oggetti vuoti). Ma gli oggetti non sono mai completamente vuoti. Quando provo a vuotare uno spazio, mettendomi da parte come artista, è l’osservatore poi che lo riempie. Lo spazio è sempre gravido, pieno di paura o bellezza, oppure di tutti e due insieme, o ancora di qualcosa di terrificante o altro ancora. Un concetto che si ricollega a Kant e al sublime che non è qualcosa di lontano e indefinito, ma pieno di cose psicologiche. Possiamo parlare di oggetti post-freudiani vuoti che creano ansia, perché non sono realmente vuoti, ma colmi di timori.
All’interno di «Descension», infatti, sembra presente una citazione di Dante, ma anche di Freud…
Sì, decisamente. È la discesa nell’inferno di Dante. Il motivo per cui mi interessa il vortice, e anche l’opposto con la colonna di fumo bianco artificiale (Ascension, 2003 – n.d.R.), è creare un oggetto dal nulla, dall’assenza di materiale. Possiamo dire così che l’idea di Platone dello stare all’interno di una cava e guardare la luce al di fuori è il futuro nell’ideale del modernismo. L’estensione di questa logica è l’eroe tipo Parsifal o Thor. C’è, poi, l’aspetto dell’altra parte della cava, l’oggetto freudiano buio, interno, involuto che è l’opposto del razzo e, può darsi che sia legato al femminile, è problematico, incerto e, come dice Freud, «unheimlich» (perturbate). Dante indica la fragilità dell’umanità.
La sua idea di monumentalità che implica l’utilizzo di specchi – pensiamo a opere come «Cloud» «Gate», «Sky Mirror», «Turning the World Upside Down» – sembra stimolare una sensazione di equilibrio precario. Può essere un modo per entrare nella dimensione del tempo?
Ho sempre realizzato opere grandi. La scala è uno strumento della scultura. Penso che la paura quando si fanno cose enormi è che non significhino niente. Ma la scala è sempre misteriosa. Perché la grande dimensione non dovrebbe avere senso? Dipende da come si lavora. Quando si incontra un’opera molto grande si viene catturati. E questo non è affatto scontato. Quanto allo specchio, che uso molto, è come la pelle. Nella storia della scultura, lo specchio è stato usato in forma convessa. La maggior parte dei miei, invece, sono concavi. Solo con la scienza del ’700 e ’800 si comincia a usare la forma concava per mettere a fuoco la luce nei telescopi e altri strumenti scientifici. La forma concava cambia lo spazio. Gli oggetti concavi proiettano l’immagine non indietro, ma di fronte. Si verifica una condizione abbastanza strana, perché l’immagine è capovolta, lo spazio è invertito, come ho provato a fare con il Vortex.
Il titolo è parte integrante dell’opera, ma più che essere didascalico ne esalta il mistero, come in «Between Shit and Architecture» (2011), «A Ghosts Endeavour» (2012), «Symphony for a Beloved Sun» (2013)...
Non ho mai pensato a un titolo prima della realizzazione dell’opera. Credo che rappresenti un’altra parte del lavoro, un aspetto dell’oggetto. Mi interessa molto la poesia e sono convinto che le parole possano creare una condizione emotiva. La mitologia è una risorsa potente. Sono sempre ritornato alla mitologia, perché sono fermamente convinto che gli artisti non fanno oggetti, ma mitologia. Questo è il nostro vero ruolo.