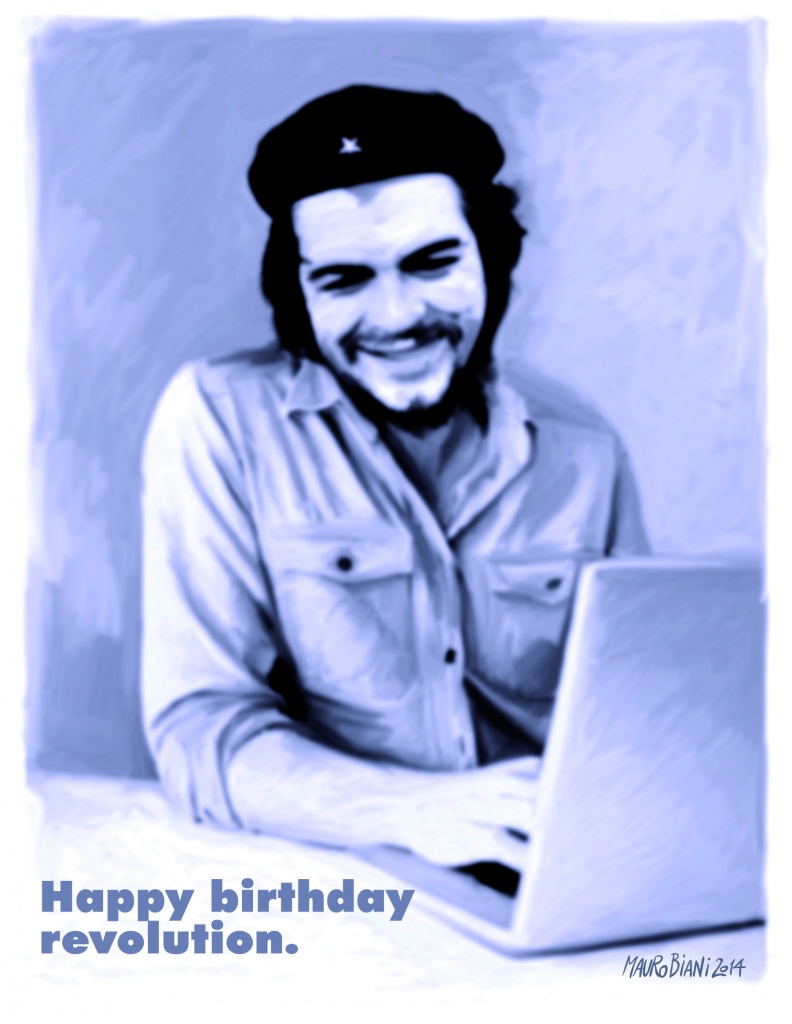All’indomani del «patto degli Apostoli» e dell’invito di Norma Rangeri a una nuova unità a sinistra, Tonino Perna invita alla prudenza e sollecita «una grande tessitura sociale e culturale di parole in grado di costruire la visione del futuro desiderabile e credibile». Ha ragione: il disastro renziano ha radici antiche e l’alternativa non può certo stare in una rivincita (seppur la cercasse) dell’establishment del Pd di ieri, che di quel disastro ha posto le premesse politiche e culturali (a cominciare dall’elevazione a stelle polari «delle leggi di mercato e della crescita economica senza se e senza ma»).
Ma questa necessaria tessitura deve accompagnarsi a una iniziativa politica immediata: perché il rischio di una desertificazione del tessuto sociale e istituzionale è sempre più forte e sul deserto è difficile anche ricostruire. Nello stesso tempo, non siamo all’anno zero ché i tentativi degli ultimi tempi, seppur improduttivi sul piano elettorale, non sono stati avari di elaborazione culturale. Una rinnovata iniziativa politica, che abbia l’ambizione di diventare egemone (e non solo di superare il quorum delle prossime elezioni, sperando che non sia troppo alto…), deve, peraltro, misurarsi con alcune questioni, troppo spesso eluse o esorcizzate e che stanno alla base degli insuccessi degli ultimi anni. Provo a indicarne alcune.
Primo. In tutte le recenti esperienze alternative e innovative ci si è mossi, talora teorizzandolo e comunque nei fatti, sul presupposto che le buone idee sono di per se sole, proprio perché buone, capaci di produrre in modo automatico l’organizzazione necessaria (e sufficiente). Non è così. Lo dico pur consapevole, da vecchio movimentista, delle degenerazioni burocratiche e autoritarie che spesso si annidano negli apparati. Contro queste derive va tenuta alta la guardia ma la sottovalutazione del momento organizzativo (e della sua legittimazione) è stata una delle cause principali della rissosità e della inconcludenza di molte aggregazioni politiche ed elettorali dell’ultimo periodo. Posso dirlo per esperienza diretta con riferimento a “Cambiare si può” (paralizzato dalla mancanza di luoghi di decisione e, per questo, facile preda di una nefasta e alienante occupazione). Ma lo stesso dimostrano le difficoltà in cui si dibatte la lista Tsipras.
Secondo. La bontà delle idee non ne garantisce, di per se sola, neppure la capacità di autoaffermarsi e di aggregare consensi. Il fatto nuovo della società dell’immagine – affermato da tutti ma non ancora compiutamente metabolizzato – è il primato della comunicazione sui valori. Sempre più persino chi è subalterno o marginale combatte battaglie non proprie, mobilitandosi e votando su parole d’ordine altrui più che a sostegno dei propri bisogni e interessi. Si spiegano così i successi di Berlusconi e di Renzi, che – modernizzando un copione antico – hanno attinto consenso e voti in maniera massiccia in strati popolari. La comunicazione, poi, ha oggi regole e modalità semplificatorie, assertive, spesso demagogiche. Non ci piacciono (o non piacciono a me). Ma da esse non si può prescindere, almeno oggi. Meglio, in ogni caso, adottarle – con il necessario distacco critico – per veicolare buoni progetti piuttosto che subirle con il loro carico di cattivi progetti… Nella odierna comunicazione fast food le parole contano più della realtà che rappresentano: occorre cambiare questa spirale perversa, ma per farlo bisogna saper usare le parole.
Terzo. Se questo è vero lo sbocco è conseguente. Abbiamo buone idee e buoni progetti ma continueremo, ciononostante, ad essere sconfitti e saremo ridotti all’irrilevanza (non solo alla minorità) se non sapremo esprimere nuovi linguaggi, semplificati e ripetitivi, ma capaci di dare concretezza a una prospettiva di eguaglianza e di emancipazione (la mancanza di una promessa attendibile di reddito decente per tutti ha fatto vincere chi ha dato a molti una mancia di 80 euro, pur sottratta con l’altra mano).
E lo stesso accadrà se non sapremo esprimere un personale politico radicalmente diverso da un ceto responsabile di sconfitte seriali (non scopro l’acqua calda se dico che nella resistibile ascesa di Renzi è stato determinante il contributo, miope quanto comprensibile, di chi lo ha votato «perché è il solo che può farci vincere»). E un nuovo personale politico dovrà avere un punto di riferimento riconoscibile e mediaticamente forte: non un uomo della provvidenza circondato da nullità che ne esaltano la funzione salvifica (come è stato ed è da due decenni), ma un uomo, o una donna, in grado di aggiungere un personale carisma a un gruppo autorevole e coeso. Anche questo provoca in noi (o almeno in me) non poca diffidenza. Ma il terreno e le modalità dello scontro non li decidiamo noi. Dovremo cambiarli, epperò – qui e ora – non possiamo prescinderne.
Arrivo così alla parte più difficile. Esiste oggi in Italia la possibilità di dar corpo a una prospettiva siffatta (come sta accadendo altrove: dalla Grecia alla Spagna)? Esiste, ma per costruirla bisogna uscire dal generico e avanzare proposte concrete, anche venendo meno al politically correct. Dunque ci provo.
Il nucleo forte della proposta politica non può che essere il lavoro, con le sue condizioni e i suoi presupposti, di cui riappropriarsi sottraendolo a chi lo distrugge ma, insieme, lo declama presentandosi come il suo vero e unico difensore. C’è chi può rappresentare questa prospettiva in modo non personalistico e con un riconoscimento diffuso, verificato in centinaia di piazze e – particolare non meno importante, secondo quanto si è detto – in centinaia di confronti televisivi. È – non devo certo spiegare perché – Maurizio Landini.
Lo so. Landini ha detto più volte che il suo posto è il sindacato e non la politica. È un atteggiamento fino a ieri comprensibile e apprezzabile. Ma oggi c’è una ragione aggiuntiva per chiedergli di farle il salto: il lavoro non lo si può più inventare, creare e difendere solo o soprattutto a livello sindacale. E le occasioni per ribaltare il quadro non si ripetono …