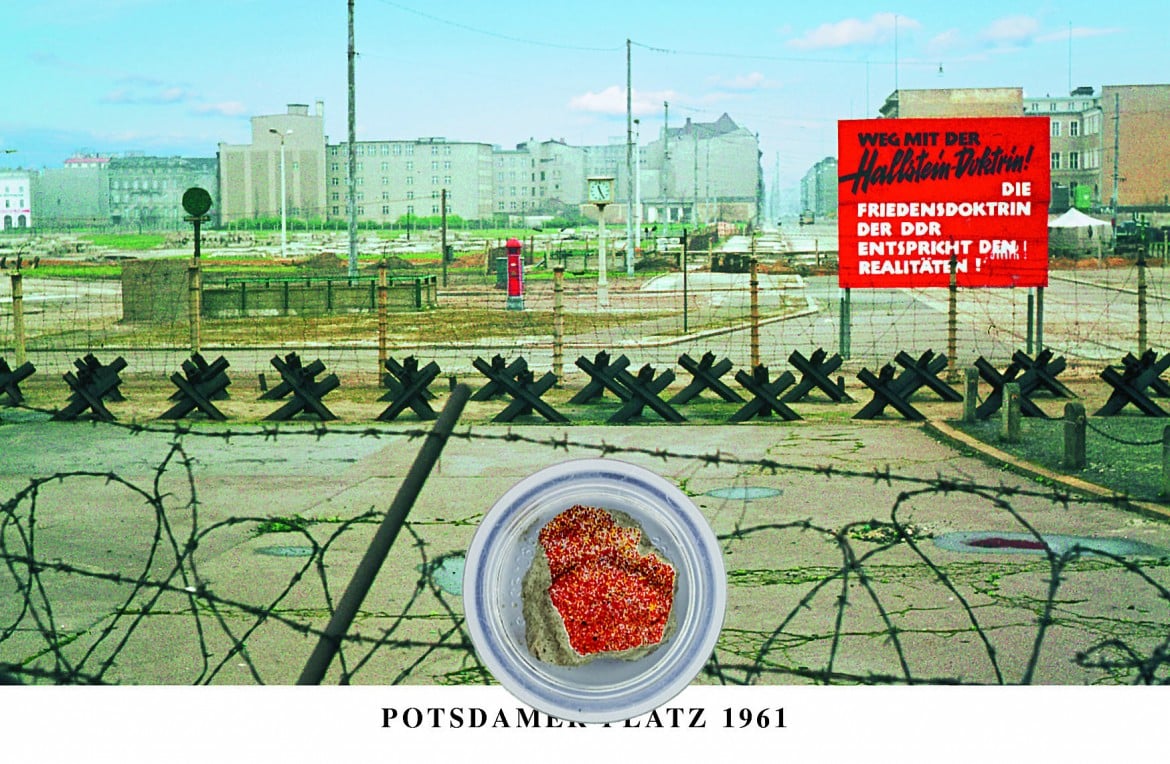La taz è il quotidiano tedesco nato nel 1978 ispirandosi a il manifesto. Michael Braun ne è il corrispondente dall’Italia, da oltre vent’anni impegnato a raccontare ai suoi concittadini la politica del nostro paese, e viceversa. Come ha fatto con Mutti. Angela Merkel spiegata agli italiani, libro del 2015, uscito per i tipi di Laterza.
Quel fatidico 9 novembre, mentre a Berlino cadeva il Muro, la sconosciuta 35enne ricercatrice in fisica che diventerà cancelliera si trovava in sauna, evidentemente non particolarmente coinvolta in ciò che stava avvenendo. Lei, Braun, invece dov’era?
Ero a Duisburg, città industriale dell’Ovest, dove lavoravo come ricercatore alla facoltà di scienze politiche. Guardavo in televisione, a casa mia, le immagini del portavoce del comitato centrale della Sed (il partito comunista, ndr), Günther Schabowski, che diceva che la frontiera fra le due Germanie era aperta «da subito». Come ormai si sa, le parole di Schabowski erano frutto di un equivoco, non era stata presa nessuna decisione di quel genere, ma il risultato fu che le tv della Germania ovest e poi di tutto il mondo diedero la notizia che gli espatri dalla Ddr erano possibili senza alcuna formalità, e la gente cominciò ad ammassarsi ai valichi berlinesi. Osservavo quel che accadeva con stupore e, devo confessare, con inquietudine.

Stupore perché non ci si aspettava un’evoluzione di quella portata così rapidamente. E l’inquietudine nasceva dalla trasformazione del movimento di protesta della Ddr che avevamo di fronte. Inizialmente la sua parola d’ordine era stata «Wir sind das Volk», cioè «Noi siamo il popolo», l’obiettivo era la democratizzazione contro il potere dell’apparato del partito; poi divenne «Wir sind ein Volk», cioè «Noi siamo un popolo», a significare che l’unico traguardo era la riunificazione. Noi militanti della sinistra della Germania ovest speravamo in una riforma della Ddr che portasse a un socialismo democratico, che era quel che voleva anche l’élite della protesta dell’Est fatta di personalità come Christa Wolf, Heiner Müller e Stefan Heym. Nella grande manifestazione ad Alexanderplatz del 4 novembre, nessuno dei leader chiedeva la fine della Ddr. Ma la massa che si mobilitava, in realtà, aveva un’agenda diversa.
Vi preoccupava un possibile ritorno del nazionalismo tedesco e di una «grande Germania»?
Sì. Nella sinistra occidentale la riunificazione era vista come un rischio. Non solo negli ambienti più radicali e alternativi, ma anche nella Spd. Oskar Lafontaine, all’epoca governatore della Saar e dirigente socialdemocratico di primo piano, parlò di «ubriacatura nazionale», Gerhard Schröder, futuro cancelliere, tacciò la riunificazione di essere un «progetto reazionario ed estremamente pericoloso». Il timore era che si abbandonasse la strada dell’integrazione europea e che si tornasse al cosiddetto deutscher Sonderweg, la «via particolare tedesca» che aveva portato a due guerre mondiali. Questa paura non era molto diversa da quella che fece dire a Giulio Andreotti che amava così tanto la Germania da essere contento che ce ne fossero due.
Un socialdemocratico che invece plaudì da subito all’ipotesi di riunificazione fu Willy Brandt.
È vero, ma è una posizione che assunse proprio in quei giorni, prima era riluttante anche lui. Quando cadde il Muro Brandt capì che la Spd non avrebbe potuto diventare un punto di riferimento per le masse della Ddr se avesse dato l’idea che preferiva il mantenimento di due stati diversi. Fra le élite della protesta dell’Est e il grosso del popolo tedesco-orientale, Brandt scelse quest’ultimo. E lo fece perché sapeva che nella Ddr posizioni come quelle di Lafontaine erano condivise solo dagli intellettuali e dai militanti riformatori più avvertiti, ma non dalle larghe masse. Infatti il successivo 18 marzo del ’90, alle prime e ultime elezioni libere della storia della Ddr, la Cdu del cancelliere Helmut Kohl sconfisse clamorosamente la Spd (48% contro 21,9%, ndr) e al governo della Germania est si insediò il democristiano Lothar De Maizière fino alla riunificazione del 3 ottobre.
Il nazionalismo di cui avevate timore, però, non tornò. È apparso clamorosamente venticinque anni dopo, con la destra populista di Alternative für Deutschland (Afd). È l’avvelenato frutto tardivo della riunificazione o qualcosa di diverso?
Se parliamo dell’intero paese, non credo che l’Afd si debba alla riunificazione in sé. La sua presenza sulla scena politica rende la Germania simile agli altri stati europei: i populisti ci sono ovunque e ovunque la sinistra è in crisi fra i ceti popolari. Quel che intendo dire è che l’Afd che prende il 10-12% nei Länder dell’Ovest è, purtroppo, una cosa «normale» in questo momento storico. Ciò che deve preoccuparci è il suo successo nella ex Ddr, e qui il discorso sulla gestione degli anni successivi alla riunificazione c’entra moltissimo.
Insomma, qualcosa è andato storto dopo l’89.
Certo. In sintesi si può dire che non si sia trattato di una vera riunificazione fra due stati, ma quasi dell’annessione dell’Est nell’Ovest. Non nacque una nuova Germania, fu la Repubblica federale ad allargarsi. Per i cittadini della Ddr ha voluto dire una cesura nelle loro biografie di proporzioni enormi: un trauma storico che non è stato elaborato, e i frutti di tale mancanza si vedono ora.
Eppure Merkel, la cancelliera che si avvia a diventare la più longeva della storia, è una ex cittadina della Ddr: come risarcimento simbolico avrebbe potuto funzionare…
Sì, Merkel è dell’Est, ma lei non ha mai giocato quella carta, non ha mai fatto della sua biografia un tema politico. E va detto che se c’è una figura che è odiata dagli elettori della Afd nella Germania orientale è proprio la cancelliera, a causa della sua politica delle frontiere aperte, che per la verità, come noi sappiamo bene, è durata pochissimo. Detto ciò, quando mi riferisco al trauma storico, parlo di una dimensione non solo simbolica: in milioni persero il lavoro nelle fabbriche e negli uffici, improvvisamente ciò che sapevano e facevano diventava senza valore. Si è calcolato che l’80% dei cittadini dell’ex Ddr nei primi anni Novanta dovette ricominciare da zero: un fatto che non è mai stato preso sul serio dalla politica. E per altro verso quasi tutte le posizioni lavorative delle élite, dall’università alla magistratura e alle amministrazioni, venivano occupate da persone dell’Ovest. A queste condizioni si può capire perché si è diffusa la sensazione di essere stati colonizzati.
Per molto tempo a intercettare questi stati d’animo fu la forza che traeva origine dalla trasformazione della Sed: quella che ora si chiama Linke e dopo la caduta del Muro si chiamò Pds, partito del socialismo democratico. Adesso non è più così, se si eccettuano le recentissime elezioni in Turingia. Perché?
Molti elettori sceglievano in passato Pds e poi Linke non perché fossero persone di sinistra, ma perché volevano votare una sorta di «Lega Est». Adesso a proporsi come tale è l’Afd, e lo fa in modo smaccato, giocando su una sorta di vittimismo nazionalista, malgrado i suoi dirigenti provengano tutti dai Länder occidentali.
Nella fortuna dell’Afd nella ex Ddr si può trovare anche un effetto di lunga durata di una mentalità autoritaria che, sconfitto il nazismo, si riprodusse anche se in forme diverse nel regime di Berlino est?
Sì, certamente. Alla Ddr è mancato il Sessantotto, che invece abbiamo avuto all’Ovest. Nella Germania federale è stata la rottura politica e generazionale rappresentata dal Sessantotto che ha permesso di fare davvero i conti con il nostro passato nazista. La fatidica domanda «dove eravate e cosa avete fatto dal 1933 al ’45», rivolta dai figli ai padri, nella Ddr non ci fu. E poi c’è un’altra questione decisiva, l’immigrazione: la società dell’Ovest era multiculturale già dagli anni ’60 e ’70, mentre gli stranieri presenti nella Ddr vivano in contesti a parte, senza lasciare traccia. C’erano lavoratori dal Vietnam o dal Mozambico, ma non c’erano ristoranti vietnamiti o mozambicani a Berlino est. La Ddr era un paese del tutto monoetnico e monoculturale.
L’ombra della Afd grava quindi su questo trentennale. Con quali sentimenti lei vive, oggi, il ricordo di quell’evento epocale?
Continuano a essere sentimenti contraddittori. Intendiamoci: quel che avvenne il 9 novembre era inevitabile e bisogna riconoscere che la libertà vive non solo quando accadono le cose che preferiremmo noi, ma quando accade ciò che vogliono i protagonisti degli eventi. La caduta del Muro e la riunificazione furono vittorie della libertà e della democrazia, noi della sinistra tedesca allora non lo capimmo subito. Detto questo, ciò che è venuto dopo, la liquidazione dell’economia e delle strutture sociali della Germania est, non può essere considerato positivo. Se negli anni Novanta le cose fossero andate diversamente, forse oggi nei Länder orientali la destra populista non troverebbe il terreno fertile che, purtroppo, trova.