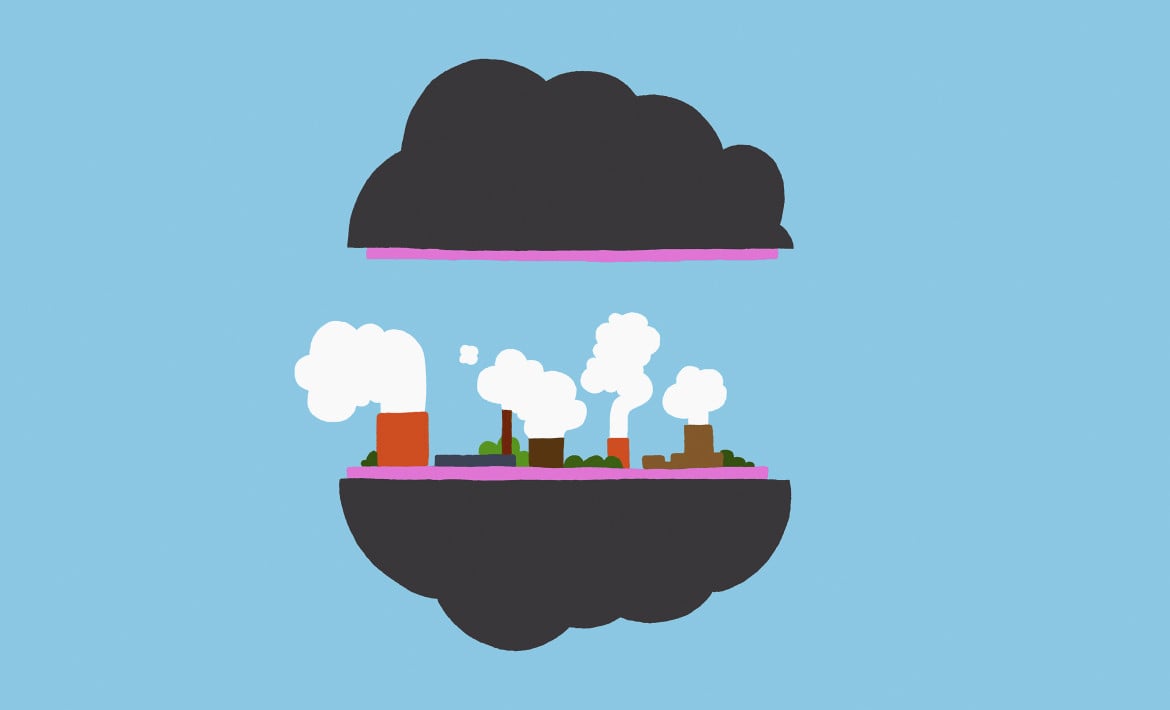Crescita al palo, consumi fermi, disoccupazione in aumento. Gli ultimi dati Istat su economia e lavoro rimettono sul tavolo le vere emergenze, smontando, di fatto, gran parte della narrazione giallo-verde sulla manovra.
Dopo tre anni, il Pil non fa registrare alcuna variazione rispetto al trimestre precedente (solo un +0,8% su base annua), mentre torna a salire il tasso di disoccupazione e cresce il lavoro instabile (184 mila contratti stabili in meno a settembre). Fermo anche il «carrello della spesa» (variazione nulla dei prezzi ad ottobre rispetto al mese precedente), con lieve aumento dell’inflazione su base annua grazie solo ai prezzi dei beni energetici e dei servizi.
È il quadro di un’economia stagnante, in affanno, che fa i conti con una questione sociale sempre più allarmante.
Eppure, qualcosa è cambiato in questi anni. E non si tratta di un qualcosa di poco conto.
Ci eravamo lasciati, prima della crisi, con una cartolina del Belpaese sulla quale campeggiava un profondo squilibrio dei nostri conti con l’estero, ci ritroviamo, oggi, a condividere il podio europeo dei paesi con il più alto surplus commerciale insieme alla Germania e all’Olanda.
Quante volte avete sentito parlare di un’Europa tagliata a metà, tra un nord creditore e un sud debitore (paesi Piigs)? Bene, questa fotografia non corrisponde più alla realtà. Nel caso dell’Italia, basta leggere una qualsiasi tabella che descrive la sua «posizione patrimoniale netta sull’estero» (saldo delle attività e passività finanziarie nei confronti di soggetti non residenti) dal 2011 ad oggi. Siamo passati da una situazione debitoria «netta» pari al 20% del prodotto lordo al quasi pareggio (3,4% del Pil nel secondo trimestre del 2018).
Numeri eccezionali, che, da un lato, denotano un allineamento del nostro paese agli standard delle economie più forti del continente, dall’altro un progressivo allontanamento dal modello di accumulazione che, per alcuni decenni, ha provato a tenere insieme sviluppo economico e coesione sociale.
Un primo indicatore di questa deriva si ricava, facilmente, dall’erosione della quota salari in rapporto al reddito nazionale. Non un fenomeno recentissimo, beninteso, che ha subìto però un’accelerazione significativa nell’ultimo ventennio, con un crollo del tasso di crescita a partire dal 2009, in corrispondenza delle decisioni europee volte a contrastare la cosiddetta «crisi dei debiti sovrani».
Rigore finanziario, deflazione salariale, contenimento del costo del lavoro (la quota salari sul reddito nazionale si è ridotta a poco più del 50%, dal 70% circa che era negli anni settanta), usati come leve per rimodellare le economie europee, accrescendone il potenziale competitivo verso l’esterno. Un’opera di macelleria sociale che ha scaraventato nella povertà milioni di persone. E messo un freno alla stessa economia: export alle stelle che fa il paio con una persistente stagnazione economica.
Perché? C’entrano il potere d’acquisto dei lavoratori, la disoccupazione ancora elevata (sempre di più quelli che un lavoro non lo cercano più), la bassa domanda interna, la povertà dilagante, le disuguaglianze.
A proposito di quest’ultime, studi recenti dell’Ocse hanno sottolineato che negli untimi vent’anni, in paesi come l’Italia, la crescita economica sarebbe stata di 6-9 punti più alta se non fosse aumentata la disparità tra i redditi.
Di fronte alla stima dell’Istat sull’andamento del Pil, il governo ha dichiarato che era «tutto previsto» e che la manovra di bilancio contribuirà ad invertire la tendenza. Che un rallentamento dell’economia, anche per effetto di alcuni fattori internazionali (tutta l’Europa è in frenata), fosse prevedibile, non c’è dubbio. Meno giustificato appare invece l’ottimismo del governo sugli effetti espansivi (e redistributivi) della manovra.
Né il taglio a casaccio delle tasse alle imprese (anche alle società di capitali, con annessi incentivi all’assunzione precaria) ed ai professionisti (e il condono per gli evasori), né il falso «reddito di cittadinanza» (rischia di assecondare la dinamica salariale al ribasso), d’altro canto, sono gli strumenti adatti per sanare la piaga della povertà e quella della disuguaglianza, causa principale della bassa crescita.
Abbiamo bisogno d’altro. Più salario, più lavoro stabile, più investimenti pubblici, più progressività fiscale, più welfare state (compreso il «reddito di base»). Per questi obiettivi, il deficit stimato dal governo (per l’anno in corso e per i prossimi anni) sarebbe pure poco, ma il «gioco», almeno, varrebbe la candela.