«Il buco di culo in plastica del mondo». Quando pronunciò questa frase William Faulkner si trovava in una fase acuta del suo rapporto di amore-odio verso Los Angeles. Fu più lirico lo scrittore beat Herb Gold: «Oh, trovarsi a Los Angeles, quando gli alberi in polietilene sono in fiore!». L.A., ovverosia plastica e celluloide. La civiltà fossile qui significa fiumi di carburante per distanze urbane immense e il tanfo delle Tar Pits, le pozze bituminose dalle quali emergono mammut in plastica che ricreano per i visitatori la California primitiva, quando non era ancora punteggiata di pozzi petroliferi. Anche Andy Warhol si entusiasmava per il trionfo sintetico di Hollywood e avrebbe voluto «essere di plastica». Inutile cercare il bandolo di Los Angeles: una montagna di opposti sulla quale si sono arrampicati filosofi, sociologi, futurologi, scrittori di noir, registi e turisti del selfie, in un ambiente urbano da set cinematografico, dove ruota un vortice di immaginari. Qui si trovano sia l’epicentro mondiale del cinema sia quello della faglia di San Andreas che provoca regolari scosse di terremoto e minaccia la distruzione totale. Qui il mito americano evapora sotto lo smog dell’ultimo antropocene. Secondo la scrittrice satirica Fran Lebowitz, spogliata dagli ismi, L.A. rimane «una grande area cittadina che circonda il Beverly Hills Hotel». Eppure un altro albergo, lo Chateau Marmont, possiede gli ingredienti del mito in purezza, pur vantando un aspetto europeo e una solidità antisismica che trionfa sulla plastica. La scrittrice A.M. Homes, incaricata dal National Geographic di scrivere un reportage su Los Angeles, scelse questo hotel come base per esplorare una città che «attrae per tutte le ragioni sbagliate». Partendo da questo mito, il critico cinematografico e scrittore Shawn Levy ha condotto un puntiglioso lavoro di ricerca per raccontare il Marmont, un luogo attraversato dai tanti protagonisti di Hollywood che hanno amato Il castello di Sunset Boulevard (Edt, pp. 402, euro 24). Il Marmont, come Hollywood, secondo Levy è «più eccitante della vita reale anche se è chiaramente un’illusione», un sunto dell’epopea americana.
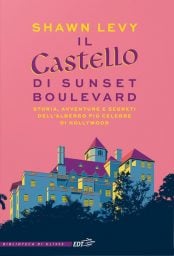
PORTO SICURO
Appartato rispetto al traffico di Sunset Strip, celebrato per la miscela di «decadenza, moda, musica, sesso, segretezza e libertà» il Marmont domina come una «rocca di Gibilterra» l’agglomerato urbano i cui confini ormai si indovinano solo dal satellite. Sarà ancora un «porto sicuro», per le stelle in cerca di privacy come indica il suo motto, ma da anni questo castello, nato nel 1927 – per Hollywood il paleolitico – vende un sogno griffato come la maison Gucci (partner del Marmont) o come un ristorante stellato, con le celebrità come piatti gourmet. Il panorama ricorda quello che si presentava decenni or sono al protagonista del Giorno della locusta di Nathanael West durante una passeggiata per Hollywood. Qui uno chalet svizzero confinava con un tempio egizio, là una pagoda cinese con un maniero del Reno e il personaggio rifletteva tra sé: «È difficile ridere dell’aspirazione al bello e al romantico, per quanto i risultati di tale aspirazione possano essere di cattivo gusto o addirittura orribili». In quel mare kitsch troneggia da una collinetta il Marmont, non lontano dalla strada che sale al Laurel Canyon. A est brilla Hollywood, dietro si intravede lo skyline del centro città e a sud Beverly Hills con tutti i suburbi che fanno parte della costellazione di L.A., separati da fiumi di asfalto.
Fred Horovitz, l’ideatore dello Chateau, era un avvocato del centro che annusò l’aria carica di affari dei ruggenti anni Venti e decise di buttarsi nel ramo immobiliare in quella che all’epoca era una periferia. Quando posò lo sguardo da questa specie di grand’angolo ai suoi piedi vide orti urbani, tante fattorie e le prime ville isolate degli attori. Si ispirò a un castello della Loira e da lì venne il nome Chateau, mentre Percy Marmont era un attore inglese del cinema muto in onore del quale era stata ribattezzata la stradina laterale che saliva fino a un campo di cipolle. Il castello-fortezza, costruito con criteri antisismici, aprì come residence di lusso nel febbraio del 1929. Doveva essere un pied-à-terre per la «high society» californiana, ma il crollo della borsa rovinò molti paperoni locali. Il secondo proprietario, Albert E. Smith, era un uomo della nuova Hollywood che aveva fatto i soldi con il cinema, partendo da un proiettore Edison e fondando una casa di produzione. Nel frattempo la strada sottostante, una terra di nessuno sul confine tra Los Angeles e Beverly Hills, si sviluppava come quartiere blue light, un luogo trasgressivo dove le maglie della legge erano tolleranti su alcool e sesso e dove si aprivano locali notturni. Nasceva il mito della Strip di Hollywood e al Marmont approdava il primo manipolo di attori, tra i quali spiccava il «triangolo» tra la bomba sexy Jean Harlow, il suo fascinoso amante e partner sullo schermo Clarke Gable e l’eccentrico regista-industriale Howard Hughes.
SCANDALI E ARTE
Il castello iniziò a costruirsi la fama di luogo appartato, dove consumare i propri vizi in segreto. Volendo si accede dai garage senza passare dalla reception e il piccolo ingresso non consente ai giornalisti o ai fotografi di stazionarvi. Glenn Ford, William Holden, David Niven, Humphrey Bogart, Stan Laurel, Billy Wilder, Greta Garbo, John Wayne sfruttarono il luogo per consumare divorzi e vivere avventure extraconiugali.
Novant’anni di cambi di proprietà e scandali, ma anche tanta arte. In uno dei bungalow dell’albergo, tra un disco di bebop e uno di classica, il regista Nicholas Ray sceneggiò con James Dean Gioventù bruciata, The Band vi soggiornò per terminare l’album Music from Big Pink, Gore Vidal, tra una chiacchiera con Paul Newman e qualche avventura erotica iniziò La Statua di sale, il romanzo di un contrastato amore omosessuale. Vidal vi tornò spesso in cerca d’ispirazione. Un’ossessione era l’insegna del vicino hotel Sahara, una gigantesca cowgirl girevole, richiamo di plastica per i clienti che Vidal scrutava dalla finestra della sua camera e che inserì nel romanzo Myra Breckinridge. Dalla sua stanza al Marmont, la protagonista Myra si immedesimava nella solitudine dell’enorme statua con il sombrero costretta a girare giorno e notte: «Adorata ma non amata, come me. Per me rappresenta Hollywood e ha un potere ipnotico». Ne venne tratto un film, Il caso Myra Breckinridge (1970), un fiasco di proporzioni colossali del quale rimane solamente l’immagine di Raquel Welch nei panni della protagonista a chiacchierare in una camera dell’hotel con la ballerina sullo sfondo, riprodotta in copia con le forme statuarie dell’attrice.
Il primo musicista importante a stazionare allo Chateau fu un artista perfettamente a suo agio in quegli spazi un po’ nobiliari: Duke Ellington. Lì vennero messe su pentagramma la colonna sonora di Anatomia di un omicidio di Otto Preminger e la versione jazz del Peer Gynt di Grieg. L’albergo, noto per la sua politica contro le discriminazioni razziali, ospitò in seguito Quincy Jones, Nina Simone, Harry Belafonte, Sarah Vaughan, Odetta, Miriam Makeba, Richie Havens, Erroll Garner, Miles Davis. Sidney Poitier, sul grande schermo star del fiabesco matrimonio interrazziale cinematografico di Indovina chi viene a cena?, nella realtà non poteva affittare una casa a Beverly Hills e doveva riparare al Marmont.
Gli anni Sessanta rinnovano Sunset Strip: i vestiti eleganti degli aspiranti attori lasciano il posto all’abbigliamento hippie. Nascono locali con musica dal vivo e al Whisky a Go Go debutta un gruppo di replicanti dei Beatles, i Byrds. In zona stazionano Mamas and Papas, Love, Frank Zappa. La zona sta cambiando, ma Los Angeles non è San Francisco: qui regnano i soldi e ci sono speculazioni in corso che non contemplano la controcultura. Una di queste, la Laurel Canyon Freeway, una superstrada di collegamento diretto tra le colline a nord e l’aeroporto, era in fase di studio. Si trattava di un affare colossale che prevedeva lungo il percorso nuovi quartieri e centri commerciali. Purtroppo nel mezzo si trovava la strip e bisognava sloggiare i locali e la massa di ragazzini che cresceva giorno dopo giorno. I soldi misero in moto la politica che fece valere vecchie leggi sul coprifuoco, scatenando controlli continui delle autorità sui locali giovanili. Nel novembre del 1966 uno dei club, il Pandora’s Box, situato di fronte al Marmont, fu al centro di violenti scontri tra polizia e ragazzi. L’ordine doveva servire a velocizzare la speculazione, ma i giovani bianchi del ceto medio non erano i neri di Watts repressi brutalmente l’anno prima; sfasciare le teste degli studenti divideva l’opinione pubblica. Il risultato fu che il Pandora’s Box venne demolito, molti locali di musica chiusero e gli hippie nel ’67 si riversarono a San Francisco dove stava decollando la Summer of Love, ma insieme finì nel cestino anche il progetto dell’autostrada e di tutta la vicenda rimase nell’aria solo For what It’s Worth, la canzone ribelle dei Buffalo Springfield. Sunset Srip avrebbe nuovamente cambiato pelle negli anni a venire, nel frattempo il Marmont diventò, come per gli attori, un ritrovo per rocker in cerca di tranquillità. I gruppi rock con gli entourage di guardie del corpo, addetti stampa, groupie, sanguisughe e perditempo erano carrozzoni che richiedevano alberghi enormi e capacità di sopportazione (o demolizione). Alla Hyatt House John Bonham aveva percorso i corridoi interni in moto, Alice Cooper giocato a football nudo nella hall, Keith Richards e Keith Moon fatto svolazzare dei televisori dalla finestra.
FESTE NOTTURNE
Lo Chateau, fedele alla sua tradizione, proteggeva la privacy e le bizze dei clienti, ma non tollerava le manifestazioni troppo appariscenti di nichilismo distruttivo del rock. I Led Zeppelin ci andarono la prima volta nel 1968, quando erano ancora acerbi e non si permisero quegli eccessi che avrebbero caratterizzato i tour degli anni Settanta. I musicisti venivano comunque dirottati sugli appartati bungalow esterni dell’albergo che permettevano di gestire festini e via vai notturni senza disturbare il ménage degli altri ospiti nel complesso principale. Jim Morrison fu il più assiduo al Marmont (celebre la sua caduta mentre usciva dalla finestra aggrappato a una grondaia esterna, una scena immortalata da Oliver Stone in The Doors). Se l’elenco degli attori è infinito anche i musicisti che passano dal Marmont non sono pochi. Vi troviamo Gram Parsons, Bob Dylan, Janis Joplin, Jackson Browne, Phil Spector, i Velvet Underground, Neil Young, Carly Simon. Si favoleggia che al pianoforte collocato nel salotto comune abbiano suonato George Shearing, Annie Lennox, Rickie Lee Jones e che Van Morrison abbia improvvisato un programma di canzone natalizie per i dipendenti dell’albergo.
L’inaccessibilità rimase per decenni il punto di forza del Marmont. Roman Polanski vi si barricò nel 1977: ascoltava jazz tutta la notte mentre attendeva di espatriare per sfuggire alle accuse di stupro ai danni di una minorenne. Se i festini a base di droghe e sesso del soul singer Rick James erano noti solo alla ristretta fauna hollywoodiana, gli inizi degli anni Ottanta portano con John Belushi quella celebrità in negativo che il Marmont non aveva mai desiderato. Nella sua ultima folle notte di droghe si incrociano visite e telefonate degli amici Robert De Niro e Robin Williams. Poi al mattino la scoperta casuale del decesso nel suo bungalow; ambulanze, polizia e giornalisti piombano in loco e il nome dell’albergo entra nella cronaca. Il maniero diventa simbolo «dell’opulenza, dell’indulgenza e della cupidigia» di Hollywood (sono le parole usate da Michael Connelly nel romanzo La Caduta). Un fascino che attira i turisti del morboso, alimentato da clienti fissi come il decano del gonzo journalism Hunter H. Thompson o il fotografo Helmut Newton (che morì nei pressi della struttura in un incidente automobilistico). In questa fase la silhouette gotica del Marmont rappresenta la Hollywood Babilonia dei libri di Kenneth Anger, un altro fan dell’albergo.
PASSAGGIO FINALE
Il passaggio finale dalla cronaca nera al circo pop avviene nel nuovo millennio, grazie all’attuale proprietario André Balazs, possessore di un impero nel settore alberghiero. Il piacente, spregiudicato Balazs (recentemente accusato di molestie da Me Too) ne ha fatto un luogo esclusivo per degustazioni di vini pregiati, sfilate di moda, party promozionali all’uscita dei film. I cantanti Lana Del Rey e Jarvis Cocker lo rendono protagonista dei loro brani. Nel garage del Marmont la coppia glamour Beyoncé e Jay-Z offre un party esclusivo per la notte degli Oscar 2018. Da attori e scrittori bohémien si passa alle celebrità del jet set e anche gli scandali si adeguano: dai debiti per le feste pazze di Lindsay Lohan al presunto amplesso in ascensore tra Scarlett Johansson e Benicio Del Toro.
Assurto allo status nostalgico di luogo dell’epoca d’oro di Hollywood, diventa un palcoscenico per interviste ai registi Jim Jarmusch e Spike Lee, a superstar come Bono Vox e Sting, ad attori come Klaus Kinski e William Hurt. Dopo averne ospitati tanti, il Marmont passa al ruolo di attore protagonista, di quelli che sullo schermo rifanno sempre sé stessi. Diventa set di Occhi di serpente (1993) di Abel Ferrara e Somewhere di Sofia Coppola, Leone d’oro a Venezia nel 2010.
Shawn Levy chiude il libro scrivendo che l’aspetto massiccio del Marmont «fornisce una solida base a un’attività e a un tratto di strada che spesso sembrano inclini a fluttuare nell’etere, evanescenti e privi di gravità». Forse lo Chateau è fatto della stessa sostanza dei sogni che si materializzano e, nel caso specifico, il viverli non costa meno di cinquecento dollari a notte, carta di credito alla mano.
FUORI I DISCHI
Ecco una manciata di canzoni dedicate alla Città degli Angeli. Profumano di anni Sessanta For what It’s Worth dei Buffalo Springfield, L.A. Woman dei Doors, West L.A. Fadeaway dei Grateful Dead. Il rock successivo ha prodotto Hollywood Nights di Bob Seger e Free Fallin’ di Tom Petty, l’hard rock edonistico anni Ottanta Girls Girls Girls dei Mötley Crüe e Welcome to the Jungle dei Guns N’ Roses, i Novanta Under the Bridge dei Red Hot Chili Peppers. Joni Mitchell ha cantato il suo folk sofisticato in Ladies of the Canyon e John Mayall ha esplorato Hollywood in Walking on the Sunset. La black music va dal blues di B.B. King (Back in L.A.) al funk dei War (Low Rider), fino all’hip hop West Coast con To Live and Die in L.A. di 2Pac e The Recipe di Kendrick Lamar.
Tom Waits Blue Valentine (Asylum, 1978)
Waits ha vissuto anni da bohémien al Tropicana Motor Hotel sul Santa Monica Boulevard e ha dedicato tante canzoni a Los Angeles (su Tomwaitsmap.com trovate i posti degli States citati nei brani). Questo disco rappresenta il suo sogno romantico fatto di whiskey, sigarette, poesia e jazz.
Ry Cooder Chávez Ravine (Nonesuch Records, 2005)
Concept album sull’evacuazione del quartiere Chávez Ravine, demolito per far posto a una zona elegante e a uno stadio di baseball. Il rock anni Cinquanta e il folklore latino riflettono il periodo storico e l’anima multiculturale del quartiere. Praticamente un saggio di sociologia urbana alla Mike Davis in musica.
Charlie Haden Quartet West Haunted Heart (Verve, 1992)
Il contrabbassista propone jazz dalle atmosfere chandleriane, ispirato alla Hollywood degli anni Trenta e Quaranta, dove il sassofonista Ernie Watts, indossato l’impermeabile, indaga repertori delittuosi e romantici.
Van Dyke Parks Song Cycle (Warner Bros Records, 1967)
L’album è l’equivalente musicale di un romanzo di Pynchon (evocato nelle note di copertina del giornalista Paul Jay Robbins) dove si fondono ispirazioni eterogenee tra ballate folk, pop barocco, psichedelia, classica. Gli oggetti sonori sembrano quinte di un b-movie, costituendo un nonsense di assoluta ragionevolezza.
Eagles Hotel California (Asylum, 1976)
Nella ballata Hotel California, dall’andamento dolce ma dal testo maledetto, Los Angeles è la Babilonia del Ventesimo secolo. Un albergo alla Kubrik, dove «puoi fare il check out quando vuoi ma non potrai mai andartene», un luogo che nella copertina del disco viene raffigurato con il Beverly Hills Hotel, meta preferita delle star di Hollywood.

