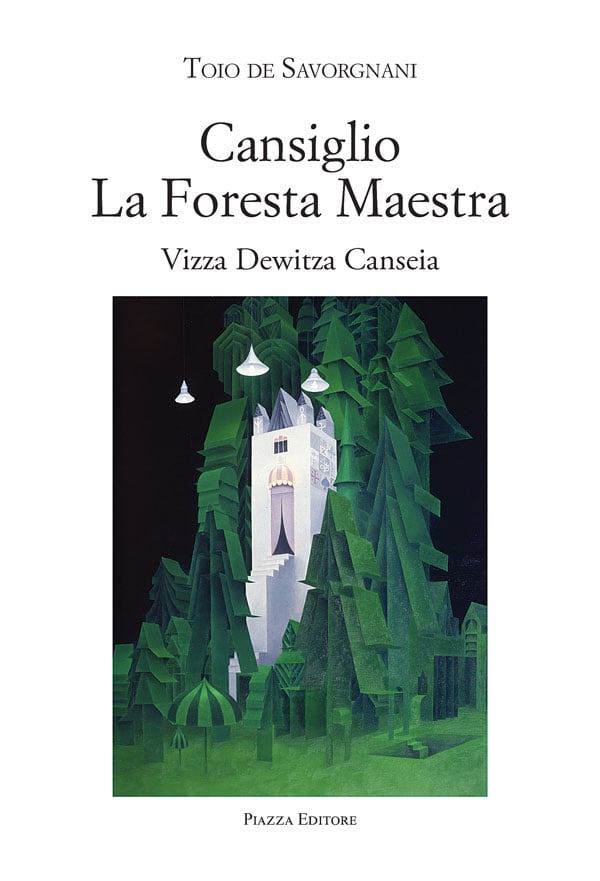Le Dolomiti, scenario naturale che caratterizza i paesaggi dell’Alto Adige, sono anche l’elemento di raccordo tra il passato e il presente per Gianni Pettena (Bolzano 1940, vive e lavora a Fiesole) e per le sue Architetture naturali, come vediamo nella doppia personale a Merano Art/Kunst Meran (fino al 24 settembre), curata dalla direttrice artistica Christiane Rekade. In questo contesto una selezione di lavori dell’esponente dell’architettura radicale dialogano con le opere dell’artista concettuale Helen Mirra (Rochester, New York 1970, vive e lavora a Cambridge, Massachusetts) che in Camminare, tessere definisce un rapporto esclusivo con la natura messo in atto attraverso l’azione del camminare, un po’ come facevano i poeti romantici inglesi.
Anche lo stesso Pettena durante la sua giovinezza ha un approccio analogo, soprattutto con le scalate in alta quota, assecondando uno spirito d’avventura con quell’innata curiosità che lo avrebbe portato prima allo studio dell’architettura all’università di Firenze e poi, oltreoceano, alla ricerca del foglio bianco. «Noi la chiamiamo Monument Valley, ma per i Navaho è la Valle dei Templi» – afferma l’autore di L’Anarchitetto (1973) davanti alle 49 fotografie in bianco e nero della serie About non-conscious architecture che ha scattato nel ’72-’73 in giro per i deserti nordamericani, dall’Utah al New Mexico.
La consapevolezza acquisita nel confrontarsi con un paesaggio che, però, non è esattamente quel foglio bianco che immaginava – «quando arrivo lì capisco che sono arrivato tardi» – non distoglie la convinzione di Pettena nel riconoscere la «qualità insuperabile di questa architettura» che nasce proprio dalla relazione osmotica con la natura, come sono gli stessi nativi ad indicare. «Siamo in presenza dell’architettura che sul piano concettuale è la più pura. Quella in cui il nomade, che si muove con le stagioni, riconosce nella natura». Dal Pueblo di Mesa Verde alla Valle della Morte «sei natura stessa, come qualsiasi altro animale o vegetale. Questa maniera di non toccare visibilmente il paesaggio, ma di riconoscervi il passaggio di spazio pubblico e privato è la maniera più alta, concettualmente impeccabile, del fare architettura. Quando cominci a costruire un muro, uno schermo tra te e l’esterno, questo muro artificiale segnala che hai smesso di essere nomade, che ti sei fermato e sei diventato un coltivatore o un allevatore di animali e che guardi la natura dalla finestra. Non sei più natura, ma essa è la controparte e può essere amica, ma anche nemica».
Partiamo dalla memoria famigliare e dalla sua influenza sul tuo lavoro, soprattutto durante l’infanzia quando giocavi con i tuoi sei fratelli…
Inventavamo giochi perché non c’erano i giocattoli. Un gioco, ad esempio, era fare della musica «suonandosi» la testa. I giochi erano di tutti i tipi, ce li auto costruivamo. Nuotavamo anche a rana sotto il letto!
Proprio vedendo «Paper/Midwestern Ocean» tua sorella maggiore ha riconosciuto le scenografie che facevate da piccoli.
Quando Caterina ha visto una foto presa dall’alto dell’installazione che ho realizzato a Minneapolis nel 1971 – una foresta di carta come Paper che a Merano è stata fatta con la stessa logica, anche se qui si sviluppa in modo verticale – ha ricordato immediatamente quando da piccoli facevamo teatro. Piantavamo dei chiodi nella cima degli armadi stendendo degli spaghi e buttandoci sopra delle lenzuola, poi ci facevamo spazio attraversando queste lenzuola verticali. Erano fondali, quinte, sipari.
Un modo visionario di concepire lo spazio?
Certamente! Solo in questi ultimi anni ho ricollegato con chiarezza il fatto che cercando il foglio bianco nel Sud-Ovest degli Stati Uniti, cioè un paesaggio non contaminato dall’uomo, ho ricollegato questi miei viaggi e queste mie indagini con un’oggettiva ricerca inconsapevole della matrice di questa mia curiosità che erano le montagne che avevano circondato me stesso fin da bambino. Le mie prime memorie datano durante la guerra a Moena, alla Val di Fassa e alle Dolomiti che circondavano il paese, come pure a Bolzano dove si vedono quelle cime che poi a 16, 17 anni ho scalato.
Quel paesaggio maestoso suscitava anche timore?
Non era questa la chiave. Le Dolomiti erano le quinte del teatro in cui stavo agendo. Erano montagne amiche con i boschi, con le cime. No, non erano un paesaggio opprimente. Le Dolomiti sono forse le più belle montagne del mondo perché non sono scure, ma chiarissime e, da un certo punto in poi del pomeriggio, si colorano di rosa.
A proposito di colori, riferendoti ai meccanismi cerebrali hai parlato di una parte verde…
Mi riferivo al mantenere una parte del proprio cervello coltivata a verde. Una considerazione a proposito dell’educazione, del modo di essere al mondo preparandosi sempre a costruire una struttura del proprio cervello che porti all’auto sostentamento ideale, emozionale, fantastico e teorico non direttamente collegato a quello pratico e materiale. Mi viene in mente la citazione di Joseph Conrad, «come faccio a spiegare a mia moglie che quando guardo fuori dalla finestra sto lavorando?»-
Tra le amicizie del periodo americano è stata particolarmente significativa quella con Robert Smithson…
Bob l’ho conosciuto nel ’69 – anche se conoscevo già un po’ il suo lavoro – quando è venuto a Roma alla galleria L’Attico per Asphalt Run Down. Da allora siamo diventati amici. Un’amicizia che ho coltivato a lungo durante i miei soggiorni negli Stati Uniti, fino a quando purtroppo volando su Amarillo, in Texas, per fare quella che sarebbe stata la sua ultima opera, l’aeroplanino cadde e morirono sia lui che il pilota. Nel libro sui suoi scritti (Robert Smithson: The Collected Writings, 1979 – n.d.r.) c’è una conversazione che avemmo a Salt Lake City nel ’72, quando ci incontrammo per caso nella Main Street. Registrammo quella chiacchierata che, qualche mese dopo, finì su «Domus». Il giorno dopo quel nostro incontro fortuito andammo sulla Spiral Jet. Era inverno, c’erano anche Virginia Douane e Laurence Allowey, il critico che con Leo Castelli inventò la parola Pop Art. Anzi, non solo la parola!
Pensi che il lavoro di Smithson ti abbia influenzato?
C’è stato un dialogo forte, sebbene avessimo avuto un’educazione diversa. Io da una parte e lui dall’altra parte dell’Oceano Atlantico. Lui era stato educato come artista visivo, io come architetto. Anche se i miei dubbi come studente di architettura furono definitivi già alla fine del primo anno, dopo essere andato a tutte le lezioni e preso tutti gli appunti possibili. Mi accorsi che la scuola di architettura preparava ad una professione di architetto, ma non veniva insegnata l’architettura come linguaggio di cui impadronirsi per raccontare la propria storia. Una cosa che è molto diversa dal conservatorio di musica, dove insegnano a scrivere la musica, immaginarla e raccontarsi attraverso la musica stessa.
È così anche nella scuola d’arte, mentre l’architettura è considerata una scuola professionale. Per cui la mia scuola, dal secondo anno in poi, è stata la frequentazione della generazione di artisti visivi, i giovani filmmaker, attori e registi teatrali, per i quali ho anche disegnato delle scenografie come Giancarlo Nanni e Manuela Kustermann. Ero anche molto amico di Kounellis – che per noi era Gianni non Jannis – che con Paolini ogni tanto disegnava scenografie per Camion, la compagnia teatrale di Carlo Quartucci e Carla Tatò.