Tutto è iniziato l’anno precedente quando il giovane e brillante sacerdote di Riversend, piccolo centro della Riverina, una zona agricola da tempo scossa da una drammatica siccità, si è messo a sparare su quanti attendevano davanti alla chiesa per la funzione domenicale uccidendo cinque persone. È nel primo anniversario della strage che Martin Scarsden, quarantenne ex inviato di guerra, arriva nella cittadina del sud-ovest del Paese per raccontare ai lettori del quotidiano di Sidney per il quale lavora cosa sia accaduto dopo quella tragica vicenda che ha suscitato l’interesse e alimentato le paure dell’opinione pubblica australiana. Per Scarsden è la grande occasione per rientrare in pista dopo una grave crisi che lo ha fatto dubitare di tutto e, prima di ogni altra cosa, di sé stesso.
A Riversend scoprirà però che nulla è come appare e che l’apparente esplosione di follia che ha sconvolto la zona, e che ha già provocato anche altre vittime innocenti, affonda le proprie radici nei segreti che questa anonima cittadina cela da tempo. Mentre cerca elementi per la sua inchiesta, il reporter finisce così per trasformarsi in una sorta di detective deciso ad arrivare fino in fondo nella sua ricerca della verità. Ex giornalista, a lungo inviato di alcune delle maggiori testate del Paese, lo scrittore di Canberra Chris Hammer firma con Scrublands Noir (Neri Pozza, pp. 428, euro 19), la prima di una serie di inchieste che vedono come protagonista Martin Scarsden, una delle figure di maggior successo del poliziesco australiano degli ultimi anni.

L’orizzonte che emerge dal suo romanzo fa pensare a una sorta di versione australiana del «selvaggio west», è spesso questa l’immagine letteraria, e cinematografica, del bush (l’entroterra): un luogo di frontiera, senza regole e dove può accadere di tutto. C’è qualcosa di vero in questa descrizione?
L’entroterra australiano è vasto, caldo e piatto. E le città possono sentirsi molto isolate, soprattutto nei periodi di siccità, o quando infuriano gli incendi o, all’inverso, nel caso di inondazioni. In questo senso ho cercato di rendere il profilo del paesaggio fisico nel modo più accurato possibile. Ciò detto, sarebbe forse esagerato descrivere invece «il paesaggio umano» locale come quello dei fuorilegge del West americano. Proprio come nelle grandi città, anche da queste parti possono accadere e accadono sovente cose strane e terribili. Solo che quando succede, a rendere tutto più complicato è il fatto che a mancare sono quelle risorse su cui si può contare in una metropoli. Il contesto rende perciò tutto più duro, contribuisce a esacerbare i conflitti piuttosto che a contenerli.
La storia è ambientata nei pressi del bacino del Murray, una zona che lei ha raccontato in «The river», un libro-inchiesta a cui ha lavorato a lungo e che spiega come la scomparsa di un fiume possa modificare definitivamente un ambiente naturale ma anche umano. Cosa le ha lasciato quell’esperienza?
Il bacino del Murray-Darling è enorme, un’area più grande della Germania e della Francia messe insieme, e si trova interamente all’interno del Paese, lontano dalla costa, e quindi è periodicamente esposto alla siccità. Ho viaggiato a lungo in questa zona durante le estati del 2008 e del 2009, al culmine di quella che in Australia è stata ribattezzata come «la siccità del millennio», la peggiore che si sia registrata in oltre duecento anni, vale a dire da quando ha avuto luogo l’insediamento europeo nel Paese. La cittadina dove si svolgono le vicende narrate in Scrublands Noir, Riversend, non esiste, ma all’epoca ho trascorso una settimana in una località chiamata Wakool che si trova nel bel mezzo di quell’area, l’enorme distesa piatta della regione della Riverina occidentale, nel sud-ovest del Nuovo Galles del Sud. Wakool è molto diversa da Riversend, ma i due luoghi hanno una cosa in comune, vale a dire che durante il mio soggiorno anche lì il fiume era completamente a secco. Per un centro agricolo è qualcosa di devastante; i contadini erano costretti ad abbandonare le loro terre, la gente era disperata e in tutta l’area del bacino si è registrato un tragico aumento dei suicidi. Si respirava una depressione diffusa, ma anche un forte spirito di comunità, la determinazione a superare quel momento dandosi sostegno reciprocamente. La crisi stava tirando fuori il meglio e il peggio dalle persone. Se non avessi osservato tutto questo da vicino, probabilmente non avrei mai pensato di scrivere il romanzo.
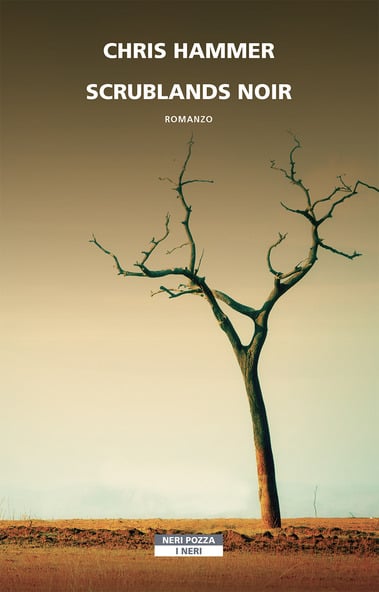
Sono sempre abbastanza riluttante ad attribuire un significato particolare ai miei libri, ma credo che un filo interpretativo per questo romanzo si possa trovare nell’idea che la violenza e i traumi che porta con sé seguano un percorso che attraversa le generazioni, che passa per così dire di padre in figlio. Non a caso nel cuore di Riversend sorge il monumento ai caduti della Prima guerra mondiale: sta lì a testimoniare come l’impatto di quella carneficina e di quelle successive a cui tanti giovani australiani, spesso provenienti proprio da piccole località di campagna, hanno preso parte, sembra avere ancora un’eco a distanza di tanto tempo. Le tracce della violenza di cui si è stati vittime o artefici persistono e si tramandano da un’epoca all’altra o dentro le medesime famiglie. Non a caso la strage compiuta dal sacerdote che rappresenta l’antefatto della storia potrebbe celare un tentativo di espiazione per altre violenze del passato, quasi a voler fermare questo tragico circolo vizioso.
Spingendosi ancora più in là, si ha quasi l’impressione che il romanzo si interroghi sul rapporto che la società australiana ha con la violenza, le armi, gli omicidi di massa e la stessa rappresentazione del «male». Sappiamo che la risposta a questo interrogativo è molto diversa in Europa rispetto agli Stati Uniti: nel suo Paese come stanno le cose?
Nel libro, l’attenzione dei media nazionali si concentra su Riversend dapprima quando il prete uccide a fucilate cinque parrocchiani e in un secondo momento dopo la scoperta di altri due cadaveri. In Australia questa reazione di tv e giornali suona credibile. Ma quando il romanzo è uscito negli Stati uniti ricordo di aver letto una recensione che sottolineava come un numero così esiguo di vittime non avrebbe attirato altrettanta attenzione, e suscitato timori simili, in America dove si è abituati a ben altre stragi. L’Australia non è un paese molto violento, almeno per quanto riguarda il numero degli omicidi e i casi di aggressione con l’uso di armi da fuoco; in questo senso è molto più simile all’Italia che agli Stati Uniti. Da noi c’è uno stretto controllo delle armi e questo tipo di politica gode di un ampio sostegno popolare. Non c’è stata una sparatoria di massa, del tipo di quelle così diffuse negli Stati Uniti, dal 1996. L’Australia non ha certamente la stessa cultura delle armi degli americani. Il che è interessante da sottolineare poiché la conquista europea di vaste aree dell’entroterra di entrambi i Paesi è avvenuta nella stessa epoca, intorno alla seconda metà del XIX secolo, e con metodi simili, vale a dire il diffuso utilizzo delle armi e l’assassinio di massa delle popolazioni indigene. Eppure l’Australia si è trasformata in un Paese dove le armi non sono più centrali nella cultura popolare, in particolare nelle città dove vive la stragrande maggioranza della popolazione.
Lei ha lavorato per i maggiori giornali australiani, eppure i reporter che seguono «il caso» di Riversend – e in parte lo stesso protagonista Martin Scarsden, prima di cambiare atteggiamento -, non fanno una gran figura: sembrano anteporre a qualunque scrupolo la spettacolarizzazione a tutti i costi della vicenda.
In effetti per molti di loro è così, però è interessante notare come nessuno dei miei vecchi colleghi si sia offeso per il modo in cui li ho rappresentati: evidentemente non mi sono discostato troppo dalla realtà. Del resto, penso che questo rifletta bene la realtà del giornalismo di oggi, sempre più pressato dal mercato e dove accanto a reportage investigativi di grande qualità, basati su analisi ponderate, emergono molte voci votate solo al sensazionalista e alla spettacolarizzazione e un modo di lavorare che si fonda su azioni e un’etica davvero discutibili.

