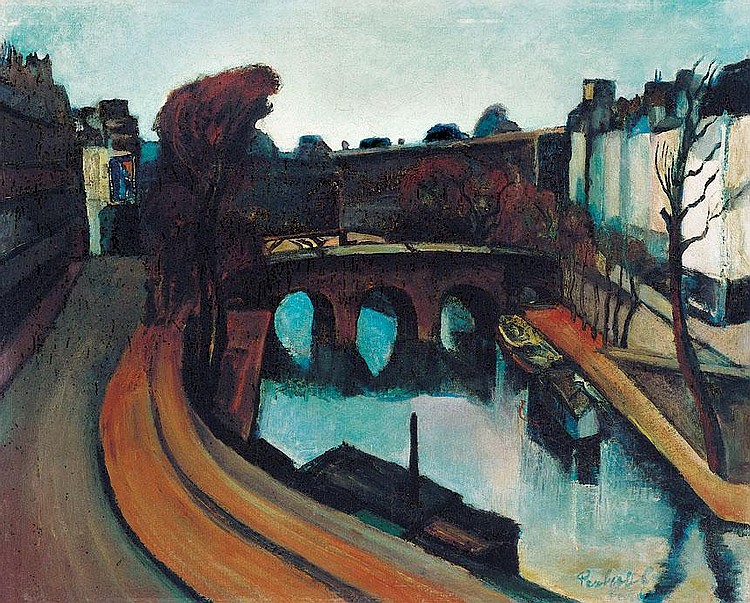Ci sono libri che attendono a lungo il loro turno prima di essere scoperti e che, una volta emersi dal cono d’ombra in cui sembravano sprofondati, svelano quanto sia sempre parziale e provvisoria la visione che abbiamo di una parte del mondo, e della letteratura stessa. È certamente il caso di Satantango di László Krasznahorkai, opera di esordio per la prima volta tradotta con splendida resa da Dora Várnai, a trentuno anni di distanza dall’uscita, benché universalmente nota (Bompiani (pp. 318, euro 20,00). Un caso appena meno bizzarro se si considera che il testo in questione è stato scritto in quella lingua notoriamente astrusa e poco studiata che è l’ungherese e, soprattutto, se l’autore in questione si è circondato nel frattempo di una tale fama di intrinseca «difficoltà» da scoraggiare qualsiasi tentativo di avvicinamento.
A rendere Krasznahorkai un narratore di culto paradossalmente poco letto hanno contribuito anche i film del connazionale Béla Tarr, che, adattando per lo schermo i suoi primi due romanzi, ha finito in un certo senso per sollevare il lettore dal compito di misurarsi in prima persona con la lunghezza apparentemente infinita delle sue frasi. Una caratteristica che gli era valsa il plauso di un altro cultore dell’ipotassi, Winfried Georg Sebald e che, «tradotta» in interminabili piani-sequenza da Tarr, affascinò anche Susan Sontag, la quale si disse disposta a rivedere i 432 minuti della versione cinematografica di Satantango ogni giorno della sua vita.
Nel suo ipnotico flusso narrativo mai interrotto da «a capo», l’opera prima di Krasznahorkai datata 1985 rende sterile domandarsi che cosa sarebbe cambiato nella nostra percezione delle letterature dell’est Europa, se avessimo potuto fare prima la conoscenza di questo scrittore che a trent’anni evocava le ombre di Beckett, Kafka e Gogol’ sullo sfondo malinconico di una Grande Pianura Magiara perennemente velata dalla pioggia. Ciò che forse più colpisce a distanza di decenni è la capacità di Krasznahorkai di proiettare i realia dell’Ungheria tardo socialista su un piano universale, trasformando lo sfascio imminente di una società storicamente determinata nella cifra atemporale dell’Apocalisse. In questo senso, Satantango anticipava – addirittura quattro anni prima della caduta del muro di Berlino – parte della letteratura post-socialista dei decenni a venire, per di più con un afflato metafisico rimasto sostanzialmente ineguagliato. D’altro canto, le tonalità profetiche dispiegate da Krasznahorkai non escludevano una sferzante ironia nei confronti dei suoi personaggi, figure così grottesche nel loro intorpidimento spirituale da non meritarsi neppure una catastrofe finale in piena regola (malgrado i segni premonitori sparsi a piene mani per il libro), ma solo un beffardo ritorno alla situazione di partenza.
Situazione che non si potrebbe definire altrimenti se non di stallo. In un punto indefinito della campagna ungherese, una fattoria collettiva indicata genericamente come «stabilimento» ha chiuso per sempre i battenti, e la gente si è affrettata a fuggire «con lo stesso slancio con cui era arrivata».
Solo un esiguo gruppetto rimane asserragliato nella struttura ormai fatiscente, continuando a illudersi (a dispetto di ogni evidenza) che il collettivo possa riprendere, prima o poi, la sua attività. Come sopravvissuti a un naufragio, ottusamente legati a quel luogo desolato e incapaci di rifarsi una vita altrove, una dozzina di irriducibili tirano a campare lavoricchiando, litigando, accoppiandosi tra di loro e smorzando i rari momenti di lucidità con riserve apparentemente illimitate di alcol.
Finché, come quei miraggi che si profilano inattesi nel deserto, anche sull’orizzonte monotono della pianura centrale, o Alföld, si stagliano segnali indecifrabili che sembrano preannunciare un immediato cambiamento. Anche perché – come osserva il più acuto dei «vinti» messi in scena da Krasznahorkai, Futaki – «la situazione non può essere davvero così irrimediabile come sembra».
E perciò, introdotta da uno trionfale scampanio mattutino di cui non si riesce a comprendere l’origine, dal momento che nelle vicinanze non ci sono chiese, né tantomeno campane, si diffonde un bel giorno la notizia che gli ex compagni Irimiás e Petrina, da tutti creduti passati a miglior vita, stanno facendo ritorno allo stabilimento. In realtà, i due erano finiti in prigione a causa di qualche oscuro maneggio e ora stanno tornando per raggirare gli ex lavoratori della fattoria e impadronirsi con l’inganno dei loro sudati risparmi.
Come che sia, la prospettiva del loro arrivo scuote i personaggi di Satantango dall’apatia in cui erano precipitati; in particolare è proprio da Irimiás – enigmatico imbonitore affine a Cicikov, il protagonista delle Anime morte – che tutti si aspettano la svolta, incapaci di darsela da soli. Da una parte Krasznahorkai lascia il finale aperto: difficile dire infatti se l’esodo collettivo intrapreso dietro ordine di Irimiás porterà a quei disperati la salvezza o la dannazione definitiva. Dall’altra, Satantango si chiude letteralmente così com’era cominciato, nell’istante in cui l’unico a non partire, e cioè il vecchio medico misantropo, constatando con soddisfazione la sparizione dei vicini, comincia a mettere per iscritto la loro storia.
Le ultime pagine del libro ripetono quindi testualmente le prime tre, trasformando Satantango in una sorta di loop o di ballo infernale in cui i lettori finiscono per ritrovarsi (al termine di dodici capitoli, numerati non a caso dal primo al sesto e poi, nella seconda parte, dal sesto al primo) al punto di partenza. Un espediente stilistico, quello della concatenazione, che Krasznahorkai riprenderà anche nel suo secondo romanzo, Melancolia della resistenza, uscito nel 1989 e pubblicato tre anni fa da Zandonai nella traduzione di Dora Mészáros e Bruno Ventavoli. Qui la clausola finale di ogni capitolo veniva ripetuta in apertura del successivo come in un rondò, riconnettendo, oltre alle singole parti della narrazione, anche i punti di vista dei vari personaggi. Questa tendenza ad adattare la forma-romanzo a strutture musicali si riallaccia alla caratteristica più evidente della prosa di Krasznahorkai, ossia la propensione a condurre alle estreme conseguenze la natura agglutinante della lingua ungherese, producendo – per aggregazione graduale di parole – frasi lunghissime, che si susseguono per pagine e pagine senza alcuna forma di stacco grafico, e che sono state giustamente definite dal traduttore inglese di Satantango George Szirtes «colate di lava verbale».
Incalzati dall’angoscia.
Immerso in questo ininterrotto flusso sonoro dalla scansione ritmica estremamente marcata, il lettore non può fare altro che andare avanti, come incalzato dall’immaginazione dell’autore e dalle visioni apocalittiche o grottesche cui dà di volta in volta forma. Anche se, man mano che la narrazione procede, sempre più forte e angosciante diventa la sensazione che i personaggi di Satantango abbiano già mancato la loro ultima possibilità e che si ritrovino ormai – come nell’epigrafe dal Castello di Kafka che apre il romanzo – nella condizione di chi preferisce lasciarsi sfuggire quello che comunque non arriverà, restando lì dov’è e aspettando. Merito di Krasznahorkai è aver saputo tracciare con mano sicura quest’orizzonte vuoto, dove l’intensità dell’attesa diventa una variabile dipendente della disperazione.