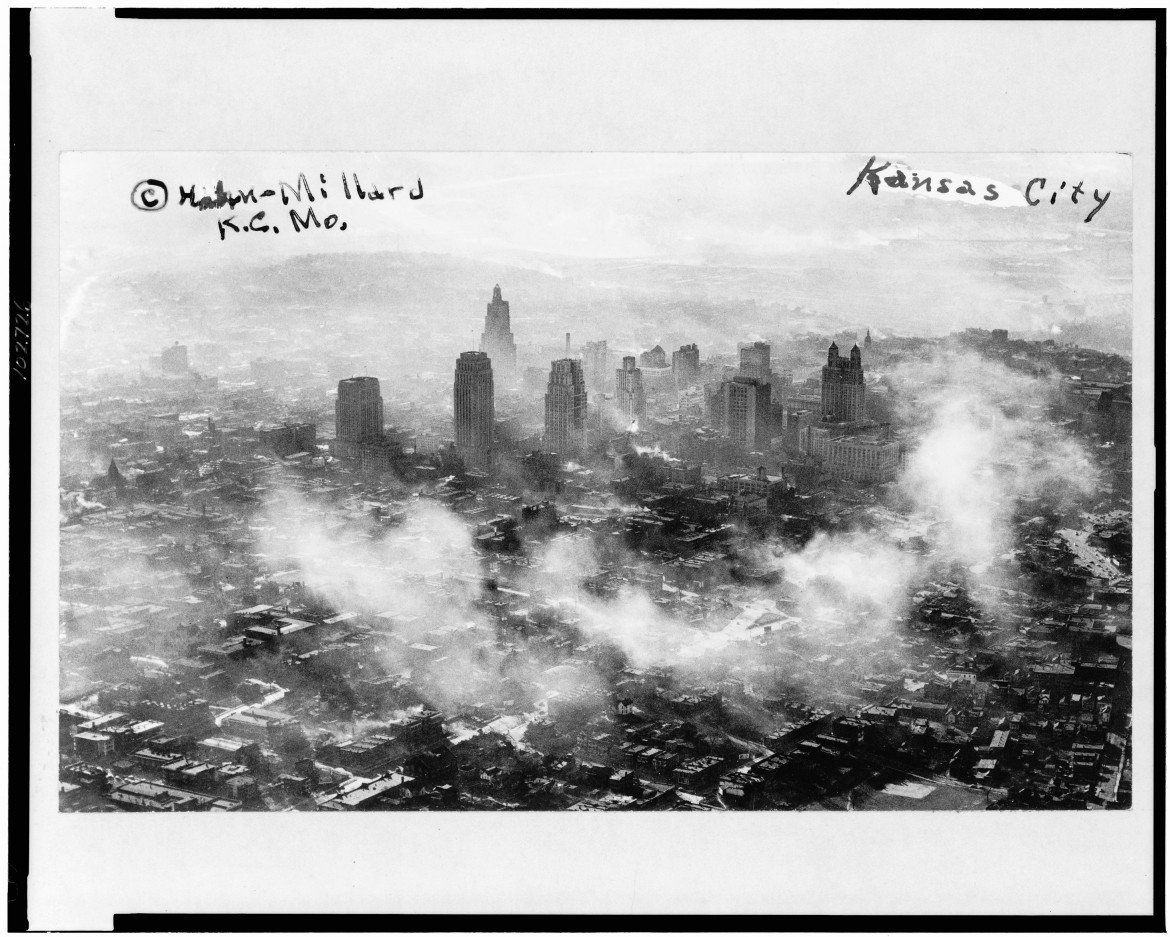«Quello che sta per concludersi è l’anno della sconfitta militare di Daesh alla quale l’Italia ha dato contributo rilevante con addestramento e stabilizzazione zone. Ne sono orgoglioso».
Così, ieri mattina, il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni. Nelle stesse ore, la branca del Khorasan dello Stato islamico – sconfitto secondo Gentiloni – rivendicava l’attentato che nella mattinata di ieri ha provocato almeno 41 morti, decine e decine di feriti.
È avvenuto a Kabul, in Afghanistan. Un Paese in cui i soldati italiani sono impegnati da molti anni. E in cui la stabilità è ancora un obiettivo lontano, a dispetto di quanto sostengono politici e strateghi militari.
Il presidente afghano Ashraf Ghani e il generale John Nicholson, a capo della missione Nato nel Paese centroasiatico, avevano assicurato alcuni mesi fa che il 2017 sarebbe stato l’anno della sconfitta dello Stato islamico in Afghanistan, quella «Provincia del Khorasan» formalmente riconosciuta dalla casa madre di Raqqa all’inizio del 2015, radicata soprattutto nell’est del Paese, a ridosso del confine con il Pakistan, e a Kabul, dove operano veterani della militanza armata e militanti più giovani, ideologicamente sensibili al salafismo jihadista propagandato dal Califfo e alieno invece ai Talebani, di scuola Deobandi.
La sconfitta invocata non c’è stata. Molti anni prima, nel 2001, il presidente texano della guerra permanente aveva garantito che rovesciando il regime dei Talebani, responsabili di aver dato ospitalità a Osama Bin Laden, sarebbero scomparsi dal territorio afghano i gruppi terroristici, i fanatici del jihad, i paladini della guerra santa contro i crociati.
Oggi è lo stesso Dipartimento di Stato a certificare che nell’area di confine tra Afghanistan e Pakistan si registra il più alto numero di gruppi jihadisti del pianeta.
Qualcosa non ha funzionato. Ma la retorica è sempre quella: il generale Nicholson rivendica successi significativi sul campo militare, come hanno fatto i suoi predecessori, a intervalli regolari. L’Italia si limita a un ruolo di subalternità atlantica, con «signorsì» così rituali da trasformarsi in gaffe clamorose.
Alcuni giorni fa, in un’intervista con il quotidiano la Repubblica la ministra italiana della Difesa Roberta Pinotti sosteneva: «Da anni l’Italia ha preso la guida del Prt, ossia del centro che coordina la ricostruzione, di tutta l’area sudoccidentale. Non possiamo abbandonarlo perché sarebbe una dimostrazione di scarsa responsabilità…». Il Provincial Reconstruction Team di Herat in realtà è chiuso dal marzo 2014. La responsabilità di un ministro è sapere ciò di cui parla. Informarsi, valutare, e poi decidere.
Quando c’è da ricorrere alle armi, nessuno sembra farlo. Tanto meno Donald Trump, che sull’Afghanistan ha dato carta bianca ai militari. Nel Paese c’è la nuova minaccia dello Stato islamico? Basta sganciare la «madre di tutte le bombe» e il problema è risolto, pensa il presidente Usa.
Così è avvenuto il 13 aprile nel distretto di Achin, nella provincia afghana di Nangarhar. Undici tonnellate di esplosivo su un complesso di tunnel. È la politica estera ridotta a esercizio della forza e dominio. L’idea – obsoleta già nel secondo Novecento, oggi del tutto screditata, contraddetta dalla storia – che la forza militare sia l’ultima garante della sicurezza mondiale. La convinzione che realismo equivalga a militarismo, a flettere i muscoli, a mostrare il volto cattivo. Un paradigma non solo obsoleto, ma inefficace e controproducente.
L’unica via veramente efficace va nella direzione opposta: costruire uno scenario globale post-militarista e «una concezione di un ordine mondiale basato su una geopolitica non violenta», per dirla con il giurista Richard Falk. Un ordine mondiale che garantisca pieni diritti a tutti, non solo ai privilegiati nati nel mondo euro-atlantico. Quei diritti che si pretende di tutelare con le armi, mentre vengono negati con leggi, procedure, decisioni politiche.
L’Afghanistan ne è esempio drammaticamente emblematico. Molti governi europei ritengono che il Paese sia sicuro. E che lo sia in particolare la sua capitale, Kabul. Così, sono ricominciati i voli di rimpatrio di quegli afghani la cui richiesta di asilo non venga riconosciuta nei Paesi membri dell’Unione europea. Ma se l’Afghanistan è davvero sicuro, si chiedono gli afghani, che ci stanno ancora a fare i soldati stranieri? E se non lo è, i rimpatri non sono forse illegittimi?