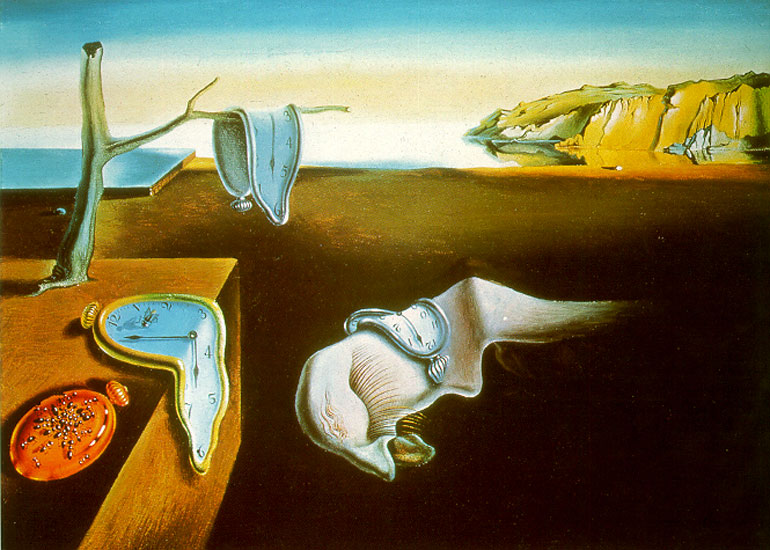Osservo il mio riflesso nella grande vetrata che dal mio ufficio dà sulla strada e mi sistemo il nodo della cravatta Hundred 07 blu, regalo di compleanno di mia moglie Teresa. Adesso è perfetto. Bevo un sorso di té al bergamotto e continuo a guardare l’avanzare di un corteo. Da quassù le persone sembrano formiche uscite dalle loro colonie in cerca di cibo. Compatti, vanno avanti lentamente. Striscioni tesi, bandiere che sventolano e cori urlati al cielo che mi giungono ovattati. Sempre le stesse parole. Da sempre. Sull’altro lato della strada ci sono quelli con le divise blu, composti e ordinati. Visiere calate, manganelli in una mano e scudo nell’altra. Bevo un altro sorso di té e lo trattengo nel palato per assaporarne a fondo l’essenza. Gli animi all’improvviso si scaldano. Parte un lancio di uova. Gli uomini in divisa rispondono con una carica di alleggerimento. Qualcuno fa partire un sasso verso la sede della banca, così la carica si fa più feroce e spuntano i manganelli che si abbattono su quelli delle prime file.
«Criminali» mi viene istintivo borbottare, «siete proprio dei criminali».
* * *
Mi ha chiamato, ieri. Mi ha detto di stare a casa. Si è raccomandato. Non chiama quasi mai, e quando chiama di solito parla con sua madre. A malapena mi saluta, tra noi pian piano si è venuto a creare un dialogo fatto più di silenzi che di parole. Così parla sempre meno; e anche io parlo sempre meno.
«Sta’ a casa», dice. Fosse facile.
«A casa a fare cosa?» avrei voluto chiedergli. Mi è rimasto solo questo, un briciolo di dignità. Il resto l’ho perduto, il resto è finito all’asta. E allora sono dovuto venire. Ho preso la mia bandiera, ho indossato il mio cappellino e sono venuto qua anche io. Non sono solo, siamo in tanti, tutti più o meno incazzati. Tutti più o meno disperati. Sollevo gli occhi verso il cielo. È terso. È una bella giornata. Lascio che lo sguardo si posi su di loro. Non lo vedo. Non sembra che ci sia. Tiro un sospiro di sollievo ma dura solo un attimo, perché riconosco quegli occhi e quegli occhi mi riconoscono. Ci fissiamo ed è come se volessimo parlare. In quel nostro sguardo c’è tutto il peso delle cose non dette, dei nostri «avrei voluto» e dei «non ho saputo». Dura finché il presente non torna a farsi sotto, al ritmo dei tamburi percossi e dei cori gridati con la forza di chi oramai non ha più nulla da perdere. Noi.
Non mi sarei dovuto fidare, questa è la verità. Ma quei soldi mi servivano. Per ammodernare un po’ l’azienda, ridurre i costi e permettermi di guadagnare qualcosa in più, visto che i nostri prodotti ce li pagano sempre meno. Però al supermercato te li ritrovi a un prezzo dieci volte più alto. Non volevo tirare a campare come mio padre e mio nonno. Volevo qualcosa di più, perché queste mani potessero stringere un grano di speranza. Le mie mani… uguali alle loro, aride come la terra che mi dava il pane. Sotto le unghie ce n’é ancora uno strato sottile, di quella terra, ed è come se la portassi sempre appresso. È come non averla abbandonata mai. Neppure ora che me l’hanno tolta.
Ci hanno dato dei soldi.
Li hanno chiamati aiuti di Stato.
I soldi li hanno rivoluti indietro. Molti di più di quelli che ci avevano prestato.
Siamo più di diecimila, in queste condizioni.
«Non ce ne andremo fino a quando non avremo risposte!» grida una voce accanto a me.
Io la mia risposta l’ho avuta. Hanno mandato l’esercito per portarmi via tutto quello che avevo. Anche questo dev’essere un aiuto di Stato, penso. E se questo è il modo di aiutarci, allora ha ragione quella canzone che dice «se Dio vuole e i Carabinieri permettono». Ma quale Stato. Vorrei gridare, e invece mi sento svuotato, come se mi avessero reciso le radici.
Qualcuno fa partire un lancio di uova marce che imbrattano i muri della banca. La Polizia risponde serrando le righe in un cordone stretto e cercando di respingerci, lontano. Sento il tuono ritmico dei manganelli rimbombare sugli scudi. Dovrei avere paura. Dovrei provare vergogna. Ma se non hai più radici non provi più nulla. E io non ho più nulla, e non provo più nulla. Mi è rimasta solo questa rabbia. Che monta.
Infilo la mano nella tasca dei pantaloni. C’è un sasso, non è grosso, sta chiuso in una mano. Era mio, l’ho raccolto la prima volta che…
Non importa. Lo tiro fuori e lo guardo, poi lo stringo forte, alzo il braccio e lo porto indietro.
È in quel momento che lo vedo. E mi vede. Scuote la testa. «Non lo fare» sembra volermi dire, «non lo fare». Evito il suo sguardo e lascio che il sasso scivoli via, lontano, verso il luogo del mio odio.
* * *
Eccolo. Lo vedo. Mai una volta che mi desse ascolto. Eppure pensavo di avergli spiegato per bene le mie ragioni.
«Non venire, fammi questo favore. Tanto non cambia niente». Un solo, piccolo, dannato favore. Ne stavamo parlando da giorni, in questura. Il clima è quello che è. Poi c’è stata la comunicazione. E sono arrivate le informative. Subito dopo, hanno iniziato a scorrere parole come fiumi. Sappiamo come vanno queste cose. Sapevamo che cosa sarebbe potuto accadere. Per questo ho pensato a lui, appena ho letto l’ordine. Avevo ragione. L’aria è ancora più densa di quanto immaginassi. Non è certo la prima volta che faccio Ordine Pubblico. Ma questa volta mi sento a disagio.
Nelle orecchie rimbomba il rumore ritmico dei tamburi. A stento riesco a decifrare ciò che urlano nel megafono, e nei cori che lo accompagnano. Il collega davanti a me segue il tempo, come ipnotizzato. Sbatte il manganello contro lo scudo trasparente, andando in sincrono con le percussioni che arrivano dalla folla. Il commissario fa un passo di lato e lo gela con uno sguardo. Non ha neppure bisogno di parlare. Lo sfollagente si allontana dal plexiglas come se scottasse, per andare ad affiancarsi alla gamba destra, perfettamente verticale.
Alzo lo sguardo, lui è ancora lì. Continua a guardarmi, e io ho un’enorme difficoltà a staccarmi dai suoi occhi. Non so da quanto tempo non ci guardavamo così a lungo in viso. Non possiamo parlarci, ma in quello c’è poca differenza rispetto al solito. Sono anni che mi racconta più con le espressioni che con la voce. Maledetta la campagna. Non si è limitata a tenerlo lontano, lo ha anche plasmato, quasi come fosse fatto anche lui dello stesso silenzio delle piante che riempiono la sua terra. La nostra terra, come la chiama lui. Ma io non ho mai voluto averci niente a che fare, con quei tre pezzi di terreno sparsi per il territorio paese. Quando ero bambino erano il mio posto preferito. Uscire da casa la mattina e non tornare fino a sera, perdendomi insieme agli amici per le mulattiere contornate di rovi. Ogni stagione aveva il suo percorso, e il suo colore. Il viola delle more, o il giallo del sole che secca i campi. Tutte, però, avevano la stessa conclusione. I terreni su cui mio padre e il fratello trascorrevano le giornate. Allora sì, che parlavamo. Parole che avevano il sapore aspro delle susine appena colte, o quello dolce dei piselli strappati di fresco dai baccelli.
Poi sono cresciuto, e i frutti hanno assunto un altro sapore. Quello, amaro, della fatica. E delle difficoltà. Un gusto che non era fatto per me. Non avevo sudato sui libri per ritrovarmi a mani vuote alla prima annata storta.
Un odore acre mi riporta alla realtà, pizzicandomi le narici e la gola. Alzo lo sguardo oltre il blu acceso dei caschi dei colleghi. Ancora più in alto, fino a pochi minuti prima, c’era l’azzurro illuminato del cielo, e i riflessi del sole che si specchiava sul mare. Ora invece il mio campo visivo è occupato dal grigio di un’unica, grande nuvola. Qualcuno ha lanciato dei fumogeni. Il commissario urla qualcosa, e noto che c’è dell’altro. Un cassonetto, alle spalle dei manifestanti, ha preso fuoco. Sento il cuore accelerare e il fiato farsi corto. La vista perde i contorni delle cose, e sento i muscoli vibrare. So cosa mi accade, e so che non è paura, ma l’adrenalina che è entrata in circolo. Capisco che intorno a me, sotto gli altri elmetti blu, si affollano le stesse idee. A parte una, che appartiene a me soltanto, e che non posso condividere con nessuno.
Così riporto lo sguardo su di lui. Lo vedo infilare la mano destra in tasca. Non faccio in tempo a chiedermi che cosa stia cercando, che da una delle tasche tira fuori un sasso. Ne sono certo. E sono altrettanto sicuro che si tratti del primo sasso che ha tirato fuori il giorno che ha ereditato il terreno, e dopo anni di abbandono si è messo a spietrarlo e ripulirlo dalle erbacce con le sue mani. Potrei giurarci, perchè in questi anni lo ha sempre tenuto come fermacarte sulla scrivania dell’ufficio, a tenere impilate fatture, conti, fidejussoni e cataste di documenti che avrebbero potuto, più che volare via, volatilizzare l’azienda. Terra contro finanza. Io lo capivo, quel gesto.
Ma stavolta è diverso. Mi viene d’istinto guardarmi intorno sperando che nessun altro lo abbia visto. Forse è così: un fatto rilevante solo per i miei occhi. Scorro, uno per uno, gli sguardi dei colleghi, almeno dei pochi che riesco a scorgere. Nessuno fa caso a mio padre, là in mezzo, con un sasso in mano.
Quando torno su di lui, la sua mano è alzata, e si muove al ritmo degli insulti che l’uomo col megafono sta urlando. Un gruppo di manifestanti avanza verso di noi. Sono quelli con gli striscioni.
Noi paghiamo e le banche intascano.
Lo stato è Pilato, la banca è Barabba.
I nostri soldi li intascate voi.
Quante volte l’ho sentito dire le stesse cose. A tavola, al bar, quando veniva a trovarmi a Cagliari. Quei maledetti prestiti che lo stato aveva richiesto indietro. Tutti quei contadini col culo per terra. E io che avrei voluto dirgli che non c’era altra soluzione, che l’unico modo per non finire in quel modo era lasciare la terra alle bestie, che almeno loro avrebbero trovato di che sfamarsi. Ma sono stato zitto, ché di litigi con lui mi son bastati quelli del giorno in cui gli ho detto che avrei indossato la divisa, e che a morire in campagna non mi avrebbe visto mai. Non ci siamo parlati per un anno.
So come la pensa. E so che quello che ci stanno urlando nelle orecchie è la metà di quello che vorrebbe urlare lui.
Poi la prima fila sfonda il blocco, e i colleghi spingono. Una volta, due volte. Gli vorrei urlare di nuovo di andarsene.
Adesso.
Il commissario si avvicina a uno dei manifestanti. Gli urla di stare calmo. Hanno archiviato il «lei» per un più informale «tu». Da dietro arriva il dirigente, si mette in mezzo. La discussione finisce. Gli animi sembrano essersi placati, almeno un po’. I miei occhi sono ancora su di lui. Scuoto la testa. Mi vede. Poi lascia andare la pietra, che sfiora il vice questore prima di schiantarsi sul casco di un collega.
Arriva il segnale. Dovrei partire. Dovrei muovermi, con gli altri; è il mio lavoro, lo so fare fottutamente bene. È il motivo per il quale ho lasciato casa, e adesso ho una vita mia.
Davanti, a pochi metri, c’è ancora lui. Mi guarda. Ma non si muove di un millimetro.
Marco mi urla a un centimetro dal casco.
«Cazzo, ma ti decidi o no? Muovi il culo, perdio!».
Come se bastasse muovere il culo per decidersi.
* * *
«Criminali. Non pagare un debito è immorale. Oltre a essere reato, s’intende. E sono anche furibondi, guardali: convinti di stare dalla parte della ragione. Sanguisughe! Hanno avuto i loro soldi. Undici miliardi di vecchie lire nel 1988, mica briciole, a un tasso più che vantaggioso. Noi, quei soldi, li abbiamo erogati, e abbiamo intascato la differenza con i tassi di mercato. Tutto a norma di legge, s’intende. D’altra parte non siamo un istituto di beneficienza. Siamo una banca. E se dieci anni dopo la Comunità Europea ha deciso che quelli erano aiuti di Stato, prenditela con l’Europa, no? Prenditela con la Regione che ha sbagliato a comunicare alla Comunità che stava erogando i prestiti agevolati.
E adesso che la Regione Sardegna ha presentato a questi disgraziati un conto da trentuno milioni di euro, eccoli qua a frignare per strada: tu non puoi pagare, e la colpa sarebbe nostra? Bella faccia tosta, beata ignoranza. Con tassi dal due al cinque percento, che sono rapidamente schizzati fino al venti, cosa ti aspettavi? Certo, il differenziale ce lo teniamo noi. Abbiamo intascato due volte gli interessi per le stesse somme, e che sarà mai? Anche noi dobbiamo andare avanti, superare la crisi. Costi quel che costi. Mica possiamo trovarci i nostri dipendenti giù in piazza a tirar pietre! Non puoi pagare? E allora fatti da parte. È il nostro momento, questo: pignoramenti e sequestri giudiziari. Cinquemila aziende, hanno messo all’asta. Tutto a norma di legge, amo ripetere. E le leggi, care formichine incazzose, le dovete rispettare. Soprattutto voi.
Questo, mi racconto, mentre al di là del mio riflesso vedo le cariche partire e la strada trasformarsi in una sorta di moderno Circo Massimo. E tra le due fazioni che si scontrano, beh, io la mia preferenza ce l’ho. Così bevo un altro sorso di tè, e mentre si arriva al contatto fisico sfodero il mio pollice verso. Come se il destino di tutti loro fosse nelle mie mani. E mi domando se anche i Cesari provavano la stessa emozione guardando le belve scagliarsi contro i gladiatori.