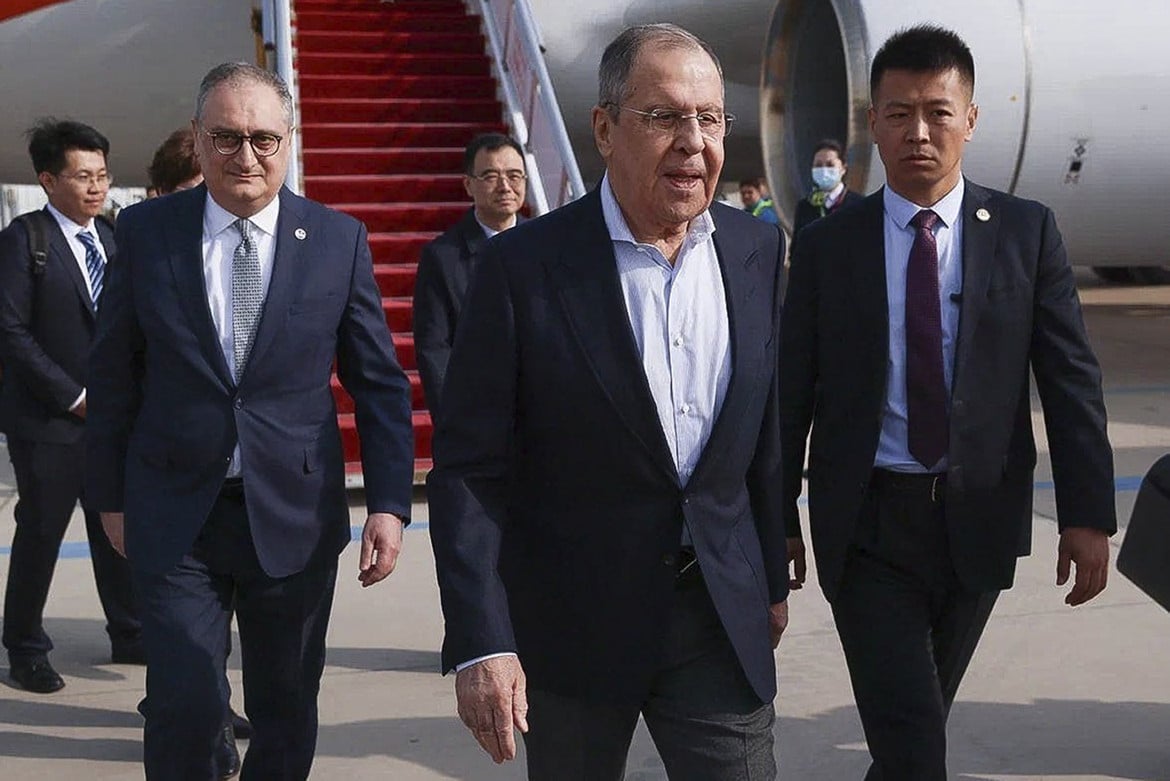La «normalità» delle bombe a Lyshichansk, città zombie
I soldati si sono messi al riparo sotto un albero. Hanno gli occhi stanchi e le mani sporche di polvere. Sono seduti a terra, in mezzo all’erba verdissima e scompigliata dal vento.
Sembrano esausti, e certamente lo sono. Un paio si sono persino messi a dormire. Gli chiedi: «Odkuda vy? Da dove venite?».
QUELLI INDICANO un punto indefinito, oltre il curvone in fondo alla strada: «Severodonetsk», dicono. Poi tornano ad abbassare la testa. Abbiamo trascorso una mattinata per le strade di Lyshichansk, l’ultima città sotto controllo ucraino a ovest del Severskij Donec.
Severodonetsk – «la nuova Mariupol», come l’hanno ribattezzata i giornali – è per l’appunto laggiù, dall’altra parte del fiume. Il ponte che collegava i due centri abitati è stato abbattuto nella notte tra giovedì e venerdì e da allora l’ormai ex capitale dell’oblast’ di Lugansk è isolata dal resto del Paese.
Avremmo voluto raggiungere le macerie del ponte, ma i soldati non ce l’hanno permesso – è troppo pericoloso, dicono, i russi sono appostati sull’altra sponda e sparano in continuazione. Lungo il curvone accanto a noi sfilavano piccoli convogli di camion e carri armati.
Cosa esattamente stia accadendo a Severodonetsk in fondo non lo sa nessuno. Le fonti russe hanno annunciato la «liberazione» di due terzi del tessuto urbano, condendo il proclama con un poco rassicurante monito nei confronti dei combattenti di Kiev: «Chi non si arrende verrà liquidato».
DAL CANTO LORO, gli ucraini sostengono di aver scatenato una serie di controffensive vittoriose, costringendo il nemico a una parziale ritirata.
Dalla collina di Lyshichansk – che dall’alto domina la città gemella – tutto ciò che abbiamo potuto vedere sono state le nuvole di fumo degli edifici in fiamme e i continui lampi delle esplosioni.
Prima della guerra a Severodonetsk vivevano circa 110mila persone, nove decimi delle quali sono riuscite a mettersi in salvo alla vigilia della tempesta. Chi è rimasto vive sepolto nei bunker e nelle cantine, in attesa di un’alba che oggi più che mai sembra lontana. Anche a Lyshichansk il clima è plumbeo.
Qui i russi non sono ancora arrivati – per farlo dovranno riuscire nell’ardua impresa di guadare il Severskij Donec, finora hanno sempre fallito. Tuttavia, sono vicinissimi, una vicinanza più che mai tangibile.
IMMAGINATE due schieramenti d’artiglieria posizionati l’uno di fronte all’altro, e di trovarvi nel mezzo. Questa è la situazione di Lyshichansk. Quando vai in guerra, impari a riconoscere il fischio acuto dei proiettili in arrivo.
È un suono raggelante, e quando giungi a sentirlo vuol dire che hai pochi secondi per gettarti al riparo in attesa dell’esplosione. In questa cittadina arroccata sulle alture – 95mila abitanti prima del 24 febbraio – quel suono è diventato parte della vita quotidiana.
Non sempre le bombe scoppiano tra le case, il più delle volte si limitano a volarci sopra, per poi schiantarsi una manciata di chilometri più a est, se provengono dai cannoni ucraini, o verso ovest, se esplose dai russi.
L’effetto è lancinante, è come trovarsi puntato in faccia un kalashnikov ogni volta che si gira l’angolo della strada. Ma la gente qui sembra essersi abituata anche a questo.
Abbiamo visto uomini e donne camminare tranquillamente sul marciapiedi mentre missili e Grad fischiavano sopra loro teste. Una donna, palesemente ubriaca, è passata saltellando vicino alla nostra macchina. Rideva da sola, in preda a chissà che pensieri.
NEL CORTILE di un condominio un ragazzino ci ha inseguito per mezz’ora chiedendo inutilmente una sigaretta. «U nas net sigaret», gli ripetevamo noi. Ma lui sembrava non capire e continuava a venirci dietro trascinando i piedi, con un ghigno vuoto dipinto sul volto. È questo l’effetto di tre mesi di bombe?
A Lyshichansk non c’è più luce né gas né acqua corrente. La gente ha smesso di lavarsi; si cucina all’aperto, direttamente sul fuoco dei falò. Gli aiuti umanitari? In pochi li hanno visti. In giro vedi solo volti smagriti, con la postura da zombie e gli sguardi persi nel nulla.
PROPRIO nel punto più alto della città, di fronte alla conca fumante di Severodonetsk, sorge un grande palazzo di otto piani. Abbiamo scalato a piedi tutte e sedici le rampe di scale, fino a raggiungere gli appartamenti del sottotetto. Qui, tra porte sfondate e vetri in frantumi, ci siamo imbattuti in una vecchina piccola e secca, con un fazzoletto a righe stretto sotto il mento.
«Gdié vasha doma?», le abbiamo chiesto. Ci ha risposto che la sua casa è proprio lì, all’ottavo piano, e che lì – nonostante tutto – lei continua a vivere e dormire.
«Nié bunker?», abbiamo insistito. Lei ha fatto un gesto scherzoso con la mano, come a scacciare un pensiero buffo e senza senso. «Eta maià doma», ha ripetuto un paio di volte: questa è casa mia. Così si vive, sotto le bombe, nella città di Lyshichansk.