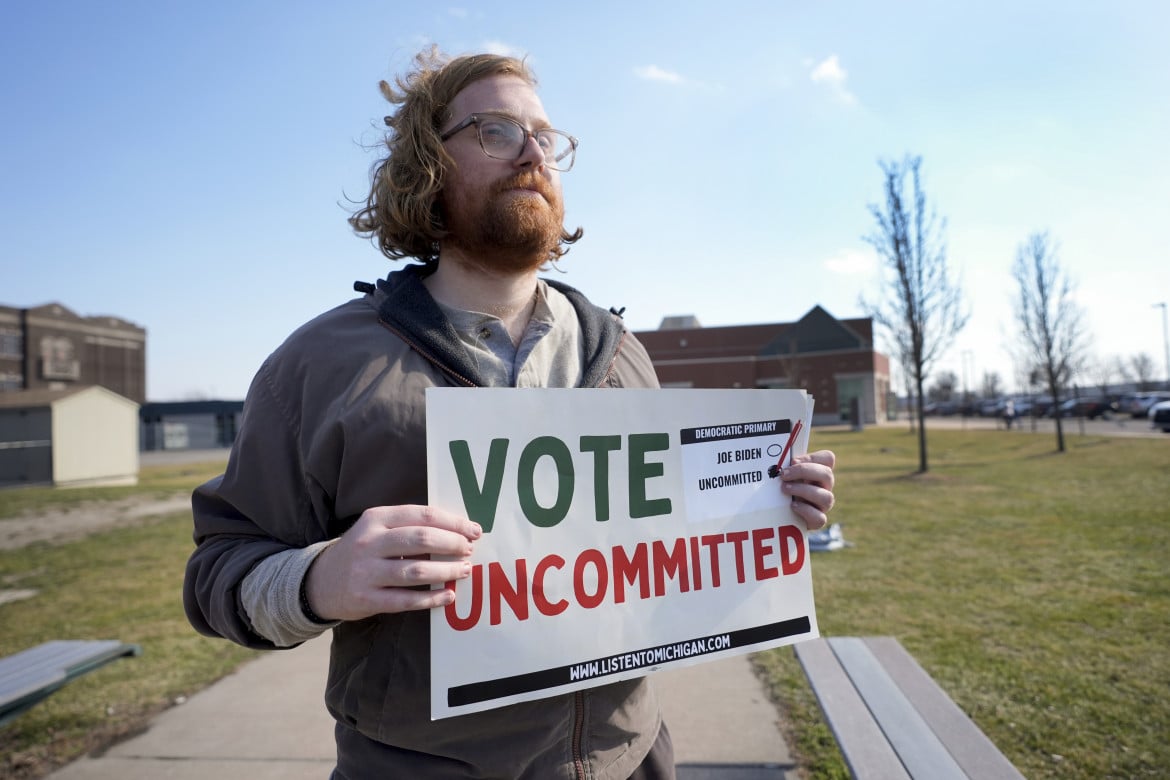Con la sua sparata sulla chiusura ad oltranza dei confini americani a tutti i musulmani, Donald Trump deve essersi voluto ravvedere delle critiche al discorso di Obama parse forse in retrospettiva eccessivamente tiepide. Forse alcuni sondaggi che davano in rimonta Ted Cruz in Iowa sono entrati nel calcolo. Forse non è voluto sembrare da meno di quegli ex-socialisti al di la dell’Atlantico che in Francia hanno organizzato un tea party alla francese.
Così Trump ha alzato il tiro. Altro che melting pot e tolleranza buonista obamiana: Stop preventivo a tutti i musulmani in arrivo, immigrant e turisti di Disneyland, “fino a quando i rappresentanti del paese (sic, ndr) non riescano a capire cosa diavolo stia succedendo”. “Non c’è scelta” dice Trump perché “l’odio dei musulmani va oltre la comprensione”.
E non sono parole al vento.
Come Joseph McCarthy che aveva la sua lista di comunisti sempre in tasca, Trump ha i numeri alla mano: quelli di un presunta inchiesta del Center for Security Policy – un “think tank” filo sionista di Washington fondato da Frank Gaffney, un complottista a suo tempo espulso dall’ammiistrazione Reagan per idee eccessivamente estreme. Il Gaffney che accusò Saddam Hussein dell’attentato di Oklahoma City e chiese il bombardamento degli studios di Al Jazeera, sostiene che il 25% dei musulmani residenti in Usa facciano parte di una congiura jihadista pilotata dai Fratelli musulmani. Malgrado sia stato sconfessato perfino da Newt Gingrich e Donald Rumsfled, o forse proprio per questo, da Trump le sue statistiche hanno ricevuto l’investitura di sacra verità.
Mai uno disposto a lasciarsi intralciare dai fatti, il candidato usa semplicemente ripetere in pubblico storie, dati e numeri e dichiararli veri. Per alcuni giorni il suo aneddoto preferito è stato quello sui “musulmani che dal litorale del New Jersey festeggiavano la caduta delle torri gemelle”. Le smentite di autorità locali, politici e polizia non lo hanno minimamente preoccupato e anzi forse hanno rafforzato nei suoi supporter il dubbio di una congiura del silenzio – l’assioma impenetrabile del complottismo.
Non importa insomma quanto grosse siano le sparate, ognuna garantisce comunque che a riguardo vengano scritti migliaia di articoli come questo, e che gli indici di gradimento continuino a salire per l’ormai sconcertata costernazione dei suoi concorrenti repubblicani. Per il candidato che ha cominciato la campagna denunciando i “violentatori messicani”, che ha espulso i giornalisti della ispanica Univision da un suo comizio e giustificato il pestaggio di un esponente di Black Lives Matter in un altro, i fatti di Parigi e ora San Bernardino sono stati un regalo del cielo.
E ora, dopo “la splendida muraglia sul confine messicano” è giunta l’ora del sigillo antimusulmano al confine.
Ma Trump va oltre la xenofobia d’ordinanza e il populismo strumentale dei “professionisti”. È un soggetto post-ideologico incontrollabile, capace di incorporare frammentariamente narrazioni fascistoidi, berlusoniane patriottarde ed eccezionaliste – tutte comunque sempre riconducibili al culto di Trump.
Capace di lanciare bombe incendiarie come quella di ieri e passare oltre lasciando corsivisti ed avversari ad accapigliarsi nello scompiglio.
La guerra unilaterale dichiarata all’Islam dal padrone del Trump international golf club e condomini di lusso a Dubai, è stata finora la più efficace. E lo scompiglio riguarda specialmente i suoi tredici concorrenti per la nomination repubblicana.
Con l’ultima uscita il “Trump problem” di cui gli strateghi repubblicani brontolano da mesi, è ormai ineluttabile.
Bush, Rubio, Carson e gli altri che fin’ora hanno cercato perlopiù di evitare il vortice di kryptonite che emana dal megalomane miliardario, ieri si sono trovati nell’inconsueta posizione di rappresentare indignazione per l’insostenibile scorrettezza.
“Trump è demente” ha twittato Jeb Bush, secondo Carly Fiorina si è trattato di un “eccesso pericoloso”, “schediamo e controlliamo” ma non solo i musulmani ha offerto un Ben Carson più disposto alla pari opportunità.
Perfino iI mefistofelico decano Dick Cheney ha invitato a moderare i termini. Una esibizione patetica da parte di quelli che fino a ieri gareggiavano a far vedere a tutti il pugno di ferro che proponevano di sostituire al guanto di velluto dell’infingardo Obama.
La verità vera, e la narrazione ormai prevalente di questa campagna, è che Trump è il frutto avvelenato dei semi così entusiasticamente piantati dagli strateghi del partito di Lincoln, figlio deforme delle campagne improntate alla paura e ai tamburi di guerra – quelle di Cruz, Rubio, Lindsey Graham e Chris Christie – manovrate per raccogliere i voti della psicosi, per aizzare lo zoccolo duro che lusingato e strumentalmente attivato e sdoganato ha finito per impadronirsi dell’anima stessa dei repubblicani.
Il mostro da prima pagina che imperversa sui giornali e in cima ai sondaggi, minaccia innanzitutto l’intero l’establishment repubblicano con una insurrezione populista.
“Quello che inizialmente era parso il numero di un comico inacidito – ha scritto Arianna Huffington – si è rappreso in qualcosa di repellente e sinistro”.
Il mostro scatenato è fuggito dalla gabbia. Non sarà facile rimettercelo.