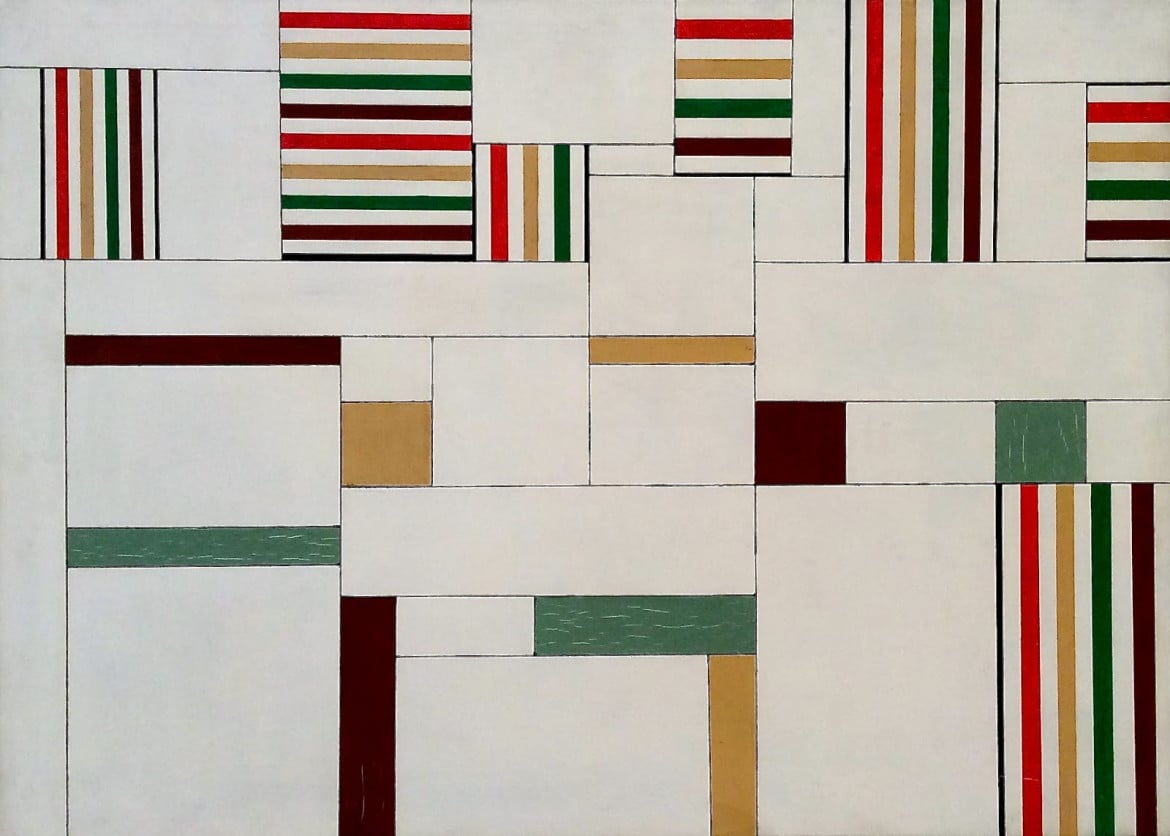C’è uno spassoso trattato, incluso in Storia dell’eternità, nel quale Jorge Luis Borges compie una sorta di carrellata delle storiche traduzioni sette-ottocentesche delle Mille e una notte. Le versioni che, secondo Borges, si rivolgevano a quei lettori ancora disposti a crogiolarsi nel magico e nel meraviglioso si distinguono dalle altre, rivolte a chi si stupiva che qualcuno potesse ancora crederci. Esiste tuttavia un terzo potenziale lettore del grande testo orientale, al quale si rivolge oggi Kader Abdolah, tornato in libreria con Il sentiero delle babbucce gialle (traduzione di Elisabetta Svaluto Moreolo, Iperborea, pp. 416, € 19,50): iraniano di nascita, intellettuale inviso agli ayatollah, a partire dagli anni Ottanta Abdolah si è stabilito nei Paesi Bassi e ha trovato nella lingua olandese un porto remoto ma accogliente nel quale custodire la sua formazione culturale.
La sua opera rappresenta, in qualche modo, una anomala, inarrestabile traduzione della letteratura persiana, dove i motivi fiabeschi della novellistica anonima e dei poemi medievali si intrecciano ai rivolgimenti della storia dell’Iran. I piani, anzi, sono ancora più sfumati: l’americanizzazione voluta dallo scià, l’avvento di Khomeini, la politica tutta, sono filtrati da un occhio antico, che cambia i connotati degli eventi, mostrandoli come episodi di una saga iniziata secoli, millenni addietro.
Lo sguardo da lontano si avverte in ogni libro di Abdolah, che sin dal suo romanzo di maggior successo, La casa della moschea, ha avviato una sorta di narrazione della diaspora, facendo i conti con la concretezza del presente mediante l’evocazione di città appisolate nel sogno e scosse da incubi, e dando voce a vecchi imam, nonne chiaroveggenti e nipoti senza chador, uccelli di buona coscienza e spiriti suggeritori.
Pieno di azione, struggente, Il sentiero delle babbucce gialle è scritto in un limpido olandese, che lascia comunque intravedere fra le sue maglie la stessa fonte alla quale attingeva Sherazade: a raccontarlo in prima persona è Sultan Farahangi, personaggio ispirato al poeta Said Sultanpur, condannato a morte dagli ayatollah.
È dunque una autobiografia contraffatta, mitologica, scandita in modo da ricordare proprio le Mille e una notte fatta di aneddoti concatenati, con una melodia in comune, che li rende simili a variazioni su un canovaccio. Figlio di ricchi commercianti di zafferano, cresciuto nel castello di famiglia, il protagonista diventa il più illustre regista del suo tempo. Un giorno lo convocano i partigiani, pronti a rovesciare lo scià; in questa disputa fra eroi – una fase appassionante ma «cupa», «mortifera» – il pericolo della prigionia e della morte non è che un abbaglio, oltre il quale si è già aperto un sentiero. La rivoluzione è un processo naturale: «In macchina pensai a un gatha, ovvero a un verso dell’Avesta, il libro sacro di Zarathustra che un tempo mio nonno leggeva tutte le mattine. Conoscevo a memoria quel condensato di saggezza: “Ciascuno percorre la strada che è stata posta ai suoi piedi”».