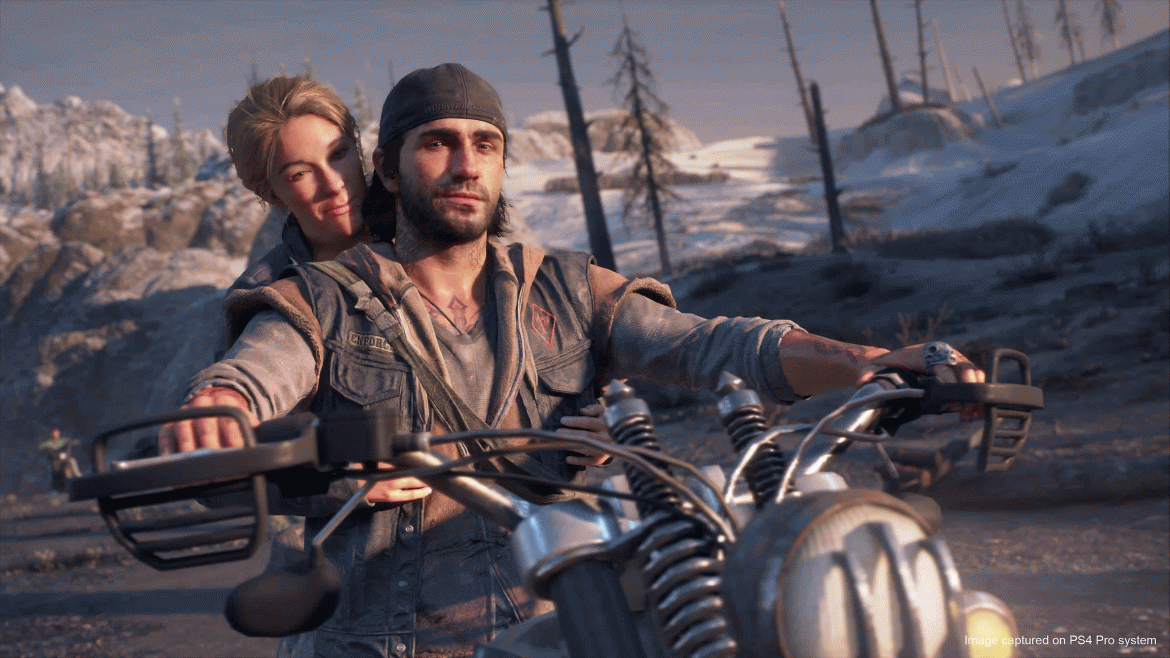In Days Gone tutto ciò che è finisce, o forse no perché la natura indifferente alle sofferenze dell’uomo che si estingue continua a vivere maestosa e crudele e in essa l’umanità nuova, gli infetti, branchi di mostri che sciamano per i boschi e i monti come le antiche bestie di una preistoria horror. Se in Io sono Leggenda Richard Matheson ci racconta la morte della metropoli come inizio di un nuovo mondo, in Days Gone invece la fine dell’umana società coincide con il trionfo della natura, attraverso la quale ci muoviamo come alieni nel corpo del protagonista motorizzato, tanto che il rombare della sua motocicletta risulta più estraneo, sbagliato, nel “naturlaut” dell’Oregon silvestre del videogame di Sony Bend Studio, dei lamenti affamati e dolenti degli infetti.
“Il romanzo di Matheson, che amo molto, per la sua scrittura e i suoi straordinari colpi di scena, ci ha senza dubbio inspirato”, ci dice John Garvin, direttore creativo di Days Gone, “ tuttavia una fondamentale fonte di ispirazione è stato The Road di Cormac McCarthy, perché è la storia di un padre e di un figlio che devono sopravvivere in un mondo orrendamente degenerato e sebbene si possa essere affascinati dalla tragedia che la storia racconta e coinvolti da tutti gli eventi terrificanti che capitano ai personaggi, tra tanto orrore la speranza comunque non esaurisce, c’è al contrario una tensione verso una vita migliore”.
Eppure questa tensione è quella dei rari umani esausti, incattiviti e bestiali che si struggono nel desiderio frustrato di un passato perduto o si beano di un nuova, meschina autorità o quella degli pseudo-zombie, che si dimostrano in grado di provare dolore, addirittura di temere la propria morte?
Perché oltre l’egoistica volontà di continuare ad esistere del protagonista il messaggio più importante del gioco secondo John Garvin, ovvero “che sopravvivere non è vivere ma bisogna avere un obbiettivo più grande, bisogna cercare l’amore, bisogna avere uno scopo nella propria esistenza che non sia solo quello di cercare il prossimo pasto”, ce lo comunicano proprio i cenciosi infetti che arrancano salmodianti in una perenne ricerca di qualcosa che non può essere solo il nutrimento. Come quelle di una nuova massa ai vecchi padroni le ragioni degli infetti sfuggono; l’umano obsoleto non le comprende, nel modo in cui la lingua nascente dell’Homo Sapiens dovette risultare estranea al soccombente Homo di Neanderthal.
Talvolta quando il rombare della moto tace, quando camminiamo a piedi per la selva, comprendiamo le ragioni del protagonista e il suo amoroso struggimento che condividiamo con empatia; tuttavia la sua connessione con il giocatore è forte proprio perché instaura una dialettica della nostalgia, il doloroso anelito verso la qualcosa che se anche ritrovato è comunque inevitabilmente perduto, andato, come i giorni trascorsi. “Amo questo titolo perché ha molteplici significati” continua John Garvin, “ Days Gone può significare la fine del giorno, quindi il crepuscolo, e nel nostro videogame la notte è per diverse ragioni più pericolosa del giorno. Inoltre può significare il numero di giorni trascorsi da quando è accaduto un evento, oppure può essere inteso come la conclusione di un’era, in questo caso la fine della civiltà. Possiamo quindi intendere il titolo come una somma di questi significati e in esso c’è un doloroso senso di perdita, Days Gone By, inteso come i bei tempi andati, perché ora è tutto peggio”.
Days Gone è un videogioco traballante sotto il peso delle sua bellezza e bruttezza, grandioso proprio per questo squilibrio parzialmente incompreso e per il suo farraginoso andamento, che squalifica e insieme esalta un romanticismo sfiancato, appassito ma lirico, volgare, retorico e bello come la rara ballata di una band punk. Days Gone è anche un gioco sull’incomunicabilità tra opera e critica contemporanea, che in questo caso disseziona un solenne, orribile cadavere con gli strumenti sbagliati, troppo raffinati quando dovrebbero essere barbari e viceversa.
“